(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 513-bis)
Il fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Noia che condannava gli imputati alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ritenendoli responsabili dei delitti, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 513-bis cod. pen. (capo 1) e 110, 582, 585, comma 1 ultima parte, 576, n. 1, cod. pen. (capo 2).
Ai predetti imputati, in particolare, era stato contestato di aver compiuto, in concorso fra loro, atti di illecita concorrenza con minaccia e violenza e nel cagionare, colpendolo con calci e pugni, lesioni giudicate guaribili in tre giorni, un dipendente di una ditta individuale il quale effettuava lavori di spurgo nel medesimo ambito territoriale ove gli imputati, operanti nel medesimo settore, rivendicavano l’esclusiva.
Volume consigliato
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso la decisione della Corte di appello aveva proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo i seguenti motivi: 1) violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all’omessa valutazione delle risultanze offerte dalle dichiarazioni di un testimone addotto dalla difesa nonché alla ritenuta credibilità delle deposizioni rese dalla persona offesa e da un altro testimone escusso in dibattimento evidenziandosi al riguardo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la deposizione resa dal teste che aveva fornito una versione dell’accaduto radicalmente diversa da quella riferita dalla persona offesa accreditando la ricostruzione del fatto operata dagli imputati mentre, sotto altro profilo, poi, le dichiarazioni rese dall’altro teste, genero della persona offesa, risulterebbero essere state caratterizzate da incoerenza e inverosimiglianza non avendo saputo indicare il nome del titolare della ditta che gli aveva commissionato il lavoro da piastrellista che stava effettuando nei pressi del /ocus commissi delicti, né dove fosse ubicato l’appartamento oggetto di tali lavori; si soggiungeva, infine, che, in fase di indagini, il Pubblico Ministero avrebbe cercato di acquisire elementi di riscontro in ordine alla presenza in loco del Castaldo il cui datore di lavoro, tuttavia, sebbene più volte sollecitato a confermare tale circostanza di fatto, avrebbe rifiutato di rendere dichiarazioni al riguardo; 2) analoghi vizi (rispetto a quelli prospettati nel primo motivo) in relazione alla configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. muovendosi dall’assunto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la fattispecie in esame in quanto il suo ambito di operatività sarebbe stato ristretto solo a condotte tipicamente concorrenziali (come il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare) poste in essere attraverso atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale con esclusione, pertanto, degli atti intimidatori finalizzati a contrastare od ostacolare l’altrui libera concorrenza dato che, diversamente da quanto ritenuto nelle decisioni di merito, l’ipotesi di reato in esame, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha superato un diverso e risalente indirizzo interpretativo cui si era ispirata la sentenza impugnata, non sarebbe applicabile ad atti, come quelli in contestazione, di violenza e minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza è solo la mira teleologica dell’agente, né dalle pronunzie di merito sarebbe emersa, peraltro, la descrizione dell’atto concorrenziale tipico nel quale si sarebbe concretata la condotta delittuosa degli imputati.
In via subordinata nel ricorso si chiedeva infine che la questione venisse rimessa al vaglio delle Sezioni Unite.
La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione
Con ordinanza n. 26870 del 19 aprile 2019 la Terza Sezione penale rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite prospettando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale.
Rilevava al riguardo la Sezione rimettente che, secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, ritenuto maggiormente aderente alla lettera della norma, l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. consiste nella repressione delle sole condotte illecite tipicamente concorrenziali e competitive (quali il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.) che vengano realizzate con atti di violenza o minaccia tali da inibire la normale dinamica imprenditoriale non rientrando invece nella fattispecie astratta, quelle condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o contrastare l’altrui libera concorrenza che si pongano, però, al di fuori’ dell’attività concorrenziale — quali, ad es., i casi di diretta aggressione ai beni dell’imprenditore concorrente ovvero alla sua persona – ferma restando l’applicabilità, in tali situazioni, di altre fattispecie di reato.
Secondo tale orientamento, la ratio della norma va individuata nella tutela della libera concorrenza sicchè, ai fini dell’integrazione del reato, si ritengono “atti di concorrenza” soltanto quelle condotte concorrenziali ritenute illecite da un punto di vista civilistico realizzate con metodi di coartazione volti ad ostacolare la normale dinamica imprenditoriale.
Un diverso orientamento interpretativo, di contro, ritiene che il delitto in esame sia configurabile ogni qualvolta si realizzi un comportamento che, attraverso l’uso strumentale della violenza o della minaccia, sia idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell’esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva ed, entro tale prospettiva, sono qualificabili come atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti, “attivi” o “impeditivi” dell’altrui concorrenza, che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il mercato e a consentirgli di acquisire, in danno dell’imprenditore minacciato, illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa.
Siffatta diversa opzione ermeneutica, osservava la Sezione rimettente, trova il suo fondamento sia nella volontà del legislatore che ha inteso reprimere, con la introduzione della norma incriminatrice de qua, forme di intimidazione volte a controllare e/o a condizionare le attività commerciali e produttive nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, sia nella norma extrapenale di cui all’art. 2598 cod. civ. che se, da una parte, prevede ai numeri 1) e 2) casi tipici di concorrenza sleale parassitaria ovvero attiva, dall’altra contempla, al numero 3), una norma di chiusura secondo la quale sono atti di concorrenza sleale tutti i comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda.
Tal che se ne faceva conseguire che rientrano nella fattispecie in esame, non solo le condotte tipicamente concorrenziali, ma anche tutti quegli atti intimidatori che siano finalizzati a contrastare o ad ostacolare l’altrui libertà di concorrenza.
Il Presidente aggiunto, dal canto suo, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite e ne disponeva la trattazione all’odierna udienza pubblica.
Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite
La questione di diritto per la quale il ricorso era stato rimesso alle Sezioni Unite veniva da queste Sezioni riassunto nei seguenti termini: «se, ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, sia necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, sia sufficiente anche il solo compimento di atti di violenza o minaccia comunque idonei a contrastare od ostacolare l’altrui libertà di concorrenza».
Premesso ciò, gli Ermellini rilevavano come, sull’ambito di applicazione del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza previsto dall’art. 513-bis cod. pen. e, in particolare, sulla interpretazione della nozione di “atti di concorrenza” che costituisce l’asse attorno al quale ruota l’intera fattispecie incriminatrice, si registrino tre diversi orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo indirizzo interpretativo il dato testuale della fattispecie prevista dall’art. 513-bis cod. pen. ricomprende solo i comportamenti competitivi tipici che si prestino ad essere realizzati con mezzi vessatori ossia con violenza o minaccia nei confronti di altri soggetti economici tendenzialmente operanti nello stesso settore (Sez. 3, n. 46756 del 03/11/2005; Sez. 2, n. 35611 del 27/06/2007; Sez. 3, n. 16195 del 06/03/2013).
In particolare, pur non limitata alle condotte poste in essere da appartenenti ad associazioni criminali, la norma incriminatrice viene ritenuta inapplicabile agli atti di violenza o minaccia non sostanziatisi in condotte illecite tipicamente concorrenziali quand’anche la finalità perseguita dall’agente si identifichi con la limitazione della libertà di concorrenza (Sez. 2, n. 35611 del 27/06/2007; Sez. 1, n. 6541 del 02/02/20:12; Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015; Sez. 2, n. 49365 del 08/11/2016; Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016) ivi rientrandoti solo comportamenti quali, ad esempio, il boicottaggio, lo storno di dipendenti ed il rifiuto di contrattare (Sez. 3, n. 46756 del 03/11/2005; Sez. 2, n. 29009 del 27/05/2014; Sez. 2, n. 9763 del 10/02/2015; Sez. 3, n. 16195 del 06/03/2013).
Entro tale prospettiva, dunque, il reato non è riferibile anche a colui che nell’esercizio di un’attività imprenditoriale compie atti intimidatori al fine di contrastare o scoraggiare l’altrui libera concorrenza atteso che la disposizione in questione, introdotta dall’art. 8 della legge 13 settembre 1982, n. 646 mira a reprimere la concorrenza illecita che si concretizza in forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata, a sua volta orientata a controllare, con metodi violenti o mafiosi, le attività commerciali, industriali e più genericamente produttive (Sez. 3, n. 46756 del 03/11/2005 che a sua volta richiama in motivazione quanto già affermato da Sez. 6, n. 3492 del 09/01/1989 secondo cui la norma tende ad impedire quei comportamenti intimidatori che, attraverso l’uso strumentale della violenza e della minaccia, incidono su quella fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza “non solo libera, ma anche lecitamente attuata“).
Coerente con tale ricostruzione è l’affermazione secondo cui le condotte commesse con atti di violenza e minaccia in relazione ai quali la limitazione della concorrenza costituisce solo la mira teleologica dell’agente devono propriamente ricondursi ad altre fattispecie di reato (come, ad es., il delitto di cui all’art. 629 cod. pen.) mentre la norma in esame, di contro, mira a sanzionare solo la commissione di atti di concorrenza che si pongono “oltre i limiti legali” inibendo la normale dinamica imprenditoriale con una conseguente turbativa del libero mercato in un “clima di intimidazione e con metodi violenti“.
Pertanto, secondo tale orientamento, non può accogliersi, in altri termini, l’interpretazione che tende a ritenere integrato il tipo di reato nel caso di violenza o minaccia finalisticamente connotata dall’intenzione di scoraggiare l’altrui concorrenza (così incidendo sull’elemento soggettivo della fattispecie) poiché questa opzione ermeneutica non può essere considerata conforme al dato testuale e pone, al contempo, inevitabili problemi di violazione del principio di tassatività a fronte di un enunciato normativo la cui formulazione intende invece isolare, dalla generalità degli atti violenti, gli specifici atti di concorrenza, pur commessi con quella particolare modalità.
Un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, interpreta la norma descritta nell’art. 513-bis cit. in senso ampio non limitato alle indicazioni desumibili dalle pertinenti disposizioni del codice civile come se la condotta s’incentrasse sulla violenza o minaccia posta in essere con il dolo specifico di inibire la concorrenza (Sez. 3, n. 44169 del 22/10/2008; Sez. 1, n. 9750 del 03/02/2010; Sez. 2, n. 6462 del 16/12/2010; Sez. 2, n. 9513 del 18/01/2018).
Nel dettaglio, nel richiamare la ratio giustificativa della previsione della fattispecie incriminatrice, siffatto indirizzo interpretativo mira a tutelare nella sua massima potenzialità espansiva il contenuto del bene protetto evidenziando come l’ambito di applicazione non possa ritenersi limitato al campo della criminalità organizzata poiché ciò che rileva, non è tanto la commissione di tipici atti di concorrenza, quanto la realizzazione di una serie di attività violente e minacciose che, proprio per le loro caratteristiche di fatto, configurano una concorrenza illecita e tendono a controllare le attività commerciali, o comunque a condizionarne il libero esercizio (Sez. 3, n. 450 del 15/02/1995; Sez. 2, n. 13691 del 15/03/2005; Sez. 6, n. 24741 del 05/05/2015; in motivazione v., inoltre, Sez. 1, n. 19713 del 22/02/2005) sottolineandosi, in tal senso, che il riferimento alle condotte tipiche della criminalità organizzata non intende affatto «dimensionare l’ambito di applicabilità della norma (restringendolo alle sole operazioni di criminalità organizzata) ma solo caratterizzare i comportamenti punibili con il ricorso a un significativo parallelismo».
Secondo tale impostazione, posto che il bene giuridico tutelato consiste non solo nel buon funzionamento dell’intero sistema economico ma anche nella libertà della persona di autodeterminarsi nell’esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva, l’atto di concorrenza illecita ex art. 513-bis cit. è configurabile in qualsiasi comportamento violento o intimidatorio che sia idoneo ad impedire al concorrente di avvalersi della sua libertà d’impresa.
Siffatta linea interpretativa, dunque, si esprime in senso favorevole ad un’applicazione quanto più generalizzata della norma proiettata non solo al di fuori del contesto proprio della criminalità organizzata ma anche verso una prospettiva di tutela nei confronti di eventuali atti di concorrenza sleale “atipici” e, comunque, non limitati all’area di incidenza della disciplina civilistica della concorrenza sleale emergente dagli artt. 2595 ss. cod. civ..
Si tende, all’interno di tale impostazione ricostruttiva, a valorizzare il concetto di “atti impeditivi” della concorrenza quale connotazione della condotta che tiene conto del contesto nel quale normalmente anche se, non necessariamente, maturano i comportamenti oggetto della previsione normativa e così accogliendo la volontà del legislatore di sanzionare quelle condotte poste in essere in ambienti o settori caratterizzati dalla presenza esplicita di associazioni a delinquere di stampo mafioso ovvero dalla contiguità ad esse dei soggetti attivi seppur esercenti un’attività di natura imprenditoriale.
Pur non potendosi qualificare propriamente come “atto di concorrenza” un banale litigio tra venditori ambulanti, alla stregua di questo approdo ermeneutico, si ritiene comunque necessario accedere ad un “significato ampio” di tale nozione in modo da includervi sia quelle condotte dirette a distruggere direttamente l’attività del concorrente, sia quelle finalizzate ad evitare che possa essere esercitato un atto di concorrenza lecita (come, ad esempio, il ribasso dei prezzi) così da sanzionare tutti quegli atti volti a rimuovere le condizioni che rendono possibile la stessa capacità di autodeterminazione dei soggetti economici.
Dalla linea ermeneutica tracciata dal secondo orientamento prendeva inoltre le mosse, progressivamente sedimentandosi nel tempo, un terzo indirizzo interpretativo essenzialmente finalizzato a valorizzare le prospettive di una meno restrittiva e più completa definizione del concetto di “atti di concorrenza” attraverso il riferimento non solo alla ratio della norma incriminatrice ma anche alla necessità di integrarne il precetto alla luce della normativa italiana ed europea in tema di tutela della concorrenza.
Nel tentativo di superare la contrapposizione fra i due orientamenti dianzi illustrati, la più recente elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015,; Sez. 3, n. 3868 del 10/12/2015, dep. 2016; Sez. 2, n. 18122 del 13/04/2016) ha affermato che la condotta materiale del delitto previsto dall’art. 513-bis cod. pen. può essere integrata da tutti gli atti di concorrenza sleale previsti dall’art. 2598 cod. civ. fra i quali rientrano quelli diretti non solo a distruggere l’attività del concorrente ma anche ad impedire che possa essere esercitato un atto di libera concorrenza come quello della ricerca di acquisizione di nuove fette di mercato precisandosi al contempo che tale disposizione del codice civile, da interpretarsi alla luce della normativa comunitaria e della legge 10 ottobre 1990, n. 287, prevede ai numeri 1) e 2) i casi tipici di concorrenza sleale parassitaria ovvero attiva mentre al n. 3) contiene una norma di chiusura secondo cui sono atti di concorrenza sleale tutti i comportamenti contrari ai princìpi della correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda.
Nel richiamare, al riguardo, gli approdi cui è pervenuta l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione nel settore civile (Sez. 1 civ., n. 14394 del 10/08/2012; Sez. 1 civ., n. 25652 del 4/12/2014), si sottolinea che la condotta violenta o minacciosa deve essere valutata coerentemente con il su indicato quadro normativo muovendosi dall’assunto che il cercare di impedire l’attività di un imprenditore nella sua opera di promozione e proposizione sul mercato della propria attività commerciale o imprenditoriale costituisce un comportamento certamente contrario alla correttezza professionale, idoneo a danneggiare l’altrui azienda, perché “teso ad ostacolare la libera e lecita concorrenza della parte offesa, nell’acquisizione di una fetta di mercato del settore ove operano anche altre imprese”.
Per le medesime ragioni si afferma che tale condotta deve al contempo ritenersi lesiva del principio della libera concorrenza intesa come concorrenza effettiva tra imprese che liberamente competono sul mercato nella più ampia prospettiva risultante dall’analisi dell’intero quadro normativo comunitario (ex artt. 101, 102, 120 TFUE, 16 CDFUE), i cui principi, in considerazione della prevalenza riconosciuta sulle relative norme interne ex artt. 11 e 117 Cost., si impongono anche nell’interpretazione della disposizione di cui all’art. 2598 cod. civ.
Assumono in tal modo rilievo sia quei comportamenti che, commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, risultano “idonei a falsare il mercato” e a consentire l’acquisizione, in danno dell’imprenditore minacciato, di illegittime posizioni di vantaggio senza alcun merito derivante dalla propria capacità operativa (come nel caso tipico dell’intimidazione esercitata da parte di un imprenditore nei confronti di un altro, rispetto a lavori appaltati ma rivendicati come propri), sia le condotte contrarie ai principi della correttezza professionale intese come “qualunque comportamento violento o minatorio” posto in essere nell’esercizio dell’attività imprenditoriale al fine di acquisire una posizione dominante sul mercato non correlata alla capacità operativa dell’impresa (Sez. 6, n. 38551 del 05/06/2018; Sez. 2, n. 30406 del 19/06/2018) o comunque diretto ad alterare l’ordinario e libero rapportarsi degli operatori in una economia di mercato (Sez. 6, n. 50094 del 12/07/2018; Sez. 6, n. 50084 del 12/07/2018) fermo restando che, a sostegno di tale ricostruzione ermeneutica, si rimarca, in definitiva, il fatto che, sebbene il legislatore abbia svincolato la costruzione della fattispecie dalla necessità di una diretta connessione con il contesto specifico della criminalità organizzata, lo scopo della disposizione è quello di arginare la pericolosità di quelle condotte anticoncorrenziali comunque realizzate con comportamenti violenti o minatori.
Conclusa la disamina di questi orientamenti nomofilattici, le Sezioni Unite osservavano come l’origine del contrasto giurisprudenziale andasse ricercata nella ambiguità della formulazione del testo dell’art. 513-bis cod. pen. la cui introduzione risale alla legge 13 dicembre 1982, n. 646 (cd. Rognoni-La Torre) recante disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale per la volontà, dettata dall’urgenza della particolare temperie storico-politica in cui la figura criminosa ha trovato la sua genesi, di far fronte ad «un comportamento tipico mafioso che è quello di scoraggiare con l’esplosione di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza» (così si esprimeva la Relazione illustrativa della proposta di legge n. 1581 presentata alla Camera dei deputati il 31 marzo 1980, in Atti parlamentari, VIII Legislatura).
La volontà parlamentare, dunque, appariva orientata a contrastare e reprimere lo svolgimento di tutte quelle attività di impresa gestite, anche indirettamente, da associazioni di stampo mafioso o comunque ad esse riferibili, nel porre in essere condotte intimidatorie in danno di imprese operanti in settori affini o nella medesima realtà territoriale con il palese obiettivo di acquisire indebite posizioni di preminenza posto che l’espansione delle forme di compenetrazione fra organizzazioni criminali e settori dell’imprenditoria era crescente sicchè l’esigenza di una sua limitazione sembrava imprescindibile dall’apprestamento di nuovi e specifici strumenti di tutela attraverso la previsione di una fattispecie ad hoc finalizzata a colmare la lacuna normativa esistente tra il delitto di estorsione e la contigua fattispecie di turbata libertà dell’industria o del commercio.
In tal senso, rispetto al delitto di cui all’art. 629 cod. pen., la dottrina aveva osservato, da un lato, che l’offesa era in tal caso diretta sostanzialmente verso il patrimonio dei singoli (e, naturalmente, verso la persona), dall’altro lato, che, ai fini della configurabilità del reato, restava comunque necessaria la prova dell’ingiusto profitto con l’altrui danno.
Per quel che attiene invece al rapporto con la contigua figura criminosa prevista dall’art. 513 cod. pen., si era posto in evidenza che, sebbene tale norma tuteli la libertà dell’iniziativa economica nel settore delle attività produttive, il compimento di atti di violenza ivi previsto assumeva rilievo sul piano penale solo in quanto diretto, in modo esclusivo, verso le cose.
Ora, sebbene la proiezione storico-politica della norma introdotta con l’art. 513-bis rifletta l’intento, generalmente avvertito, di fronteggiare l’emergenza legata ad un contesto socio-economico caratterizzato dalla crescente incidenza di fenomeni criminali legati alle attività della cd. “mafia imprenditrice“, è agevole rilevare come la struttura della fattispecie incriminatrice sia stata congegnata dal legislatore in maniera del tutto indipendente dal peculiare contesto in cui ha visto la luce delineandone un ambito di applicazione generale non limitato alle condotte tipiche della criminalità organizzata e privo di qualsiasi connotazione specializzante anche sotto il profilo soggettivo in quanto la condotta può essere materialmente realizzata da “chiunque“, sia pure nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o produttiva.
Alla luce di tale ricostruzione, dunque, ben si comprende per la Corte il percorso evolutivo seguito dalla giurisprudenza che ha gradualmente ampliato la portata applicativa della norma, inizialmente limitandone l’incidenza ai fini del contrasto di forme d’intimidazione mafiosa tese a scoraggiare la regolare dinamica dell’agire imprenditoriale (Sez. 6, n. 3492 del 09/01/1989, omissis, cit.), per poi escludere la necessaria realizzazione della condotta nel contesto delittuoso specifico della criminalità organizzata sul rilievo che il riferimento ai comportamenti posti in essere in siffatti contesti criminali ha il solo fine di caratterizzare le condotte punibili tramite il ricorso ad un “significativo parallelismo” e non intende affatto dimensionare e circoscrivere l’ambito di applicazione della norma (Sez. 3, n. 450 del 15/02/1995, omissis, cit.).
Nel testo dell’art. 513-bis, peraltro, la dichiarata volontà legislativa di reprimere i comportamenti mafiosi diretti ad impedire il libero svolgimento dell’attività imprenditoriale, secondo le regole della concorrenza, non ha trovato una fedele attuazione poiché la descrizione del fatto tipico è stata seccamente incentrata sulla realizzazione di atti di concorrenza accompagnati da violenza o minaccia, senza alcun riferimento alla specificità di un determinato contesto criminale.
Sotto altro, ma connesso profilo, la scelta di collocare la disposizione tra i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio (nel Capo II del Titolo VIII) ha di fatto allontanato l’area della oggettività giuridica della nuova figura di reato dal complesso delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dell’ordine pubblico.
L’imprecisione della norma, del resto, è stata subito colta dalla dottrina che, nel criticarne la funzione prevalentemente “simbolica“, ha posto in evidenza il problematico accostamento di elementi oggettivi di incerta ricomposizione interna (“atti di concorrenza“, da un lato, “violenza o minaccia dall’altro“) rilevando come l’uso della violenza e della minaccia si ponga all’esterno dei limiti e delle caratteristiche proprie dell’atto concorrenziale in senso tecnico con il logico corollario che l’attività volta a scoraggiare l’iniziativa imprenditoriale altrui, attraverso l’impiego di tali metodi, rischia di porsi al di là delle più note e scorrette forme di attività concorrenziale esorbitando dal concetto classico di concorrenza sleale secondo la previsione dell’art. 2598 cod. civ..
In tal senso, ad avviso del Supremo Consesso, il problema fondamentale posto dall’interpretazione della figura di reato in esame, priva di precedenti legislativi immediati, è stato prontamente individuato nella palese divergenza fra la ratio della previsione normativa e l’ambito di incidenza della sua tipicità delineata dal legislatore in relazione ad una oggettività giuridica i cui tratti identificativi sono risultati sostanzialmente diversi da quelli inizialmente annunciati con il conseguente disallineamento venutosi a determinare fra l’intentio legis, la formulazione lessicale del dettato normativo e la successiva opera di esegesi compiuta in sede dottrinale e giurisprudenziale.
Ciò posto, e richiamato il complesso delle considerazioni dianzi svolte, gli Ermellini rilevavano come i primi due orientamenti giurisprudenziali muovano da impostazioni ricostruttive sensibilmente differenti delineando percorsi argomentativi che in entrambi i casi giungono a soluzioni non condivisibili.
Il primo di essi intende conferire alla norma una maggiore determinatezza tipizzando le condotte punibili attraverso il riferimento ad un parametro normativo preciso ma estremamente delimitato nella sua potenzialità applicativa là dove ne restringe l’incidenza ad isolate forme di comportamento competitivo senza esplorare appieno la possibilità di un’interpretazione che si faccia carico di collocare la norma incriminatrice e il bene giuridico da essa tutelato all’interno di una visione complessiva dei presupposti della libertà di concorrenza nel sistema interno e nella sua più ampia dimensione euro-unitaria.
Per tali ragioni ne era stata criticata la ridotta efficacia delle capacità di tutela che rischiano di subire un sensibile ridimensionamento rendendo la norma sostanzialmente inapplicabile se non in casi assai limitati.
Il secondo indirizzo ermeneutico, a sua volta, nel mostrare una maggiore sintonia con le finalità e le ragioni di politica criminale che hanno accompagnato l’introduzione della fattispecie in esame, ne offre una lettura decisamente ampliativa rispetto a quella accolta dal primo orientamento, valorizzando la sola prospettiva ideologica dell’azione sicchè il carattere concorrenziale dell’atto non è dato dalla sua natura materiale ma dalla sua finalità.
Così ragionando, tuttavia, ad avviso del Supremo Consesso, si finirebbe necessariamente per accogliere il risultato di una vera e propria equiparazione tra l’atto violento o minaccioso finalizzato ad inibire la concorrenza, non ravvisabile nel dato normativo, e l’atto di concorrenza commesso con violenza o minaccia, espressamente annoverato fra gli elementi costitutivi del reato.
I rischi di compressione del principio di tassatività e determinatezza della legge penale emergevano, dunque, per la Corte di legittimità, con particolare evidenza.
Siffatta interpretazione estensiva della nozione degli atti di concorrenza, inoltre, rischia, sempre secondo la Suprema Corte, da un lato, di rafforzare del tutto impropriamente l’incidenza dell’elemento psicologico dei reato poiché, al di fuori di condotte intimidatorie poste in essere nell’esercizio dell’attività concorrenziale, il fine dei comportamenti illeciti dovrà comunque dirigersi verso il contrasto dell’altrui libertà di concorrenza, dall’altro lato, di imporre una rivisitazione del contenuto dell’oggettività giuridica dal momento che la norma verrebbe a tutelare situazioni ed attività non riconducibili esclusivamente al libero autodeterminarsi dell’imprenditore nella sua attività d’impresa, oltrepassando l’esigenza di protezione della sfera dell’economia pubblica, dell’industria e del commercio, per indirizzarsi di fatto verso la difesa di esigenze proprie dell’ordine pubblico.
Prospettive di maggior interesse ai fini della corretta soluzione del quesito rimesso per le Sezioni Unite, emergono, di contro, dalla valorizzazione delle implicazioni sottese alla soluzione di mediazione prospettata dal terzo dei richiamati orientamenti giurisprudenziali là dove si propone di ridefinire la tipicità della fattispecie assegnando al compimento degli “atti di concorrenza” una rinnovata centralità nel quadro evolutivo della pertinente normativa di riferimento, sia interna che di origine e derivazione euro-unitaria, senza tralasciare l’importanza del richiamo alle ragioni e alle finalità di tutela che hanno storicamente determinato la genesi della norma descritta nell’art. 513-bis cod. pen..
Prospettiva, questa, che reca in sé importanti elementi di novità, la cui rilevanza – nei termini che verranno di seguito illustrati – deve essere esaminata ed approfondita all’interno di un contesto normativo profondamente mutato rispetto a quello che vide l’inserimento nel sistema codicistico della predetta fattispecie di reato: un contesto “multilivello“, dunque più ampio e complesso, le cui numerose articolazioni forniscono oggi all’interprete parametri di riferimento utili per meglio inquadrare nel sistema le scelte di incriminazione a suo tempo operate dal legislatore.
Ebbene, pur in assenza di un’esplicita menzione, la Cassazione, in questa pronuncia, ritiene che il principio di libera concorrenza sia tutelato a livello costituzionale dall’art. 41, primo comma, Cost. il quale afferma che l’iniziativa economica privata è libera sicchè ogni individuo è libero di esercitare un’attività economica fatti salvi i limiti espressamente dettati nel secondo comma della richiamata disposizione fermo restando che tale principio è altresì tutelato dalla legislazione europea e da quella ordinaria che dettano al riguardo una serie di disposizioni volte a contrastare la formazione di monopoli privati e di coalizioni di imprese.
A fronte di ciò, i giudici di legittimità costituzionale facevano presente come l’accelerazione del processo di integrazione europea determinatosi fin dall’inizio degli anni novanta e la crescente importanza e pervasività delle regole di concorrenza stabilite dall’Unione europea, cui spetta a titolo di competenza esclusiva la loro definizione secondo criteri immediatamente vincolanti per le politiche economiche degli Stati membri (ex art. 3, par. 1, lett. b), TFUE), unitamente alla netta scelta di campo espressa in favore di “un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza” (ex artt. 119 par. 1 e 120 TFUE, in relazione all’art. 3, par. 3, TUE), abbiano sensibilmente inciso sulla portata del principio stabilito nell’art. 41, primo comma, Cost. imprimendogli connotazioni in parte nuove che il legislatore ordinario da tempo si è fatto carico di recepire e filtrare nell’ordinamento interno (sin dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato) in linea con l’affermazione euro-unitaria della centralità della tutela della concorrenza nella prospettiva di “un’economia sociale di mercato fortemente competitiva” (art. 3, par. 3, TUE).
A tal riguardo rilevano, in particolare: a) l’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sul riconoscimento della libertà d’impresa; b) i su citati artt. 3, par. 3 e 21, par. 2, lett. e), TUE; c) gli artt. 3, par. 1, lett. b), 32, lett. c), 34 ss., 101-109, 119, par. 1, 120 TFUE, che dettano le norme sostanziali in materia di tutela della concorrenza; d) il Protocollo n. 27 allegato ai Trattati là dove si afferma che «il mercato interno ai sensi dell’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata».
Nella libertà di concorrenza si è così progressivamente intravista una delle naturali espressioni della libertà di iniziativa economica privata, poi anche formalmente consacrata nella nuova disposizione di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., introdotta nell’ordinamento a seguito della modifica operata dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
In tal modo, la libertà di concorrenza si è imposta quale bene costituzionalmente rilevante la cui tutela viene assegnata, nell’ambito della nuova ripartizione delle competenze fra i diversi livelli territoriali di governo, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato che deve dal canto suo esercitarla «nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».
Di tale nuova declinazione del rapporto fra la libertà dell’iniziativa economica privata e la tutela delle regole della concorrenza anche nella più ampia dimensione del mercato comunitario si colgono chiaramente i segni nella evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale ormai costante nell’affermare che la nozione di «concorrenza», di cui al secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost., riflette quella operante in àmbito comunitario (ex plurimis v. Corte cost., sent. n. 97 del 16 aprile 2014 e n. 125 del 7 maggio 2014; Corte cost., sent. n. 325 del 17 novembre 2010; Corte cost., sent. n. 401 del 23 novembre 2007) sicchè essa comprende sia le misure legislative di tutela in senso proprio intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati (con la disciplina delle relative modalità di controllo, eventualmente anche sul piano sanzionatorio), sia le misure legislative di promozione volte ad eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza “nel mercato“) ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per il mercato”) (ex plurimis v. Corte cost., sent. n. 291 del 19 dicembre 2012 e n. 200 del 17 luglio 2012; Corte cost., sent. n. 45 del 12 febbraio 2010).
In questa seconda accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», vengono altresì perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sent. n. 401 del 2007).
Pur nell’indubbia varietà di posizioni, la dottrina, dal canto suo, tende a ricostruire il portato del principio costituzionale riconoscendo che «la libertà di concorrenza è valore implicito nella libertà d’iniziativa in quanto libertà di tutti».
La libertà d’iniziativa economica privata può essere esercitata, dunque, erga omnes come «eguale possibilità» di tutti i privati «di attivarsi materialmente e giuridicamente nello stesso settore» e, quindi, «di confrontarsi vicendevolmente, sottoponendo al giudizio del mercato la valutazione e il conseguente successo, delle reciproche iniziative, necessariamente sempre nuove e diverse, in una competizione senza fine».
La richiamata disposizione, di conseguenza, afferma il valore della libertà dell’iniziativa privata senza limitarne l’operatività ai rapporti fra Stato e imprenditore essendo la copertura costituzionale estesa sino a ricomprendervi anche il quadro delle relazioni reciproche tra imprenditori ed i rapporti fra questi ed i consumatori.
Pertanto, se dal riconoscimento della libertà d’iniziativa economica deriva, quale naturale corollario, quello del principio di eguaglianza nei rapporti economici, è evidente che la repressione delle forme di concorrenza sleale s’innesta proprio su quest’ultimo versante del precetto costituzionale offrendo una specifica tutela nei confronti di comportamenti posti in essere dall’imprenditore allo scopo di assicurarsi indebite posizioni di vantaggio che non ledono tanto (o soltanto) l’economia nazionale astrattamente considerata ma sono idonei a ledere anche, e soprattutto, l’esercizio dell’altrui libertà di iniziativa economica.
Il riferimento, obbligato anche ai sensi dell’art. 11 Cost., al complesso delle disposizioni normative che fondano lo “statuto” europeo della concorrenza, consente altresì di valorizzare, all’interno del perimetro tracciato dalla norma principio costituzionale scolpita nell’art. 41 cit., una serie di interessi emergenti ed implicitamente rilevanti ovvero nuove ed ulteriori declinazioni degli stessi riconoscendosi ormai che, attraverso tale procedimento ermeneutico, il “metodo competitivo” si eleva “a decisione di sistema” e “guadagna la funzione di principio generale dell’ordinamento“.
Alla luce di quanto appena esposto, per il Supremo Consesso, si può, allora, concludere, come osservato dalla dottrina, che la leale concorrenza è un bene non solo «socialmente rilevante, suscettibile di assurgere ad oggetto di tutela penale» ma anche dotato di «indiscutibile rilievo costituzionale» in un’accezione sia di tipo estrinseco o negativo, sia, soprattutto, di tipo positivo, quale assenza di condizionamenti indebiti all’esercizio della relativa libertà.
Volgendo lo sguardo all’ordinamento europeo, gli Ermellini osservavano come fosse agevole rilevare come il favor per la tutela della libertà di concorrenza si manifesti, in particolare, nell’insieme di divieti posti dagli artt. 101 e 102 TFUE (e in precedenza stabiliti negli artt. 81 e 82 TCE).
In particolare, se l’art. 101 TFUE afferma che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concorrenziali che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno, elencando in un apposito catalogo una serie di specifici comportamenti (ad es., fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita, limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza, ecc.) ritenuti rilevanti al fine di incrementare il benessere dei consumatori e realizzare l’integrazione dei mercati nazionali tramite la creazione di un mercato unico, l’art. 102 TFUE vieta, a sua volta, l’abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo e ne sanziona, in particolare, lo sfruttamento abusivo non essendo di per sé incompatibile con il mercato la ricorrenza di una posizione dominante ma l’uso scorretto che della stessa si faccia per pregiudicare l’ordinario andamento del mercato e la finalità di tale disposizione, pertanto, è quella di arginare ogni tipo di pratica abusiva che, non solo provochi un danno al consumatore, ma pregiudichi anche la sussistenza di una concorrenza effettiva tra le imprese.
I comportamenti tipici che possono dar luogo ad un abuso di posizione dominante, a loro volta, sono individuati in termini del tutto corrispondenti a quelli che possono formare oggetto delle intese vietate ai sensi dell’art. 101 cit..
Le richiamate disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tra l’altra, producono effetti diretti nei rapporti tra i singoli ed attribuiscono agli interessati diritti che possono essere direttamente invocati dinanzi ai giudici nazionali tenuto conto altresì del fatto che, nel proclamare in linea generale il principio della libertà d’impresa conformemente al diritto dell’Unione europea e alle legislazioni e prassi nazionali, l’art. 16 CDFUE contiene uno specifico criterio di coordinamento con l’intera normativa euro-unitaria fermo restando però che la previsione di tale criterio non involge soltanto le naturali esigenze di raccordo con le condizioni ed i limiti previsti dalle norme contenute nei Trattati poiché si afferma espressamente nella richiamata disposizione che la libertà d’impresa deve essere esercitata “conformemente al diritto dell’Unione” così includendovi, dunque, le regole di diritto derivato che governano in maniera specifica e dettagliata i meccanismi di funzionamento della concorrenza (ad es., il Regolamento CE n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 del Consiglio, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, e il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese).
Conclusa questa disamina del quadro normativo europeo di riferimento in relazione al tema in questione, i giudici di piazza Cavour evidenziavano altresì che del tutto conformi alle regole stabilite dalla disciplina europea della concorrenza risultano essere le disposizioni contenute nell’ordinamento interno ed, in particolare, nella legge 12 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato, i cui artt. 2 e 3 dettano analoghe previsioni in tema di intese restrittive della libertà di concorrenza, abuso di posizione dominante e concentrazioni fra imprese, volte a preservare il regime concorrenziale del mercato a livello nazionale ed a reprimere i comportamenti anticoncorrenziali che incidono esclusivamente sul mercato italiano.
Non solo quindi le situazioni vietate sono individuate assumendo quale modello di riferimento il contenuto delle corrispondenti disposizioni dell’ordinamento euro-unitario ma, nella richiamata legge di recepimento (ex art. 1, comma 4), figura espressamente enunciato il criterio secondo cui le regole interne vanno interpretate « in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza».
Identici, dunque, per la Suprema Corte, devono ritenersi i comportamenti pericolosi per la struttura concorrenziale del mercato posti sotto controllo dalla normativa europea e da quella nazionale con la relativa esigenza di una regola di riparto che il legislatore ha introdotto riconoscendo alla prima una posizione preminente e sovraordinata anche sotto il profilo della residualità della disciplina interna in quanto applicabile alle pratiche anticoncorrenziali che abbiano un rilievo esclusivamente locale e non incidano sulla concorrenza nel mercato comunitario.
Oltre a ciò, veniva tra l’altro messo in evidenza che nel sistema italiano, come in quello di altri Paesi, è altresì vietato l’abuso dello stato di dipendenza economica nel quale si trovi un’impresa, cliente o fornitrice, rispetto ad una o più altre imprese anche in posizione non dominante sul mercato ex art. 9, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 192 secondo cui «si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l’abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti» mentre nell’art. 9, comma 2, legge cit. si prevede che «l’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto» così individuando in forma esemplificativa una serie di comportamenti tipici dei rapporti verticali fra imprese che in parte coincidono con quelli che danno vita alla fattispecie di abuso di posizione dominante.
In una più ampia prospettiva di analisi, inoltre, si collocano le previsioni della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese” che ha inteso definire (art. 1, comma 1) «lo statuto delle imprese e dell’imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d’impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione».
Lo statuto, in particolare, mira «a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo e internazionale” [ex art. 1, comma 5, lett. g)] prevedendo, al fine di raggiungere tali obiettivi, l’adozione di iniziative (ad es. l’integrazione degli statuti delle associazioni di imprese con un codice etico) volte a favorire «il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la libera concorrenza» (art. 3, comma 4).
Concluso questo excursus normativo, gli Ermellini facevano oltre tutto presente che il principio cardine della legislazione europea in tema di regole della concorrenza, pienamente recepito anche nell’ordinamento interno, è quello secondo cui la libertà di iniziativa economica e la competizione fra le imprese non possono tradursi in atti e comportamenti pregiudizievoli per la struttura concorrenziale del mercato.
Il fatto che il legislatore tuteli la libertà di concorrenza delle imprese non significa, però, osservavano i giudici di legittimità ordinaria, che ne giustifichi qualsiasi arbitrio poiché nel tentativo, legittimo, di allargare la propria quota di mercato esse potrebbero far ricorso a strumenti “sleali” in contrasto con l’obbligo di comportarsi in conformità “ai principi della correttezza professionale” (art. 2598, comma 3, cod. civ.) atteso che il riconoscimento legislativo della libertà di iniziativa economica privata e della conseguente libertà di concorrenza costituisce un presupposto necessario, ma non sufficiente, per la instaurazione di un regime di mercato oggettivamente caratterizzato da un sufficiente grado di effettiva competizione concorrenziale ed è dunque necessaria la previsione di modelli e tecniche di regolamentazione che impediscano sul piano giuridico, in relazione a diversi ed egualmente meritevoli profili di tutela, il determinarsi di situazioni di monopolio e quasi-monopolio ovvero comportamenti illeciti che di fatto alterino o, addirittura, stravolgano il regolare funzionamento del mercato.
Nella ricerca di tale problematico punto di equilibrio, il legislatore nazionale, a sua volta, non solo consente limitazioni legali della concorrenza per fini di “utilità sociale” (art. 41, terzo comma, Cost.) ovvero limitazioni di tipo negoziale subordinandone al contempo la validità al rispetto di ben determinate condizioni (art. 2596 cod. civ.) ma mira, soprattutto, ad assicurarne l’ordinato e corretto svolgimento attraverso la repressione degli atti di concorrenza sleale (artt. 2598-2601 cod. civ.) così recependo nell’ordinamento interno la corrispondente normativa dettata dall’art. 10-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della libertà industriale del 1883 riveduta a L’Aja nel 1925, di cui al Regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 169 e convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701 che, a sua volta, fa riferimento agli “usi onesti in materia industriale e commerciale” trattandosi di atti questi che, diversamente dalla disciplina generale dell’illecito civile, vengono repressi e sanzionati dall’ordinamento anche se compiuti senza dolo o colpa (art. 2600, comma 1, cod. civ.) ed anche se non hanno ancora arrecato un danno al concorrente, dovendosi ritenere sufficiente, perchè scattino le specifiche sanzioni dell’inibitoria e della rimozione degli effetti prodotti (art. 2599 cod. civ.), che “l’atto sia idoneo a danneggiare l’altrui azienda” (art. 2598, comma 1, n. 3, cod. civ.) fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni in presenza dell’elemento psicologico (dolo o colpa) e di un danno patrimoniale attuale (art. 2600 cod. civ.).
L’art. 2598 cit., in particolare, classifica gli atti di concorrenza sleale individuando, in primo luogo, due vaste aree di fattispecie tipiche nel n. 1 (gli atti idonei a determinare confusione con i prodotti o con l’attività di un concorrente) e nel n. 2 (gli atti di denigrazione, idonei a determinare il discredito sui prodotti o sull’attività di un concorrente, e l’appropriazione di pregi dei prodotti o dell’impresa altrui) mentre, nel successivo n. 3, enuncia una regola generale di chiusura secondo cui costituisce atto di concorrenza sleale il fatto di avvalersi, direttamente o indirettamente, di “ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda“.
Si tratta, nell’ultima delle ipotesi citate, per la Suprema Corte, di qualsiasi atto che risulti, da un lato, contrario ai canoni di etica professionale generalmente accettati e seguiti nel mondo degli affari ovvero nello specifico settore cui appartengono le attività imprenditoriali in rapporto concorrenziale, dall’altro lato, idoneo a recare danno all’altrui azienda.
Il legislatore, dunque, impernia la valutazione sulla base di due criteri fondamentali di qualificazione (la contrarietà ai principii della correttezza professionale e l’idoneità a danneggiare l’altrui azienda) che se, per un verso, devono guidare il giudice nel delicato compito di adeguare l’apprezzamento del caso concreto alla coscienza sociale di un determinato momento storico (Sez. 1
civ., n. 752 del 17/04/1962, Rv. 251188), per altro verso, tendono ad operare come paradigmi di riferimento sul piano ermeneutico non solo in relazione all’individuazione degli atti cd. non tipizzati (previsti nel n. 3) ma anche per la qualificazione degli atti di concorrenza sleale espressamente indicati nell’art. 2598, n. 1 e n. 2, cit..
Il giudizio sui canoni di correttezza professionale, in tal modo, ad avviso del Supremo Consesso, non esaurisce l’intero arco dell’attività di qualificazione dell’illecito concorrenziale il cui retto svolgimento poggia altresì sul criterio, parimenti rilevante, della idoneità dell’atto a recare danno all’altrui attività imprenditoriale: idoneità intesa dalla dottrina quale capacità offensiva “specifica” e di regola più intensa rispetto a quella connaturata a “qualsiasi” atto di concorrenza poiché finalizzata a sottrarre uno spazio di mercato occupato o gestito dall’impresa concorrente.
Al residuale modello di riferimento delineato dall’art. 2598 n. 3 cit., la dottrina e la giurisprudenza hanno invece ricondotto un’ampia varietà di comportamenti illeciti come, ad esempio, il boicottaggio economico, la sistematica vendita sotto costo dei propri prodotti (cd. dumping), lo storno dei dipendenti, la cd. concorrenza “parassitaria” (quando attuata con accorgimenti e forme tali da evitare la piena confondibilità delle attività, a sua volta riconducibile alla fattispecie tipica degli atti di confusione), la pubblicità menzognera (quando sia specificamente diretta a screditare i prodotti di un altro imprenditore e non inquadrabile nella fattispecie tipica dell’appropriazione di pregi), l’acquisizione o l’utilizzazione in forme scorrette di informazioni commerciali o industriali e la violazione di norme pubblicistiche – penali, fiscali, amministrative ed oggi finanche, euro-unitarie, qualora il comportamento dia luogo ad una alterazione delle condizioni di concorrenza che incida sulle condizioni di mercato risolvendosi in profitto dell’autore della violazione e in danno di uno o più concorrenti (cfr. Sez. U civ., n. 582 del 23/02/1976, Rv. 379229).
Determinata, o comunque determinabile, deve pertanto ritenersi per la Corte di legittimità la categoria degli atti di concorrenza sleale per la cui valutazione occorre tener conto «degli interessi collettivi concorrenti alla dinamica economica, in adesione ai principi ed ai limiti di cui all’art. 41 della Costituzione, finalizzati a garantire che il mercato conservi la qualità strutturale di luogo della libertà di iniziativa economica per tutti i suoi partecipi, ovvero per chiunque pretenda di esercitare tale iniziativa» (Sez. 1 civ., n. 10684 del 11/08/2000; Sez. 1 civ., n. 2634 del 16/04/1983; Sez. 1 civ., n.11859 del 26/11/1997) ed entro tale prospettiva si è affermato, in particolare, che «l’aggancio ad un parametro snello adeguabile ai mutamenti del costume del mercato impone all’interprete di stabilire se un comportamento, ancorché non previsto dai nn. 1 e 2, e ferme restando le eccezioni delle privative, realizzi attualmente o potenzialmente la stessa dannosità anticoncorrenziale».
Tal che se ne faceva discendere, in definitiva, che la concorrenza libera viene lesa ogni qual volta l’equilibrio delle condizioni del mercato sia compromesso laddove il carattere residuale della previsione contenuta nell’art. 2598 n. 3 cod. civ. «consente di evitare che l’obiettivo anticoncorrenziale venga raggiunto con comportamenti che presentano lo stesso disvalore di quelli come tali considerati dal legislatore storico. Consegue la necessità di esaminare caso per caso se il comportamento allegato costituisce illecito, dia esso luogo, o meno, anche a violazione di norme pubblicistiche. Non rientrando siffatte ipotesi dentro una fattispecie astratta a sé stante» (cfr. Sez. 1 civ., n. 10684 del 11/08/2000).
Sulla base delle considerazioni dianzi esposte è evidente per le Sezioni Unite che, in assenza di una definizione, anche penalistica, del concetto giuridico di “concorrenza“, l’interpretazione del sintagma “atti di concorrenza“, centrale nella struttura della fattispecie incriminatrice delineata dall’art. 513-bis cod. pen., deve necessariamente procedere alla luce della pertinente normativa euro-unitaria ed interna che disciplina i presupposti e le regole di funzionamento della libertà di concorrenza.
Orbene, seguendo tale impostazione ricostruttiva, i giudici di piazza Cavour rilevavano come la tipicità della fattispecie vada inquadrata alla luce sia del superiore divieto di ordine costituzionale posto dall’art. 41, secondo comma, Cost. secondo cui qualsiasi forma di competizione concorrenziale riconducibile alla libera estrinsecazione dell’iniziativa economica privata non può svolgersi “in modo da recare danno” ad una serie di situazioni giuridiche soggettive costituzionalmente tutelate (come i diritti di libertà, sicurezza e dignità umana), sia dell’esigenza di rispetto dei limiti stabiliti dalla legge ordinaria (ex art. 2595 cod. civ.) per lo svolgimento della libera concorrenza, che sono quelli specificamente risultanti dal raccordo fra i diversi livelli della normativa euro-unitaria e delle disposizioni contenute nel codice civile e nella successiva legislazione speciale (in primo luogo, nella legge n. 287 del 1990).
Tra l’altro, nella medesima prospettiva indicata dalla Corte costituzionale nelle richiamate decisioni in ordine ai criteri di interpretazione della nozione di «concorrenza» di cui all’art. 117, secondo comma, Cost., si era mossa l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di cassazione nel settore civile (Sez. 1 civ., n. 14394 del 10/08/2012, Rv. 624016) secondo cui, già nel regime giuridico anteriore all’entrata in vigore del Regolamento comunitario n. 1 del 2003 – il quale, sostituendo il precedente Regolamento n. 4 del 1962, ha introdotto una maggiore integrazione tra gli ordinamenti nazionali in relazione alle azioni risarcitorie conseguenti a violazione della normativa “antitrust” – era consentito al giudice nazionale, alla luce degli artt. 85, 86, 89 e 90 del Trattato dell’Unione europea e della legge 10 ottobre 1990, n. 287, interpretare ed applicare le norme sulla concorrenza sleale – in particolare l’art. 2598 cod. civ. – assumendo come valore di riferimento la tutela della concorrenza.
A fondamento di tale affermazione, la Corte aveva osservato quanto segue: «la dimensione giuridica della concorrenza ha assunto nel nostro sistema la funzione di “valore di riferimento” giacché gli artt. 85 ed 86 del Trattato hanno imposto limiti nuovi mirati a proteggere la struttura concorrenziale del mercato anche indipendentemente dall’atteggiamento del soggetto leso. Da ciò il rilievo giuridico qualitativo dei presupposti, apparentemente solo quantitativi, dell’applicazione di tale novità giuridica, quali il “mercato rilevante”, ed il “pregiudizio agli scambi dei Paesi aderenti al Trattato”».
Il mercato, prosegue la Corte nella richiamata decisione, si identifica, nella nozione introdotta dal Trattato europeo, con quello concorrenziale sicchè il bene giuridico da tutelare è quello della competitività.
Ne consegue che «…..già prima del nuovo testo dell’art. 117 Cost., e dunque nel vigore del Trattato e quindi ancora a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 287 del 1990, si può dire certa nel nostro sistema giurisprudenziale la necessità di leggere la disciplina del codice civile parallelamente a quella del Trattato, ovvero considerandone parte integrante la logica antitrust».
Nella medesima direzione si muove d’altronde l’impostazione ricostruttiva parallelamente delineata dalla Cassazione nell’individuazione degli elementi costitutivi della condotta delittuosa tipizzata nell’art. 513-bis cit. là dove, nel sottolinearne la connotazione di norma non meramente sanzionatoria della disciplina civilistica, ha richiamato l’esigenza di fare riferimento sia alla normativa di matrice euro-unitaria, sia alla legislazione interna che vi ha dato attuazione (in primo luogo con la menzionata legge n. 287 del 1990), accogliendo l’intero ambito applicativo delle disposizioni racchiuse nell’art. 2598 cod. civ. (ivi compresa, pertanto, quella di cui al n. 3) non come un corpus estraneo e separato dalla suddetta normativa ma con essa strettamente compenetrato e da interpretare, dunque, alla stregua dei principii da essa desumibili (Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015; Sez. 3, n. 3868 del 10/12/2015,, cit.; Sez. 2, n. 30406 del 19/06/2018; Sez. 6, n. 50084 del 12/07/2018; Sez. 6, n. 50094 del 12/07/2018).
Posto ciò, per le Sezioni Unite si rende necessario, a questo punto della disamina, esplorare la potenzialità delle correlative implicazioni esegetiche ai fini della precisa delimitazione del contenuto precettivo della fattispecie e della corretta soluzione del richiamato contrasto.
Orbene, a tal proposito veniva rilevato che la condotta descritta dalla norma incriminatrice si inserisce all’interno di un’attività imprenditoriale e poggia essenzialmente sulla qualità materiale degli atti che vi danno corpo, ossia sulla loro qualificazione in senso concorrenziale e non sulla loro direzione teleologica.
La scelta del legislatore penale di impiegare nella descrizione degli elementi tipici della condotta la locuzione “atti di concorrenza” al plurale, anziché al singolare, non deve ritenersi per il Supremo Consesso casuale poiché se, di certo, deve ammettersi la possibilità di un atto di concorrenza isolato ed istantaneo (Sez. 3, n. 39784 del 16/05/2013) nella gran parte dei casi ricorre, normalmente, un’attività continuata di concorrenza e «poiché nel giudizio di concorrenza sleale non va isolatamente preso ciascun atto, che può anche essere lecito, ma va compiuto un apprezzamento complessivo dei fatti, ai fini della loro valutazione rispetto ai principi della correttezza professionale, la combinazione di essi può essere rivelatrice della manovra ordinata ai danni del concorrente, in quanto quegli atti, nella loro coordinazione, mettano capo all’attuazione di un mezzo sleale» (Sez. 1 civ., n. 752 del 17/0411962, cit.).
L’analisi della struttura della fattispecie di reato modellata dalla norma in esame, inoltre ne suggerisce, in primo luogo, la riconduzione all’interno di una dialettica concorrenziale postulando, attraverso il riferimento lessicale al compimento di atti di concorrenza “nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva”, sia la qualità di imprenditore in capo al soggetto che, direttamente o indirettamente, pone in essere la condotta, sia l’esistenza di un rapporto di competizione economica nei confronti del soggetto che ne subisce le conseguenze.
Il soggetto attivo e quello passivo del rapporto di concorrenza devono tendenzialmente offrire nello stesso ambito di mercato beni o servizi che siano destinati a soddisfare, anche in via succedanea, lo stesso bisogno dei consumatori o, comunque, bisogni complementari o affini tenendo conto, però, del fatto che il rapporto di concorrenza si instaura anche fra operatori che agiscono a livelli economici diversi (ad es.: produttore-rivenditore o grossista dettagliante) coinvolgendo «tutte le imprese i cui prodotti e servizi concernano la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni» posto che l’anello della catena, che porta il prodotto alla stessa categoria di consumatori in cui si collochi un imprenditore, fa sì che questi viene a trovarsi in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività, per cui ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole di cui all’art. 2598 cit. (Sez. 1 civ., n. 4739 del 23/03/2012).
Se, dunque, è vero che l’operatività della norma descritta nell’art. 513-bis si estende verso qualsiasi attività economicamente orientata alla predisposizione ed offerta di prodotti o servizi su un certo mercato, è parimenti vero che la delimitazione dei soggetti attivi o passivi del reato non va intesa in senso meramente formale in quanto non occorre la qualità di commerciante, industriale o produttore, ma semplicemente l’espletamento in concreto di attività che si inseriscono nella dinamica commerciale, industriale o produttiva (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014,; Sez. 2, n. 26918 del 16/05/2001) e ciò a prescindere dai requisiti di professionalità ed organizzazione tipici della figura civilistica dell’imprenditore e fatte salve, in base ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, le ipotesi di compartecipazione criminosa nella realizzazione della condotta punibile qualora vengano dimostrati la conoscenza da parte dell’extraneus della qualità di intraneus del soggetto agente ed il contributo del primo alla commissione del fatto (Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996).
Analogamente non si ritiene per la Suprema Corte necessario, sotto altro ma connesso profilo, che gli atti di concorrenza illecita siano diretti nei confronti dell’imprenditore concorrente non essendo tale caratteristica espressamente richiesta dalla norma a fronte di condotte che ben possono coinvolgere anche persone diverse da quello (Sez. 6, n. 37520 del 18/04/2019).
Finanche in relazione alla disciplina civilistica della concorrenza sleale si ritiene, del resto, che l’imprenditore possa rispondere sia per gli atti da lui direttamente compiuti, sia per quelli posti in essere da altri soggetti (ausiliari autonomi e subordinati, concessionari, imprese controllate ecc.) nel suo interesse e dietro sua istigazione o specifico incarico espressamente prevedendo la norma di cui all’art. 2598, n. 3, cit. che l’atto di concorrenza sleale può essere compiuto anche “indirettamente“.
A fronte di ciò, ad avviso delle Sezioni Unite, una specifica valenza selettiva ai fini della individuazione della condotta punibile deve assegnarsi, inoltre, ai contenuto e alle finalità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in esame che ha introdotto nel codice penale un reato plurioffensivo orientato non solo verso la tutela di un più ampio interesse al corretto funzionamento del sistema economico, inteso come bene finale, ma anche alla protezione di un diverso interesse da intendersi quale bene strumentale più direttamente inerente ad una esigenza di garanzia della sfera soggettiva della libertà di ciascuno di autodeterminarsi nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva (v., in motivazione, Sez. 3, n. 44169 del 22/10/2008; Sez. 3, n. 46756 del 03/11/2005) visto che la volontà del soggetto passivo della condotta di illecita concorrenza con minaccia o violenza non opera liberamente in quanto viene condizionata, rispettivamente, dalla prospettazione di un male ingiusto ovvero dalla costrizione fisica a determinarsi nel senso impostogli dall’agente.
In materia di concorrenza, in effetti, il sistema è ispirato al concetto che la libera competizione nel campo industriale, commerciale e produttivo purchè esercitata con l’osservanza di determinate regole ed è, sotto vari aspetti, utile e vantaggiosa nell’interesse generale dato che l’art. 2595 cod. civ., lungi dal vietare la concorrenza, dispone in linea generale che essa deve svolgersi «in modo da non ledere gli interessi dell’economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge».
Qual che ne sia la dimensione, dunque, lo svolgimento delle attività descritte dalla norma incriminatrice deve rispettare ben precisi canoni di correttezza nell’ambito dei rapporti di coesistenza sul mercato fra imprenditori concorrenti: canoni il cui diverso grado di inosservanza è progressivamente sanzionato nell’ordinamento civile e in quello penale.
La dialettica del rapporto concorrenziale, entro cui può fisiologicamente dispiegarsi il libero esercizio dell’attività d’impresa, quindi, ad avviso delle Sezioni Unite, delinea, unitamente ai contenuti del bene protetto, il contesto giuridico entro cui si inserisce e, come tale, va ricostruita la tipicità di una condotta oggettivamente distorsiva degli ordinari meccanismi di competizione economica: condotta che, in quanto illecitamente connotata dal ricorso ai mezzi della violenza o della minaccia, assume rilievo penale integrando la fattispecie incriminatrice senza che si renda necessaria la reale intimidazione del soggetto passivo ovvero una effettiva alterazione degli equilibri di mercato.
Non dissimili appaiono tra l’altro le implicazioni di ordine generale sottese agli esiti della elaborazione giurisprudenziale che la Cassazione (Sez. 1 civ., n. 2157 del 7 luglio 1959) ha da tempo sviluppato con riferimento alla individuazione dei tratti differenziali della concorrenza illecita là dove affermato che «….tutti gli atti di concorrenza, siano essi leciti o illeciti, mirano in generale al medesimo scopo, che è quello di affermare sul mercato la propria azienda, o di incrementarla mediante l’acquisizione di nuovi clienti o di nuovi affari, a scapito e con pregiudizio, quanto meno potenziale, delle aziende concorrenti. La differenza tra concorrenza lecita e concorrenza sleale non è data, dunque, dallo scopo che l’una o l’altra perseguono, ma è determinata ‘unicamente dalla natura dei mezzi adoperati, che sono i soli rilevanti ai fini della qualificazione di un atto come atto di concorrenza sleale, ai sensi dell’art. 2598 cod. civ.».
La disciplina della concorrenza sleale, ha affermato la Corte nella richiamata decisione, «….concerne appunto le modalità della concorrenza, la cui illiceità è caratterizzata dalla natura dei mezzi usati, in quanto contrari ai principi della correttezza professionale ed idonei a danneggiare le altrui aziende, non già dalla intrinseca natura degli atti di concorrenza, o dalla concreta entità degli stessi, o dall’intenzione dell’imprenditore di pregiudicare i concorrenti mediante un’attività consentita dall’ordinamento giuridico».
La medesima disciplina, inoltre, può operare a diversi livelli del mercato ed investire quei rapporti concorrenziali che sono tali solo potenzialmente, sotto i distinti profili: a) territoriale (avendo riguardo non solo al luogo di produzione o di commercio ma anche al cd. “mercato di sbocco“); b) merceologico (in ragione della accentuata tendenza delle imprese ad allargare la gamma delle produzioni per ricomprendervi prodotti succedanei o analoghi); c) temporale (potendo riguardare una competizione fra soggetti che debbano ancora iniziare la propria attività d’impresa – per avere già provveduto alla organizzazione di tutti i fattori produttivi univocamente orientandoli alla realizzazione di un commercio concorrente – ovvero stiano per esaurire quell’attività).
Entro tale impostazione ricostruttiva, pertanto, deve inquadrarsi la scelta dal legislatore operata nel disegnare gli elementi di tipicità della condotta punibile attribuendo alla duplicità dei mezzi alternativamente impiegabili nell’esercizio delle attività economiche ivi descritte (quelli, cioè, della violenza o della minaccia) il vero tratto di disvalore penale di una condotta in sé altrimenti legittima, come l’atto posto in essere nell’esercizio di una libertà riconosciuta e tutelata dall’ordinamento.
L’intima connessione, che la norma incriminatrice richiede fra gli atti di esercizio della libertà di concorrenza all’interno di un rapporto di competizione economica – anche solo potenziale – e le specifiche note modali rappresentate dall’utilizzo della violenza o della minaccia, costituisce un fattore distorsivo delle regole di svolgimento di quella che dovrebbe essere, di contro, una paritaria contesa commerciale sino a varcare il limite dell’atto di concorrenza anche nel suo stigma di “slealtà” innestando sull’atto di esercizio di una libertà – e con un grado d’intensità variabile a seconda dei casi – l’illecita componente oggettiva della contestuale compressione quando non addirittura della negazione, della corrispondente e parimenti tutelata possibilità di autodeterminazione del concorrente nello svolgimento delle diverse attività produttive richiamate nella predetta disposizione.
Attorno alle componenti oggettive della violenza e della minaccia, che non vi figurano come elementi finalisticamente orientati bensì come elementi costitutivi della condotta, concorrendo a delinearne la tipicità attraverso una previsione in forma alternativa del suo aspetto modale, ruota dunque, secondo i giudici di piazza Cavour, la sfera di offensività dell’intera fattispecie.
Per tale ragione il legislatore fa riferimento, anche nella rubrica della norma in esame, ad una condotta di illecita concorrenza ossia ad un atto di concorrenza non semplicemente sleale ma necessariamente caratterizzato dalla peculiare natura dei mezzi adoperati che, a loro volta, ne accompagnano la realizzazione e ne giustificano, al contempo, il giudizio di meritevolezza della tutela penale: la violenza o la minaccia, all’interno di un rapporto di concorrenzialità, è legato allo svolgimento di un’attività d’impresa in competizione, anche solo potenziale, con l’omologa attività di uno o più soggetti egualmente interessati ad esercitarla in uno spazio di mercato dove le condizioni della libertà di concorrenza siano rispettate e ne garantiscano la possibilità di una lecita attuazione atteso che la libertà di concorrenza non si traduce solo nella libertà di svolgere la propria attività d’impresa in competizione con una pluralità di soggetti operanti sul mercato ma anche nella libertà da illecite interferenze e condizionamenti che ne contrastino od ostacolino l’esercizio alterando la dimensione concorrenziale di uno spazio produttivo che i protagonisti ‘utilizzano anche in favore della collettività e dove quella libertà, non solo viene generalmente regolata e promossa, ma deve anche lecitamente attuarsi.
Entro tale prospettiva, dunque, per il Supremo Consesso, assumono rilievo penale, alla luce della richiamata normativa interna ed euro-unitaria, quei comportamenti competitivi posti in essere sia in forma attiva che impeditiva dell’esercizio dell’altrui libertà di concorrenza che si prestino ad essere realizzati in forme violente o minatorie sì da favorire o consentire l’illecita acquisizione in pregiudizio del concorrente minacciato o coartato, di posizioni di vantaggio ovvero di predominio sul libero mercato senza alcun merito derivante dalle capacità effettivamente mostrate nell’organizzazione e nello svolgimento della propria attività produttiva fermo restando che le illecite forme di esercizio della concorrenza incriminate dalla richiamata disposizione minacciano di rimuovere le precondizioni necessarie all’esplicarsi della stessa libertà di funzionamento del mercato incidendo al contempo sulla libertà delle persone di autodeterminarsi nello svolgimento delle attività produttive.
Da ciò se ne fa discendere come sia il libero svolgimento delle iniziative economiche ad essere tutelato attraverso la sanzione di comportamenti costrittivi o induttivi che possono orientarsi anche sulla libertà di iniziativa delle persone e non più solo sulle cose come nella condotta contemplata dalla contigua previsione dell’art. 513 cod. pen. che di contro richiede, in alternativa all’uso della violenza, il ricorso a mezzi fraudolenti con il fine di cagionare, in entrambi i casi, l’impedimento o il turbamento dell’esercizio di un’attività industriale o commerciale.
L’idoneità a recare un pregiudizio all’impresa concorrente, contrastandone od ostacolandone la libertà di autodeterminazione, invero, connota la fattispecie dell’art. 513-bis cod. pen. nella sua materialità poiché costituisce un elemento oggettivo della condotta, a sua volta accompagnata dalla coscienza e volontà di compiere un atto di concorrenza inficiato dal ricorso ai mezzi della violenza o della minaccia ossia di determinare una situazione di concorrenzialità illecita che rischia obiettivamente di alterare o compromettere l’ordine giuridico del mercato.
Sotto altro profilo, infine, gli elementi, che concorrono a descrivere la tipicità del reato di illecita concorrenza, impediscono di ritenerne assorbita la condotta nella più grave fattispecie della estorsione (consumata o tentata) in base al criterio di specialità posto che i due reati, rientranti in una diversa collocazione sistematica, offendono beni giuridici diversi incidendo nel secondo caso sul patrimonio del soggetto passivo (Sez. 6, n. 6055 del 24/06/2014, dep. 2015) con la previsione dell’elemento di fattispecie relativo all’ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno senza tradursi in una violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell’attività economica concorrente (Sez. 2, n. 53139 del 08/11/2016, omissis, Rv. 268640).
Tal che ne discende, altresì, che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia non può essere assorbito nel delitto di estorsione trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti, si ha il concorso formale degli stessi (Sez. 2, n. 5793 del 24/10/2013,; Sez. 1, n. 24172 del 31/03/2010).
In conclusione, la questione posta dall’ordinanza di rimessione veniva risolta enunciando il seguente principio di diritto: «ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente».
Conclusioni
Con questo arresto giurisprudenziale le Sezioni Unite chiariscono cosa deve contraddistinguere gli atti di violenza ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. enunciando il principio di diritto secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente.
Orbene, fermo restando la condivisibilità di tale principio stante il fatto che gli Ermellini sono addivenuti a siffatta conclusione dopo un articolato e ben ponderato ragionamento giuridico, va altresì osservata l’importanza di questa decisione in quanto, come appena visto, attraverso di essa, si spiega che gli atti di violenza, per poter costituire uno degli elementi costitutivo del delitto di cui all’art. 513-bis c.p. (“Illecita concorrenza con minaccia o violenza”), devono essere: a) posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva; b) connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente nel senso che questi comportamenti vengano commessi sia in forma attiva, che impeditiva, dell’esercizio dell’altrui libertà di concorrenza e che si prestino ad essere realizzati in forme violente o minatorie sì da favorire o consentire l’illecita acquisizione in pregiudizio del concorrente minacciato o coartato di posizioni di vantaggio ovvero di predominio sul libero mercato senza alcun merito derivante dalle capacità effettivamente mostrate nell’organizzazione e nello svolgimento della propria attività produttiva.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, proprio perché fa chiarezza sulla portata applicativa di questa norma incriminatrice, dunque, non può che essere positivo.
Volume consigliato


















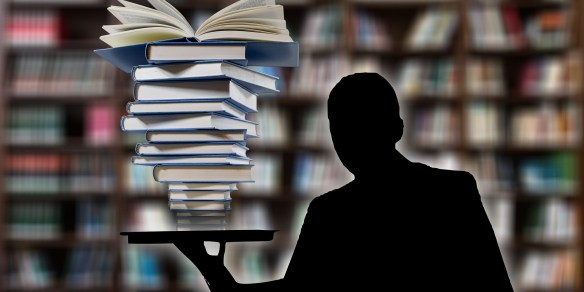


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento