(Annullamento con rinvio)
(Riferimento normativo: Cod. pen. art. 133)
Il fatto
Con sentenza in data 19 febbraio 2014, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria del 22 gennaio 2013, esclusa la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 del convertito dalla L. n. 203 del 1991, confermava il giudizio di responsabilità formulato a carico degli imputati S.D., M.A. e A.S.A. in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale e preferenziale, loro contestati al capo B) ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 1, n. 2 e n. 3, e art. 219, comma 2, n. 1, e rideterminava in anni quattro di reclusione la pena per ciascuno, revocava l’interdizione legale, sostituiva l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque e revocava altresì le statuizioni civili.
Agli imputati era contestato di avere, nella qualità di amministratori di fatto della s.r.l. (OMISSIS), dichiarata fallita con sentenza, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 11 dicembre 2008, di aver sottratto, o comunque occultato, beni strumentali per un valore di Euro 274.778,00 e la somma di Euro 102.800,00, prelevata dai conti bancari della società per adempiere debiti di ignota titolarità ed incerta esistenza; di avere, al fine di procurare a sè o altri un ingiusto profitto e di arrecare danno ai creditori, sottratto i libri e le scritture contabili della società, altresì tenute in modo tale da ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e di aver effettuato pagamenti ad alcuni creditori, preferiti ad altri, con ciò cagionando un danno di rilevante gravità e commettendo plurimi fatti di bancarotta.
I motivi formulati nel ricorso per Cassazione
Avverso la suddetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione, per il tramite dei loro difensori, gli imputati. In particolare, l’imputato A.S.A. formulava i seguenti motivi: 1) violazione della legge in relazione all’art. 530 c.p.p., commi 1 e 2, e art. 533, comma 1 deducendo che la motivazione della sentenza impugnata si era limitata al rinvio alle considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, di cui aveva riprodotto il percorso argomentativo in assenza di una autonoma disamina delle specifiche doglianze espresse con l’atto di gravame circa l’effettiva sussistenza degli addebiti mossi al ricorrente; in tal modo la motivazione per relationem non poteva considerarsi effettiva e sufficiente; 2) violazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione all’art. 110 c.p. ed alla L. Fall., art. 223, comma 1, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 1 e 2, e comma 3, ed all’art. 219, comma 2, n. 1 atteso che, secondo la difesa, la sentenza impugnata non aveva evidenziato la prova incontrovertibile della responsabilità del ricorrente, che avrebbe dovuto essere mandato assolto come disposto per i coimputati i quali, sottoposti a separato procedimento dibattimentale per le medesime vicende penali connesse al fallimento della s.r.l. (OMISSIS), erano stati assolti dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 15 luglio 2014.
A sua volta, sul presupposto della mancata notificazione della sentenza all’imputato M.A., il difensore di fiducia, avv.to V.G. aveva presentato ricorso deducendo con unico motivo proposto ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), violazione di legge in relazione agli artt. 192,544 e 546 c.p.p. ed alla L. Fall., artt. 216,217,219,223 e apparenza della motivazione visto che, secondo il ricorrente, la sentenza di appello non aveva illustrato i risultati probatori acquisiti ed i criteri adottati per affermare la responsabilità dell’imputato e non aveva desunto il fatto di reato da indizi gravi, precisi e concordanti, indicando le ragioni del proprio convincimento.
Premesso che la sentenza di appello era stata notificata ai propri difensori soltanto in data 18 luglio 2017, anche l’imputato S.D. aveva proposto ricorso articolando i seguenti motivi così strutturati: 1) violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 533 c.p.p., comma 1, in riferimento agli artt. 110 e 43 c.p., nonchè alla L. Fall., art. 223, comma 1, art. 216, comma 1, n. 1, commi 2 e 3, e art. 219, comma 2, n. 1 stante il fatto che, secondo il ricorrente, nella sentenza impugnata non era stata individuata la prova della condotta materiale contestata per potergli ascrivere la qualità di amministratore di mero fatto della società fallita, nè dell’attribuzione alla sua persona del compimento di fatti distrattivi o di pagamenti preferenziali essendo stato fatto in sentenza ricorso a mere presunzioni; 2) violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 54 c.p. posto che – una volta rilevato che la Corte di appello aveva ritenuto che, per essersi gli amministratori della s.r.l. (OMISSIS) rivolti ad esponenti della locale criminalità organizzata onde ottenere finanziamenti e forniture, costoro si erano posti volontariamente nelle condizioni di subire le pretese di tali interlocutori – si riteneva come siffatto assunto fosse manifestamente illogico perchè postulava la previa conoscenza in capo al ricorrente dell’appartenenza di tali soggetti al contesto criminale mafioso e la prevedibilità delle loro pretese, ma non considerava che egli si fosse attivato soltanto per evitare il fallimento, mentre la situazione di pericolo non era stata causata ed era insorta per le minacce ricevute in un momento successivo alla contrazione del debito; 3) violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla L. Fall., art. 219, comma 1, e art. 223 stante la diversità strutturale ed ontologica fra la fattispecie di bancarotta fraudolenta impropria e quella ordinaria che non consentiva la trasposizione in via analogica della circostanza aggravante prevista nell’art. 219, comma 1, per effetto del richiamo letterale alle norme della L. Fall., artt. 216, 217 e 218 ostandovi l’interpretazione letterale della norma, aderente ai parametri di legalità e tassatività; 4) violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. e agli artt. 133 e 62-bis c.p. dato che la sentenza impugnata non offriva una motivazione per la mancata applicazione del minimo edittale della pena e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche giustificato in base alla pretesa genericità dei motivi di appello frutto della mancata esatta percezione delle doglianze con le quali si erano state evidenziate le pressioni usurarie e mafiose subite, i tentativi di salvare la società e di ripianare i debiti con risorse ricavate anche dalla vendita di un bene personale.
La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione
La Quinta Sezione penale, cui il ricorso era stato inizialmente assegnato, rimetteva la decisione alle Sezioni Unite rilevando che i motivi di contestazione sull’entità della pena principale devolvevano anche il tema, strettamente collegato, anche se non investito di censure difensive nei ricorsi, della commisurazione delle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale per la durata di anni dieci e dell’incapacità per lo stesso periodo ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, inflitte ai ricorrenti in applicazione della L. Fall., art. 216, u.c., disposizione oggetto della recente pronuncia di illegittimità costituzionale, emessa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018.
La Sezione rimettente osservava prima di tutto come la sommaria delibazione degli atti processuali autorizzasse il dubbio sulla intempestività dei ricorsi, proposti nell’interesse di M.A. e S.D..
Premesso ciò, si rilevava come, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale avesse dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. Fall., art. 216, u.c. nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, anzichè prevedere che tali sanzioni siano applicate sino ad un massimo di dieci anni, e che gli effetti della pronuncia dal giorno successivo alla sua pubblicazione assumono rilievo anche nel presente processo sotto il profilo della possibile sopravvenuta illegalità delle stesse pene accessorie, irrogate agli imputati in via automatica nella misura massima consentita dalla disposizione riconosciuta incostituzionale in assenza di una puntuale e specifica giustificazione di adeguatezza e congruità di una durata così protratta.
L’ordinanza di rimessione aveva poi osservato come, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma citata, fosse intervenuta la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Quinta penale n. 1963 del 7/12/2018 per la quale le pene accessorie previste dalla L. Fall., art. 216, u.c., nella formulazione modificata dalla pronuncia n. 222 del 2018 della Corte costituzionale, restavano soggette alla disciplina di cui all’art. 37 c.p..
Orbene, nell’esprimere dissenso rispetto a tale arresto, si osservava che la Consulta, stabilendo che le pene accessorie previste dalla legge fallimentare sono irrogabili “fino a dieci anni“, aveva escluso di poter fare riferimento al criterio residuale di cui all’art. 37 c.p. e aveva riconosciuto al giudice la possibilità di determinazione in via autonoma della durata della pena accessoria in base ai criteri dettati dall’art. 133 c.p. e, sulla scorta di tali premesse, aveva ravvisato l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite il componimento del contrasto con diverso orientamento della stessa sezione, divenuto reale in seguito all’ulteriore pronuncia della medesima Sezione n. 7851 del 13/12/2018, postasi parimenti in termini oppositivi rispetto alla linea interpretativa proposta dalla sentenza Piermartiri e l’eventuale superamento dei principi di diritto, espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B..
Approfondisci:” Compendio penale”
Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite
Una volta fatto presente che si doveva risolvere la seguente questione di diritto: “Se le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta dalla L. Fall., art. 216, u.c., come riformulato ad opera della sentenza n. 222 del 2018 della Corte Costituzionale, debbano considerarsi pene con durata “non predeterminata” e quindi ricadere nella regola generale di computo di cui all’art. 37 c.p.; ovvero se la durata delle pene accessorie debba invece considerarsi “predeterminata” entro la forbice data, con la conseguenza che non trova applicazione l’art. 37 c.p. ma, di regola la rideterminazione involge un giudizio di fatto di competenza del giudice del merito, da effettuarsi facendo ricorso ai parametri di cui all’art. 133 c.p.“, le Sezioni Unite ritenevano di dover trattare, in via preliminare, la verifica circa l’ammissibilità dei ricorsi sotto il profilo della loro tempestiva proposizione rilevandosi a tal riguardo che dalla consultazione degli atti processuali emergeva che la sentenza di appello, depositata in cancelleria in data 19 giugno 2017 dopo il termine di novanta giorni, fissato ai sensi dell’art. 544 c.p.p., comma 3, era stata notificata in via telematica per posta certificata agli imputati ed ai loro difensori in base all’art. 157 c.p.p., comma 8-bis, nelle seguenti date: 11 luglio 2017 all’avv.to D. E. in proprio e quale difensore di S.D.; 18 luglio 2017 all’avv.to M.C. in proprio in quanto codifensore del medesimo S.; 11 luglio 2017 all’avv.to V.G. in proprio e quale difensore di M.A. ed agli avv.ti C.A. e P.N. in proprio e quali difensori di A.S.A..
Tal che, da tale premessa, se ne faceva discendere la tempestività di tutti i ricorsi, non soltanto di quello proposto dall’ A. in data 25 settembre 2017, ma anche dei restanti fermo restando che il termine di quarantacinque giorni per proporre ricorso per cassazione, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, non era ritenuto essere decorso negli stessi tempi per tutti gli imputati.
Premesso ciò, riconosciuta l’ammissibilità delle impugnazioni, si rendeva ad avviso della Corte necessaria la soluzione del quesito giuridico sottoposto al vaglio delle Sezioni Unite a ragione del fatto che agli imputati, già con la sentenza di primo grado, erano state applicate le sanzioni accessorie previste dalla L. Fall., art. 216, u.c. dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci in conformità alla previsione normativa vigente al momento dell’assunzione della decisione e quale effetto obbligato, condizionato dal giudizio di responsabilità in ordine alle fattispecie di bancarotta fallimentare loro ascritte.
Ciò posto, si denotava come entrambe le sentenze pronunciate nei due gradi di merito sul punto si fossero allineate all’orientamento interpretativo prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte, che, in nome della formulazione letterale allora vigente della L. Fall., art. 216, per la quale “salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione per l’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, riteneva determinata per legge ed in misura fissa ed inderogabile la durata delle predette sanzioni accessorie (ex multis: Sez. 5, n. 56323 del 26/10/2017; Sez. 5, n. 15638 del 05/02/2015; Sez. 5, n. 41035 del 10/06/2014; Sez. 5, n. 51526 del 18/10/2013; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010; Sez. 5, n. 269 del 10/11/2010; Sez. 5, n. 39337 del 20/09/2007).
Chiarito ciò, si evidenziava inoltre che, oltre al dato letterale, a sostegno di tale opinione si potesse ricorrere anche ad un argomento sistematico alimentato dal raffronto col testo della L. Fall., art. 217, comma 3, che per il reato di bancarotta semplice documentale stabilisce la pena accessoria, determinata solo nel limite massimo “fino a due anni“, con la conseguente soggezione al principio generale previsto dall’art. 37 c.p. di equiparazione automatica del quantum della pena accessoria a quello della pena principale.
Pur tuttavia, si prendeva atto di un orientamento minoritario e meno recente che propendeva, invece, per individuare nella previsione della L. Fall., art. 216, u.c. una durata non predeterminata in misura unica dal legislatore e quindi da individuarsi nell’ambito di un ampio intervallo temporale sino al limite edittale massimo in base al criterio integrativo dettato dall’art. 37 c.p. (Sez. 5, n. 23720 del 18/06/2010; Sez. 5, n. 9672 del 22/01/2010; Sez. 5, n. 4727 del 15/03/2000).
Evidenziato questo contrasto giurisprudenziale in siffatti termini, si sottolineava come le posizioni contrapposte riassumessero un dibattito giurisprudenziale risalente nel quale si inseriva anche la sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 31/05/2012 che, investita della questione di legittimità costituzionale della L. Fall., art. 216, u.c., l’aveva ritenuta inammissibile senza esaminarla nel merito per l’impossibilità di aderire al petitum formulato dai giudici rimettenti in termini di diversa articolazione della norma con l’aggiunta della durata delle pene accessorie “sino a dieci anni” per renderle soggette alla disciplina dell’art. 37 c.p., soluzione additiva considerata non obbligata e non l’unica praticabile per salvarne la conformità alla Costituzione, ma soltanto una tra quelle ipotizzabili, da rimettere però al prioritario intervento di produzione normativa del legislatore, che ben avrebbe potuto stabilire una graduazione tra un minimo ed un massimo di durata, oppure una differente modulazione delle pene accessorie rispetto alle principali.
Posto ciò, si faceva altresì presente che, nelle more della trattazione dei ricorsi proposti dagli odierni imputati, fosse intervenuta la pronuncia della sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, u.c., nella parte in cui prescrive che “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, anzichè “la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni”.
Veniva in particolare osservato come la Consulta avesse delimitato il proprio scrutinio al solo aspetto del possibile contrasto con il sistema dei valori costituzionali della durata fissa decennale delle pene accessorie fallimentari senza esaminare il tema della loro automatica applicazione nel caso concreto in dipendenza del giudizio di responsabilità, tema non demandato dall’ordinanza di rimessione oltre ad essere richiamati i principi già affermati dalla propria giurisprudenza, osservandosi che la determinazione del trattamento punitivo per la commissione di fatti costituenti reato è materia riservata alla discrezionalità del legislatore, secondo la previsione dell’art. 25 Cost., comma 2, il cui potere di intervento resta soggetto al sindacato di costituzionalità nei limiti in cui le scelte operate sul fronte sanzionatorio siano palesemente irragionevoli perchè comportanti l’inflizione di pene, caratterizzate da manifesta sproporzione rispetto alla gravità del fatto illecito e perciò in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. ed in specie con la funzione rieducativa della pena tenuto conto altresì del fatto che, per scongiurare tale frizione, il legislatore ricorre normalmente alla previsione di pene rimesse nella loro misura alla determinazione giudiziale da individuarsi in via discrezionale tra una soglia minima ed una massima e secondo i criteri orientativi dettati dagli artt. 133 e 133-bis c.p. in grado di assicurare la differenziazione e l’individualizzazione del trattamento sanzionatorio rispetto al fatto ed al suo autore mentre, al contrario, le pene di entità quantitativa fissa, stabilita per legge, possono essere coerenti col sistema costituzionale a condizione che l’analisi strutturale della fattispecie dimostri la loro proporzione rispetto ai comportamenti tipizzati, riconducibili alla fattispecie di reato.
Oltre a questo, si rimarcava il fatto che la verifica condotta in base ai superiori principi aveva indotto il giudice costituzionale a negare che in linea di principio la durata unica e fissa delle pene accessorie, previste dalla L. Fall., art. 216, u.c., sia compatibile con i principi costituzionali di proporzionalità e di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio atteso che, nella conformazione strutturale della norma incriminatrice dell’art. 216, era stata riscontrata l’inclusione di una serie di fattispecie tipiche di diverso disvalore sul piano astratto che si riflette nelle differenziate previsioni delle relative pene principali, nonchè una pluralità di comportamenti illeciti compresi nell’ambito delle singole ipotesi di reato, contraddistinti da diversificata gravità in dipendenza delle modalità di aggressione del bene giuridico tutelato posto che, a fronte di siffatta varietà di condotte incriminate, il sistema di pene accessorie di identica durata, stabilito in termini indifferenti rispetto alla “qualificazione astratta del reato ascritto all’imputato (ai sensi dello stesso art. 216, comma 1, comma 2 o del comma 3) e quale che sia la gravità concreta delle condotte costitutive di tale reato”, nonchè alla ricorrenza o meno degli elementi circostanziali, aggravanti o attenuanti, di cui alla L. Fall., art. 219, incidenti sulla commisurazione delle pene principali, genera “risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso (…) rispetto ai fatti di bancarotta fraudolenta meno gravi”, comportando una penalizzante limitazione dei diritti fondamentali del condannato per la protrazione per dieci anni della possibilità di svolgere determinate attività lavorative, che interviene dopo avere già espiato la pena principale ed anche quando la esecuzione di questa sia in concreto avvenuta mediante accesso a misure alternative alla carcerazione, che finiscono per risultare meno afflittive delle sanzioni accessorie.
Orbene, le Sezioni Unite rammentavano che a fronte di ciò, ossia al riscontrato vulnus ai principi costituzionali di eguaglianza e della funzione rieducativa della pena, la Corte costituzionale avesse inteso porre rimedio mediante una soluzione che supera il precedente arresto, espresso nella sentenza n. 134 del 2012, pur nel garantito rispetto delle prerogative del legislatore evidenziandosi al contempo come fosse rimasta senza seguito la sollecitazione rivolta al legislatore con la citata pronuncia del 2012 ad intervenire con una riforma organica del sistema delle pene accessorie che le rendesse coerenti col principio di cui all’art. 27 Cost., comma 3 avendo la Consulta riscontrato la vistosa sproporzione del trattamento punitivo previsto dalla L. Fall., art. 216, u.c., anche in assenza della individuazione da parte del giudice rimettente di altra disposizione di legge, da prendere in considerazione quale elemento comparativo ed esercitato il proprio potere correttivo della disposizione di legge riconosciuta incostituzionale con la sostituzione del trattamento punitivo in essa previsto sulla base del riscontro di “precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo”, intesi quali “soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata” secondo le indicazioni esegetiche offerte dalla precedente sentenza n. 236 del 2016.
In coerenza con siffatto criterio, pertanto, erano stati rintracciati, nello stesso corpo normativo che delinea i reati fallimentari, i necessari punti di riferimento per condurre l’operazione additiva imposta dall’esigenza di rimuovere la previsione incostituzionale senza privare il sistema normativo dello strumento di tutela degli interessi coinvolti individuandoli nelle disposizioni di cui alla L. Fall., artt. 217 e 218 che incriminano le fattispecie di bancarotta semplice e di ricorso abusivo al credito e prevedono le stesse pene accessorie dell’art. 216, u.c. ma con durata stabilita discrezionalmente dal giudice sino ad un massimo di due anni per il primo reato e di tre anni per il secondo.
In conseguenza di ciò, era stato quindi trasposto all’interno dell’art. 216 la medesima formulazione della determinazione delle sanzioni accessorie sino al limite massimo di dieci anni in base ad una valutazione operata caso per caso e disgiunta da quella di commisurazione della pena principale, da ancorare al diverso carico di afflittività ed alla diversa finalità di ciascuna sanzione, che può comportare anche una loro durata maggiore in ragione della funzione, in parte distinta e più marcatamente orientata verso la prevenzione speciale, che il legislatore del 1942 vi aveva assegnato e dunque la Corte costituzionale aveva respinto la diversa opzione, suggerita nell’ordinanza di rimessione, del ricorso al criterio residuale, già esistente nel sistema e dettato dall’art. 37 c.p., di ancorare la durata delle sanzioni accessorie fallimentari all’entità della pena principale della reclusione in quanto questa soluzione avrebbe finito per sostituire un diverso automatismo a quello legale, reputato incostituzionale, con effetti distonici rispetto all’intento del legislatore storico di punire severamente gli autori di delitti di bancarotta che sono considerati gravemente lesivi degli interessi individuali e collettivi al buon funzionamento del sistema economico.
A conclusione del proprio percorso argomentativo si rappresentava l’esigenza di avvertire “la valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento spetta al giudice del processo principale, unico competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l’incidente di costituzionalità”.
Terminata la disamina di quanto enunciato dal giudice delle leggi su tale questione, si faceva presente come la giurisprudenza di legittimità, nelle pronunce immediatamente successive alla declaratoria d’incostituzionalità della L. Fall., art. 216, u.c., avesse rivelato l’emersione di due orientamenti contrapposti quanto agli effetti ed alle modalità di reazione alla sentenza della Corte costituzionale.
Difatti, i primi interventi in ordine cronologico della Suprema Corte (Sez. 5, n. 1963 del 07/12/2018, dep. 2019, omissis; Sez. 5, n. 1968 del 07/12/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 274228) avevano affermato che “le pene accessorie previste per il reato di bancarotta fraudolenta a norma della L. Fall., art. 216, u.c., nella formulazione derivata dalla sentenza costituzionale n. 222 del 2018, devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla disciplina di cui all’art. 37 c.p.” e gli ermellini, per addivenire a tale conclusione giuridica, si erano avvalsi dei seguenti argomenti: a) la circoscrizione della ratio decidendi della pronuncia n. 222 del 2018 al solo profilo della durata fissa sino a dieci anni delle pene accessorie di cui alla L. Fall., art. 216, u.c., che non implica necessariamente, perchè non da essa dipendente e non vincolante, la prospettiva interpretativa dell’inapplicabilità alle medesime pene della regola generale di cui all’art. 37 c.p.; b) in ordine alla durata delle sanzioni accessorie previste dalla L. Fall., artt. 217 e 218, le cui disposizioni sono state valorizzate quale elemento di comparazione per desumere l’elemento integrativo col quale rimediare alla parziale illegittimità costituzionale della norma scrutinata, la consolidata lezione interpretativa, offerta dalla Corte di Cassazione, ne equipara la durata a quella della pena principale, in quanto, essendo stabilita solo nel massimo, resta soggetta alla regola di cui all’art. 37 c.p. (ex multis: Sez. 5, n. 15638 del 05/02/2015; Sez. 5, n. 23606 del 16/02/2012; Sez. 5, n. 13579 del 02/03/2010; Sez. 5, n. 17690 del 18/02/2010; Sez. 5, n. 4727 del 15/03/2000; Sez. 5, n. 2205 del 26/11/1986; Sez. 5, n. 8085 del 11/12/1975; Sez. 5, n. 690 del 16/10/1973) fermo restando che le medesime ragioni di soggezione alla disciplina dettata dall’art. 37 c.p. vennero ritenute estensibili anche alle pene previste dall’art. 216, u.c. nel testo modificato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018, che non può considerarsi legge speciale da applicarsi in deroga al principio generale; c) viene richiamata la soluzione conforme offerta dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 6240 del 27/11/2014, seguita in modo quasi unanime dalle successive pronunce delle Sezioni semplici, per la quale rientrano nel novero delle pene accessorie di durata non espressamente determinata dalla legge penale quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale, ovvero uno soltanto di tali limiti, mentre ne sono escluse solo le pene accessorie perpetue e quelle temporanee stabilite in misura precisa dal legislatore, con la conseguenza che la loro durata deve essere uniformata dal giudice, ai sensi dell’art. 37 c.p., a quella della pena principale; d) si avverte come incongruente e foriera di possibili conseguenze pregiudizievoli in malam partem in danno dell’imputato l’interpretazione che, sganciando la commisurazione della pena accessoria da quella della pena principale, finisce per consentire il superamento della durata della prima rispetto a quella della seconda.
Posto ciò, si evidenziava come l’ordinanza di rimessione della Quinta Sezione, cui erano seguite altre pronunce conformi che, nel richiamarne il percorso argomentativo, avevano disposto nei medesimi termini l’annullamento delle sentenze impugnate con rinvio al giudice di merito per la rinnovata determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari sul presupposto della sopravvenuta illegalità delle medesime per effetto dell’integrazione del testo della disposizione di legge che le prevede, operata dalla Consulta, (Sez. 5, n. 4780 del 20/12/2018; Sez. 5, n. 5882 del 29/01/2019; Sez. 5, n. 5514 del 18/01/2019; Sez. 5, n. 6115 del 14/12/2018), avessero invece sposato la tesi opposta e ripudiato l’affermazione della necessaria correlazione temporale tra pena principale e pena accessoria avendo basato il proprio assunto in primo luogo sulla necessità, già suggerita dalla riflessione della giurisprudenza di legittimità civile, di considerare la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 222 del 2018 mediante la lettura integrata di dispositivo e motivazione tenuto conto altresì del fatto che, sulla base di tale premessa, era stato osservato come la pronuncia di incostituzionalità, nel condurre la ricerca del referente normativo da utilizzare per l’integrazione della disposizione incostituzionale, avesse offerto chiare indicazioni interpretative nel senso di escludere l’operatività della regola dettata dall’art. 37 c.p. in riferimento alle pene accessorie della legge fallimentare.
Secondo l’ordinanza di rimessione, tra l’altro, la riconduzione della nuova formulazione della L. Fall., art. 216, u.c., nell’ambito di applicazione dell’art. 37 c.p., non è compatibile con il pronunciamento del giudice costituzionale e, pertanto, al riconoscimento del potere del giudice, chiamato a prendere cognizione dei reati fallimentari, di determinare in autonomia l’entità della pena accessoria rispetto alla commisurazione della pena principale e facendo ricorso ai criteri di cui all’art. 133 c.p., può pervenirsi attraverso due alternative ermeneutiche possibili, ossia: la rivisitazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6240 del 2015, oppure la sottrazione alla disciplina dettata dall’art. 37 c.p. delle specifiche pene accessorie della L. Fall., art. 216 nel testo riformulato dalla Corte costituzionale e, di conseguenza, a tale scopo era stato sollecitato l’intervento risolutore delle Sezioni Unite.
Così definito il tema del contrasto giurisprudenziale, si osservava come formalmente la pronuncia di incostituzionalità in esame avesse colpito soltanto la L. Fall., art. 216, u.c. e limitatamente al solo profilo di fissa quantificazione delle sanzioni ivi previste, demandando al giudice ordinario la scelta del relativo criterio commisurativo nel rispetto del solo limite invalicabile di durata decennale sicchè esse potrebbero essere tuttora legittimamente determinate secondo la disciplina dettata dall’art. 37 c.p. norma che ha conservato la propria perdurante esistenza ed efficacia prescrittiva visto che la Consulta aveva scelto di non estendere il proprio potere di scrutinio di legittimità costituzionale, conferitole dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 27, anche alla disposizione da ultimo citata, non ravvisandovi il nesso di consequenzialità rispetto all’art. 216.
Tuttavia, il Supremo Consesso riteneva come non potesse ignorarsi l’autorevolezza e la capacità persuasiva del suggerimento interpretativo offerto dal giudice costituzionale in coerenza con la funzione di normazione additiva esercitata là dove aveva escluso che la previsione dell’art. 37 c.p., come letta dal diritto vivente sino al momento attuale, potesse continuare ad essere riferita alle pene accessorie della legge fallimentare ed a sancire l’obbligatorio adeguamento della loro durata a quella della pena della reclusione, e ciò anche perché la formulazione di tale soluzione non è avulsa dal quesito rivolto al giudice costituzionale, investito da ordinanza, la cui motivazione prospetta che “L’esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio che, anzichè prevedere una ingiustificata equiparazione di situazioni profondamente differenti, renda possibile tale adeguamento individualizzato, proporzionale, delle pene inflitte con le sentenze di condanna, potrebbe, d’altra parte, in larga parte essere soddisfatta ove, eliminandosi il riferimento alla misura fissa di dieci anni, rivivesse la regola generale di cui all’art. 37 c.p.”; in altri termini, ad avviso della Corte, l’evocazione del parametro commisurativo dettato da quest’ultima norma rientra nel fascio di possibili opzioni decisorie prospettate nella questione formulata dal giudice rimettente sicchè rispetto ad essa l’espressione del parere del giudice delle leggi si mantiene nell’ambito della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancita dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
Preso atto di ciò, le Sezioni Unite, pur nella consapevolezza della non obbligatoria conformazione alle indicazioni del giudice costituzionale, perchè non di matrice legislativa, tuttavia stimavano di dovervi aderire in quanto conformi ai precetti costituzionali ed avvalorate dall’interpretazione letterale-logico-sistematica.
In particolare, una volta rilevato che il codice penale, dopo la parte dedicata alle pene principali, incidenti in senso proprio sulla libertà personale dell’imputato, al capo III, titolo II, libro I prevede le pene accessorie la cui caratteristica peculiare consiste nel limitare la capacità giuridica individuale nell’esercizio di diritti, poteri, attività e funzioni e che nella visione del legislatore del 1930 assolvono ad una funzione complementare rispetto alle sanzioni principali in quanto, secondo la Relazione ministeriale al progetto definitivo, che dà conto dei lavori preparatori, “non posseggono una efficienza tale, per cui possano riuscire, per sè medesime, sufficienti a realizzare gli scopi intimidativi ed afflittivi della repressione” e dalla loro insufficienza punitiva discende la necessità dell’applicazione congiunta ad altre sanzioni, cui appunto accedono, rivelando la astratta posizione ancillare dal punto di vista sistematico sin dalla loro denominazione e una volta fatto presente che, per espressa indicazione normativa, rinvenibile nell’art. 20 c.p., esse sono considerate appartenere alla più ampia categoria degli effetti penali della condanna, cui “conseguono di diritto” la cui concreta individuazione della misura applicabile al soggetto condannato quale pena accessoria costituisce operazione agevole quando sia il legislatore a definirla direttamente tale in disposizione codicistica o in testi di legge speciale, in difetto dei quali va condotta in base alla natura della sanzione in dipendenza della sua capacità afflittiva e del finalismo cui è orientata, si denotava che il sistema penale riflette il principio di fondo dell’automatismo applicativo che ispira tutta la regolamentazione delle pene accessorie traendosi conferma da ciò dalla formulazione dello stesso art. 20 c.p. che, nel contrapporre il meccanismo di determinazione giudiziale discrezionale introdotto per le pene principali, stabilisce “quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa”.
Tal che se ne faceva conseguire come le locuzioni del testo normativo esprimano già di per sè il ripudio e la sfiducia in un intervento cognitivo rimesso al libero convincimento del giudice, sia sull’an dell’applicazione, che sul quomodo e sul quantum della durata della pena accessoria sottratto alla commisurazione individualizzata e correlata al caso di specie, al punto da avere autorizzato giurisprudenza e dottrina ad esentare il giudice da espressa inflizione e motivazione al riguardo, rimediabile quanto al primo aspetto in sede di esecuzione mentre, soltanto in casi limitati e residuali, previsti dall’art. 32 c.p., comma 3, e art. 36 c.p., comma 2 e comma 3, oltre che da altre disposizioni della legislazione speciale, è rimessa al giudice la scelta circa l’inflizione della sanzione accessoria o la determinazione delle relative modalità attuative fermo restando che il medesimo criterio dell’automatismo permea anche la disciplina legale della determinazione della durata delle pene accessorie, per lo più di tipo temporaneo e solo in via di eccezione perpetue, basato su rigidi parametri legislativi.
Dedotto ciò, si evidenziava inoltre come la regolamentazione originaria delle pene accessorie avesse subito successivi interventi di modifica, numericamente limitati e dai contenuti poco incisivi sul piano qualitativo perchè riguardanti l’ampliamento dello strumentario delle sanzioni e dei loro effetti, ma non il procedimento applicativo e commisurativo, che non sono stati sottoposti a revisione critica sul piano dogmatico e, in tale senso, si segnalavano da parte della Corte: la L. 24 novembre 1981, n. 689, introduttiva di nuove disposizioni in materia di pene accessorie, nonchè la L. 7 febbraio 1990, n. 19, che all’art. 4 ha riformulato l’art. 166 c.p. ed all’art. 7 ha abrogato l’art. 175 c.p., comma 4, eliminando il divieto di applicazione alle pene accessorie dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna. Ulteriore parziale modifica della disciplina delle sanzioni in esame è stata apportata con il codice di rito del 1988, che all’art. 217 disp. att. c.p.p. ha soppresso la previsione della loro applicazione provvisoria, già contenuta nell’art. 140 c.p. ed in ogni altra disposizione di legge ed all’art. 445 c.p.p. ha escluso dalla sottoposizione a pene accessorie l’imputato che chieda ed ottenga di definire il processo col rito alternativo dell’applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..
Recependo la generalizzata invocazione degli interpreti di un riassetto normativo della materia per adeguarla ai mutamenti sociali ed economici verificatisi nel paese dall’introduzione del codice Rocco ed alla sempre più incisiva afflittività delle sanzioni complementari che, grazie ai meccanismi di espiazione della pena detentiva in forma alternativa alla carcerazione, possono risultare le uniche ad essere realmente subite dal condannato ed a comprimere la sua sfera giuridica in aspetti fondamentali, assistiti da tutela costituzionale, si faceva altresì presente come i susseguitisi progetti di riforma del codice penale avessero elaborato varie soluzioni che non avevano però ricevuto positivo accoglimento da parte del legislatore così come del pari non era stata ottemperata la delega che era stata conferita al Governo con la L. 23 giugno 2017, n. 103 perchè intervenisse, seppur in riferimento all’ordinamento penitenziario, con una riforma della disciplina delle pene accessorie in grado di rimuovere gli ostacoli al reinserimento sociale del condannato e di scongiurare l’effetto del superamento della loro durata rispetto a quella della pena principale mentre la recente L. 9 gennaio 2019, n. 3 aveva viceversa operato un mero intervento settoriale in riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e, in un quadro di modifiche volte all’inasprimento sanzionatorio, aveva apportato novità sul piano sostanziale e processuale con un aggravamento del regime punitivo e con misure volte a consolidare nel tempo gli effetti delle pene accessorie limitando i requisiti di accesso alla riabilitazione ed escludendo dalla sua applicazione alcune pene, oltre che prevedendone l’irrogazione anche in caso di definizione del processo con sentenza di patteggiamento o nei confronti di condannati a pena condizionalmente sospesa, che però hanno mantenuto immutato l’impianto originario codicistico.
Rilevato ciò, i giudici di piazza Cavour sottolineavano come uno degli aspetti più problematici e controversi, che l’attuale regolamentazione delle pene accessorie pone, attiene alla determinazione della loro durata evidenziandosi al riguardo, da un lato, che l’art. 37 c.p. prevede che “quando la legge stabilisce che la condotta importa una pena accessoria temporanea e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato”, dall’altro, che se è pacifico che sono esclusi dalla soggezione a siffatta regola equiparativa i casi più semplici in cui la legge stabilisce direttamente la durata perpetua della pena accessoria, come prescrivono l’art. 29 e l’art. 317-bis c.p. per l’interdizione dai pubblici uffici (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017; Sez. 5, n. 33150 del 30/03/2018), oppure la sua temporanea protrazione per un periodo unico ed invariabilmente fisso, ad esempio nel caso di cui all’art. 512 c.p., altrettanto agevole è ricondurvi le ipotesi in cui nella norma sia assente ogni indicazione temporale, prevedendo essa soltanto la tipologia di pena da infliggere, come accade per alcune delle ipotesi previste dall’art. 609-nonies c.p., è, invece, discussa l’individuazione del significato da attribuire al riferimento a pena “non espressamente determinata“, presupposto per l’attuazione concreta della prescrizione, in tutte le altre situazioni in cui, specie in ambiti trattati dalla legislazione speciale, la legge si limita a stabilire un limite minimo ed altro massimo di durata con un possibile intervallo compreso tra i due estremi, oppure una sola soglia temporale insuperabile ed una protrazione non inferiore o non superiore a tale soglia.
Su tale questione, gli ermellini facevano presente come fossero rinvenibili due contrapposte opinioni.
La prima, sostenuta, sia dalla giurisprudenza di legittimità assolutamente maggioritaria, sia in dottrina, riconosce l’espressa determinazione normativa quando il legislatore stabilisca in modo concreto e preciso la durata della pena, mentre in tutti gli altri casi in cui sono specificati il minimo e il massimo, ovvero solo il minimo o solo il massimo, la sua quantificazione resta soggetta alla regola dell’art. 37 c.p. con automatica e rigida conformazione alla pena principale inflitta (Sez. 3, n. 8041 del 23/01/2018; Sez. 3, n. 20428 del 02/04/2014; Sez. 5, n. 29780 del 30/06/2010; Sez. 3, n. 41874 del 09/10/2008; Sez. 1, n. 19807 del 22/04/2008; Sez. 5, n. 4727 del 15/03/2000).
La contraria soluzione, meno affermata, esclude l’applicazione dell’art. 37 c.p. quando la pena accessoria è indicata con la previsione di un minimo o di un massimo giacchè anche in tal caso la pena accessoria deve considerarsi espressamente stabilita dalla legge, che demanda al giudice di dosarne la protrazione temporale, facendo ricorso ai parametri di cui all’art. 133 c.p. (Sez. 6, n. 697 del 03/12/2013, dep. 2014; Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013; Sez. 3, n. 42889 del 15/10/2008; Sez. 3, n. 25229 del 17/04/2008; Sez. 3, n. 42889 del 15/10/2008; Sez. 5, n. 759 del 21/09/1989).
Nel contrasto tra i due orientamenti, si evidenziava oltre tutto come si fosse inserita la pronuncia delle Sezioni Unite, n. 6240 del 27/11/2014 che, chiamata a dirimere una divergenza interpretativa in ordine ai poteri del giudice dell’esecuzione di rilevare, dopo la formazione del giudicato di condanna, l’illegalità della pena accessoria applicata extra o contra legem in sede di cognizione, aveva offerto risposte ermeneutiche anche al tema coinvolto nel presente procedimento; nel dettaglio, in questo arresto giurisprudenziale, era stato riconosciuto che, per il disposto dell’art. 183 disp. att. c.p.p. ed in coerenza con i limitati poteri del giudice dell’esecuzione, cui compete dare attuazione al comando giudiziale irrevocabile, interpretandolo ed integrandolo, senza poterlo esprimere, nemmeno in riferimento al trattamento sanzionatorio, l’illegalità della pena accessoria può essere rilevata a condizione che “essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione” e, nella conseguente ricognizione delle tipologie di pena accessoria che ammettono il riconosciuto intervento emendativo in fase esecutiva in assenza di apprezzamento discrezionale, le Sezioni Unite vi avevano incluso anche le ipotesi previste dall’art. 37 c.p. e avevano affrontato il nodo interpretativo posto da quest’ultima disposizione, aderendo all’indirizzo maggioritario, fermo restando che, a sostegno di tale soluzione, era stato evidenziato che: 1) l’esegesi letterale della disposizione in esame induce a riconoscere come “espressamente determinata” soltanto la pena che sia stata fissata precisamente dal legislatore nella specie e nella durata senza lasciare nessuno spazio per una commisurazione discrezionale del giudice; a riprova si indica la formula lessicale prescelta dal legislatore, che “non adopera le preposizioni “da” “a”, cui ordinariamente ricorre nell’indicare la pena principale per i reati, ma sempre le parole “non inferiore” e “non superiore” oppure “fino a”“, sicchè “non può parlarsi neppure di uno “spettro”, di una “forbice” o di un “intervallo” edittale“; 2) conferma ulteriore è desumibile dall’art. 183 disp. att. c.p.p. che consente di rimediare, in sede esecutiva, in malam partem, alla omissione dell’applicazione di una pena accessoria, sempre che sia “predeterminata nella specie e nella durata“; 3) ulteriore argomento testuale, che avvalorerebbe l’orientamento accolto, veniva rintracciato nell’inciso finale del medesimo art. 37 c.p. secondo cui “in nessun caso può oltrepassarsi il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria” che sarebbe superfluo qualora il principio della uniformità temporale tra pena principale e pena accessoria, sancito dalla norma, non dovesse rispettarsi nelle ipotesi di indicazione di un minimo o di un massimo della durata di ciascuna specie di pena accessoria; 4) la collocazione sistematica della norma alla fine del Capo III del Titolo II del Libro I del codice penale indica la funzione dell’art. 37 c.p. quale disposizione generale e di “chiusura” applicabile in ogni situazione in cui difetti una precisa indicazione quantitativa della pena accessoria da applicare.
Le Sezioni Unite, alla luce di tali argomentazioni, avevano quindi offerto ulteriori spunti di riflessione sul tema avendo rinvenuto argomenti a conferma dell’indirizzo recepito nella già citata sentenza n. 134 del 2012 con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, u.c., sollevate in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. nonchè degli artt. 27 e 41 Cost., declinando di apportare l’addizione normativa richiesta dai giudici rimettenti mediante l’aggiunta delle parole “fino a” al testo della L. Fall., art. 216, u.c., al fine di rendere applicabile l’art. 37 c.p..
Proseguendo la disamina delle pronunce emesse dalla Suprema Corte in subiecta materia, si notava come la successiva evoluzione delle linee interpretative emerse nella giurisprudenza di legittimità mostrasse un prevalente allineamento ai principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6240 del 2015; in particolare, in riferimento alla sanzione accessoria prevista per i reati tributari dal D.Lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12, era stato affermato il principio di uniformazione temporale alla durata della pena principale inflitta dalla Sez. 3, n. 8041 del 23/01/2018 che, in contrasto con la sentenza Sez. 3, n. 4916 del 14/07/2016, aveva ribadito l’adesione ai principi delle Sezioni Unite n. 6240 del 2015 fermo restando che il medesimo principio era stato espresso per la pena accessoria comminata solo nel massimo dal D.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85 (Sez. 3, n. 36869 del 28/06/2016; Sez. 3, 19964 del 14/12/2016).
Oltre a ciò, si faceva presente come alla stessa soluzione fossero approdate le pronunce occupatesi delle pene accessorie per i reati previsti dal codice penale in materia di violenza sessuale: rispetto alle previsioni dell’art. 609-nonies c.p., comma 1, n. 4), che distingue l’interdizione temporanea dai pubblici uffici dall’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque anni, è stato affermato che, nella prima ipotesi, in cui la pena accessoria non presenta durata espressamente determinata dalla legge penale, il giudice deve equipararla a quella della pena principale ai sensi dell’art. 37 c.p. (Sez. 3, n. 40679 del 01/07/2016) così come sulla stessa linea interpretativa si erano collocate le pronunce in tema di reati fallimentari e relative pene accessorie: in riferimento alla fattispecie di bancarotta semplice documentale, essendo stato affermato che, tenuto conto che la pena accessoria prevista dalla L. Fall., art. 217, u.c. è determinata solo nel massimo e fino a due anni, essa deve determinarsi in una durata eguale a quella della pena principale inflitta, ai sensi dell’art. 37 c.p. (Sez. 5, n. 50499 del 4/07/2018; Sez. 5, n. 13079 del 3/12/2015; Sez. 5, n. 37204 del 14/04/2017; Sez. 5, n. 15638 del 5/02/2015).
Compiuta questa disamina di ordine giurisprudenziale, le Sezioni Unite ritenevano che l’indirizzo espresso dalla precedente sentenza n. 6240 del 2015 dovesse essere superato poichè gli argomenti addotti a sostegno della soluzione proposta, – che solo incidentalmente ed a livello esemplificativo si era occupata del tema della durata delle pene accessorie prescritte dalla L. Fall., art. 216, u.c., pur pregevoli, non meritavano condivisione.
L’analisi testuale, già condotta dalle Sezioni Unite, non considerava infatti che sul piano lessicale, là dove l’art. 37 c.p. menziona la pena espressamente determinata, richiede che la tecnica legislativa contempli una esplicita indicazione di estensione cronologica della sua durata che non può intendersi nel solo significato di quantificazione in misura unica, fissa, invariata ed invariabile atteso che, come evidenziato anche da alcuni interpreti in dottrina, sul piano terminologico una previsione espressa richiede una dichiarazione esternata, manifestata nel testo e quindi non implicita o sottintesa ed a tale definizione corrisponde anche la previsione di una sanzione da determinare entro un intervallo compreso tra minimo e massimo edittale o in entità non inferiore o non superione ad uno solo dei due estremi così come non è condivisibile nemmeno l’osservazione che valorizza l’inserimento nel testo delle singole disposizioni che stabiliscono le pene accessorie dell’espressione “fino a“, o della previsione di un unico limite invalicabile al di sotto o al di sopra del quale non è consentito modulare l’entità della sanzione, come caratteristico della tecnica legislativa riferita alle sole pene complementari poiché, anche volendo arrestare la disamina alle sole norme incriminatrici codicistiche, si riscontra come questa sia la modalità di formulazione usuale e tipica delle disposizioni che descrivono le fattispecie penali di minore gravità per le quali le sanzioni detentive e/o pecuniarie sono contenute in modo da non superare rispettivamente i due-tre anni e qualche migliaio di Euro, anche se non mancano casi di alcuni delitti di maggiore gravità, per i quali si è adottata la medesima scelta lessicale.
Si evidenziava tra l’altro come la medesima tecnica espressiva fosse riscontrabile nelle disposizioni che incriminano le fattispecie contravvenzionali quando siano punite con la pena principale detentiva dell’arresto, previsto sino ad un tetto massimo o in misura non inferiore ad una soglia minima, sicchè il criterio esegetico basato sul testo e sulla formulazione terminologica non appare risolutivo e non consente di negare che in tali situazioni per volontà legislativa il trattamento punitivo sia graduabile nell’ambito di un intervallo compreso tra due estremi opposti ed invalicabili.
Posto ciò, non si riteneva altresì conferente ed utile all’analisi condotta nemmeno il richiamo all’art. 183 disp. att. c.p.p. atteso che, ad avviso della Corte, questa disposizione, sul piano sistematico collocata in un differente contesto, quello dell’esecuzione penale, assolve ad una funzione differente, che prescinde dal meccanismo di quantificazione legale della pena accessoria ma appresta uno strumento integrativo ed emendativo dell’error in iudicando contenuto nella sentenza di condanna per effetto dell’omessa applicazione della pena stessa, pur doverosa, strumento la cui attivazione si è consentita in via interpretativa anche per l’ulteriore scopo di correggere profili di illegalità del giudicato a presidio della costante conformità alla legge del trattamento punitivo sino ai suoi aspetti complementari senza non considerare poi il fatto che la circostanza secondo la quale la norma ripeta, variandola, la locuzione “determinata dalla legge“, rinvenibile anche nell’art. 37 c.p., cui aggiunge la specificazione “nella specie e nella durata“, non apporta alcun contributo valorizzabile, nè contenutistico, nè definitorio, in grado di offrire argomenti alla lettura proposta dalla sentenza n. 6240 del 2015, posto che la nozione di specie di pena accessoria rimanda all’elencazione dell’art. 19 c.p. senza descrivere nulla di più e senza poter orientare la soluzione del quesito ermeneutico che si sta affrontando.
Tal che se ne faceva discendere che la considerazione sul piano lessicale, teleologico e sistematico convince dell’irrilevanza del raffronto comparativo tra la norma dell’art. 183 citato e l’art. 37 c.p. poichè entrambe pongono e non risolvono sul piano dell’immediata disciplina positiva la medesima problematica dell’individuazione di cosa s’intenda per determinazione legale della durata della pena accessoria.
Pure l’ulteriore argomento letterale, tratto dall’ultima proposizione dell’art. 37 c.p., che impone il rispetto in tutti i casi del limite minimo e di quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria, non veniva ritenuto atto a confermare l’applicabilità dello stesso art. 37 in dipendenza della mancata determinazione per legge della durata quando la stessa sia prevista con riferimento agli estremi edittali, individuati nella singola norma incriminatrice posto che questa lettura dell’inciso non è l’unica possibile per riconoscere l’utilità e l’autonoma portata precettiva della previsione, altrimenti superflua mentre, al contrario, essa impartisce un criterio commisurativo che assicuri il mancato superamento dei limiti di durata indicati in linea generale dal codice penale agli artt. 28-36 per ciascuna specie di pena accessoria sul presupposto che la singola fattispecie, inserita nello stesso codice o nelle leggi speciali, non li contempli.
Anche per quel che riguarda la collocazione sistematica dell’art. 37 c.p. a conclusione delle altre disposizioni sulle pene accessorie, se stimata confermativa dell’intento di approntare una norma di chiusura che completi il quadro normativo dedicato alle sanzioni complementari, non veniva ritenuta un’argomentazione che potesse consentire di addivenire alla conclusione rassegnata dalla sentenza n. 6240 del 2015 e ad elevarne la disciplina al rango di regola generale in quanto quello previsto costituisce un meccanismo decisorio, suscettibile di fornire soluzione pratica di immediata attuazione anche per la futura introduzione di nuove ipotesi di pena accessoria, prive di previsioni sanzionatorie, a fronte di un sistema codicistico che nella sua parte generale contiene per ciascuna pena un proprio regolamento edittale e la gamma di criteri orientativi a guidare l’operato del giudice, stabiliti dagli artt. 132 e 133 c.p. mentre, come segnalato da attenta dottrina, la formulazione dispositiva di questi articoli non contiene nessun riferimento letterale che consenta di escludere dall’ambito di applicazione le pene accessorie e di privilegiare l’opposto meccanismo quantificativo dettato dall’art. 37 visto che l’art. 132 c.p. menziona soltanto l’attività del giudice che “applica la pena discrezionalmente” senza aggiungere altre qualificazioni sul tipo di pena e l’art. 133 c.p. indica criteri logici non riferibili soltanto a quelle principali.
Di talchè se ne faceva discendere la conclusione secondo cui la regola della equiparazione meccanica della durata della pena accessoria a quella della pena principale in concreto inflitta assume piuttosto una funzione residuale cui fare ricorso nei casi in cui la legge in astratto sia priva di qualsiasi indicazione sul profilo temporale che circoscriva e guidi l’esercizio del potere dosimetrico del giudice.
Inoltre, sempre ad avviso del Collegio, la riflessione esegetica sul tema in esame non può prescindere dalla considerazione che la decisione da assumere interviene all’esito di un diverso pronunciamento del giudice costituzionale che, innestandosi su un orientamento esplicitato nella sentenza n. 236 del 21/09/2016 in riferimento alla fattispecie di reato di cui all’art. 567 c.p., comma 2, ed allo specifico carico sanzionatorio in essa previsto, sull’identico quesito, già esaminato con la citata sentenza n. 143 del 2012, ha mutato radicalmente posizione ed il quadro degli orizzonti esegetici e, pertanto, se, quindi, nella pronuncia della Corte costituzionale n. 134 del 2012 “vi era l’implicito riconoscimento che la soluzione indicata dai giudici rimettenti (una delle possibili), è cioè con l’aggiunta alla disposizione normativa delle parole “fino a”, avrebbe reso possibile l’applicazione dell’art. 37 c.p.”, la netta opzione di disfavore per l’automatismo punitivo sotto l’aspetto dosimetrico riferito alle pene accessorie, espresso nella sentenza n. 222 del 2018, ad avviso della Corte, priva la soluzione in precedenza assunta dalle Sezioni Unite del suo referente sul piano dell’ermeneutica costituzionale e tanto autorizza una lettura alternativa dell’art. 37 c.p., che tenga conto dell’evoluzione maturata negli ultimi decenni nell’interpretazione del trattamento sanzionatorio e della sua funzione.
Detto questo, il Supremo Consesso osservava come la giurisprudenza costituzionale sin dagli anni sessanta del secolo scorso (sentenze n. 67 del 1963 e n. 104 del 1968) avesse posto in evidenza che i principi costituzionali, quello generale di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. e quelli, specificamente riferiti alla materia penale, di legalità, di personalità della responsabilità e della finalità rieducativa della pena, dettati dagli artt. 25 e 27 Cost., possono ricevere attuazione nella legislazione ordinaria mediante previsioni sanzionatorie caratterizzate da “mobilità” della pena che si realizza attraverso la prescrizione quantitativa, compresa tra un minimo ed un massimo, e sul piano applicativo esigono l’intervento commisurativo giudiziale, riferito al caso specifico, che traduce la regolamentazione astratta nell’inflizione di una pena scelta in via discrezionale nell’ambito dei due estremi, individualizzata e proporzionata alle caratteristiche della fattispecie concreta in base ai parametri di cui all’art. 133 c.p..
Pertanto, raffrontata con i superiori principi, che pretendono elasticità nella previsione astratta e discrezionalità nella sua attuazione in riferimento alla situazione fattuale concreta, “ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (di qualunque ne sia la specie) è per ciò solo “indiziata” di illegittimità” (Corte Cost., n. 222 del 2018) ed ogni automatismo sanzionatorio, che sottragga alla giurisdizione il compito di apprezzare la specificità del caso e di offrirvi risposta adeguata e differenziata, va scongiurato perchè in contrasto con il “volto costituzionale” della repressione penale e con la funzione rieducativa e di reinserimento sociale della punizione che richiede il rispetto della proporzione per qualità e quantità col fatto di reato con la sua offensività e con la personalità del suo autore, da garantire nella fase della irrogazione, così come in quella dell’esecuzione (sentenza n. 257 del 2006; in senso conforme sentenza n. 79 del 2007) così come nella medesima ottica di assicurare reazioni repressive adeguate e personalizzate devono leggersi, secondo la Corte, gli interventi demolitori del giudice costituzionale in materia penitenziaria per la quale ha riconosciuto quale criterio “costituzionalmente vincolante” l’esclusione di “rigidi automatismi” che si realizza soltanto con “una valutazione individualizzata caso per caso” (sentenza n. 436 del 1999; in senso conforme: ” (sentenza n. 257 del 2006; in senso conforme sentenza n. 79 del 2007; n. 255 del 2006, n. 189 del 2010), pena l’inammissibile sacrifico del profilo rieducativo della pena mentre indicazioni solo all’apparenza contrastanti sono rinvenibili nelle più recenti pronunce della Corte costituzionale, occupatesi della legittimità delle disposizioni di legge contenenti per specifiche figure di reato la previsione di una pena pecuniaria di entità fissa o proporzionale, congiunta a pena detentiva mobile e determinabile nell’ambito di una forbice tra minimo e massimo atteso che, nell’escludere il contrasto con i principi costituzionali, la Consulta aveva valorizzato l’assetto normativo complessivo del trattamento sanzionatorio articolato in due specie di pene ed in base di diversi criteri di commisurazione e riscontrato in tali situazioni la consentita possibilità per il giudice, quanto meno per la reclusione o l’arresto, o comunque in ragione della quantificazione proporzionale della sanzione pecuniaria, di graduare ed adattare con apprezzamento discrezionale la pena alle peculiarità della singola situazione giudicata, confermando l’orientamento ormai consolidato della illegittimità costituzionale delle sole pene stabilite in misura fissa ed invariabile, salvo che le stesse non siano introdotte per punire fattispecie di reato che, per la loro natura, manifestino lo stesso disvalore e lo stesso grado di offensività, non richiedendo quindi una graduazione di sanzione (Corte Cost., sentenza n. 233 del 2018; sentenza n. 142 del 2017; ordinanza n. 91 del 2008).
Anche il legislatore dal canto suo, evidenzia sempre il Supremo Consesso in tale arresto giurisprudenziale, nella produzione normativa postcodicistica aveva mostrato un mutato atteggiamento verso l’automatismo applicativo delle pene accessorie in contrasto con la filosofia ispiratrice l’introduzione dell’art. 37 c.p. allorchè aveva modificato l’art. 166 c.p. consentendo l’estensione della sospensione condizionale anche alle pene accessorie ed impedendone l’attuazione provvisoria in dipendenza della pronuncia di condanna non irrevocabile rilevandosi al contempo che la considerazione autonoma delle pene accessorie emerge, ad avviso degli ermellini, rafforzata dalla recente L. 9 gennaio 2019, n. 3 la quale, in un quadro di interventi volti al rafforzamento degli strumenti repressivi e preventivi dei reati contro la pubblica amministrazione, ha inciso anche sulla sottoposizione del condannato alle pene accessorie mediante, sia l’allargamento dell’area delle fattispecie che ne determinano l’applicazione, l’aggravamento della loro durata e la loro irrogazione anche nei casi di pena già espiata, pena condizionalmente sospesa e pena patteggiata, sia la distinzione dei requisiti temporali di accesso alla riabilitazione per le pene accessorie rispetto a quelli valevoli per la pena principale e l’inibizione dell’operatività su quelle di durata perpetua dell’effetto estintivo conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova.
A loro volta i principi interpretativi che si richiamano ai valori costituzionali di colpevolezza e proporzionalità e che si oppongono agli automatismi ed alla rigida regolamentazione sanzionatoria, oltre che richiamati a monito per il legislatore ordinario, che vi deve dare attuazione nella sua produzione normativa, offrono, secondo la Corte, spunti inediti per una considerazione differente e costituzionalmente orientata anche del meccanismo parificativo vincolante, previsto dall’art. 37 c.p., sotto l’unico profilo del quantum di pena accessoria irrogabile, posto che l’indefettibilità della sua applicazione discende dalla legge e dalla esplicita e testuale definizione di effetto penale della condanna in quanto i predetti principi non consentono di interpretare l’art. 37 c.p. come prescrittivo di un automatismo che, seppur mediato dall’aggancio alla misura della pena principale, questa sì stabilita in via discrezionale dal giudice, rappresenta pur sempre un sistema rigido di determinazione del trattamento punitivo che non trova giustificazione soprattutto se si considera la funzione cui assolvono le pene accessorie, l’estrema varietà delle condotte che, in violazione dei precetti penali, realizzano le condizioni per la loro inflizione ed il severo carico di afflittività che le contraddistingue mentre, secondo l’opinione più accreditata in dottrina, le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive di carattere generale e speciale, nonchè rieducative mediante la sottoposizione al trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato; invece, le pene accessorie, specie quelle interdittive ed in abilitative, collegate al compimento di condotte postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o attività, sono più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione personale, che realizzano mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi e dallo stimolo alla violazione dei precetti penali per impedirgli di reiterare reati in futuro e per sortirne l’emenda.
Ebbene, proprio alla luce di tale distinguo, si evidenziava in questo arresto giurisprudenziale come la piena realizzazione soprattutto dello specifico finalismo preventivo, cui sono preordinate le pene complementari, richieda una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale fermo restando che questo risultato è conseguibile soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell’ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla scorta di una valutazione discrezionale, che si avvalga della ricostruzione probatoria dell’episodio criminoso e dei parametri dell’art. 133 c.p. e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione mentre, al contrario, la perequazione automatica di cui all’art. 37 c.p., nella lettura che ne è stata offerta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6240 del 2015, non estesa alla considerazione della funzione svolta dalle pene accessorie e delle linee evolutive della giurisprudenza costituzionale, non consente, ad avviso della Corte, risposte individualizzate e graduate in dipendenza delle peculiarità del caso, delle esigenze specifiche ad esso sottese nonchè delle caratteristiche di afflittività delle singole sanzioni accessorie, incidenti in senso fortemente limitativo sul diritto al lavoro e sul diritto di iniziativa economica, oltre che su altri aspetti della vita individuale e sociale, e finisce per estendervi i sospetti di incostituzionalità, insiti in tutti gli automatismi punitivi.
Un ulteriore argomento, seppur meno rilevante dei precedenti, veniva ritenuto favorevole per la soluzione accolta e segnatamente, come osservato nell’ordinanza di rimessione, la considerazione secondo la quale il necessario parallelismo cronologico tra pena principale e pena accessoria presenta delle difficoltà applicative posto che, proprio nel settore dei reati fallimentari la L. Fall., art. 219, comma 1, in caso sia ritenuta sussistente la circostanza aggravante dell’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità stabilisce che la pena principale da tre a dieci anni di reclusione può essere aumentata sino alla metà, evenienza che renderebbe inoperante la regola dettata dall’art. 37 c.p. per l’impossibilità di commisurare le pene accessorie in entità superiore a dieci anni.
Oltre tutto veniva stimato altrettanto problematico il caso posto dalla L. Fall., art. 229 per il delitto di accettazione o pattuizione da parte del curatore del fallimento di retribuzione in denaro o altra forma, punito con la reclusione da tre mesi a due anni, per il quale la pena principale massima coincide con il limite minimo della pena accessoria di cui al comma 2, il che, se si facesse applicazione dell’art. 37 c.p. nei termini tradizionali, renderebbe del tutto eccezionale l’equiparazione della durata delle due sanzioni ed impossibile irrogare la pena dell’inabilitazione temporanea dall’ufficio di amministratore per un periodo superiore al minimo così come analoghe considerazioni, ad avviso della Corte, valgono in relazione alla sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ex art. 35 c.p. che indica quale limite edittale minimo la durata di quindici giorni e quale massimo due anni dato che la stessa norma dispone che la sospensione è irrogabile soltanto in caso di condanna all’arresto non inferiore ad un anno e, pertanto, applicandosi l’equiparazione automatica di cui all’art. 37, il minimo della pena accessoria sarebbe sempre di un anno, con la conseguente inutilità della previsione di una possibile durata inferiore tenuto conto altresì del fatto che difficoltà di coordinamento similari pongono anche: l’art. 544-ter c.p., che per il reato di maltrattamento di animali stabilisce la pena della reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 Euro, mentre l’art. 544-sexies c.p. consente la pena accessoria della sospensione dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento di animali da tre mesi a tre anni; la L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 1 in tema di frodi sportive, la cui pena detentiva oscilla tra un mese ed un anno di reclusione e le pene accessorie applicabili ai sensi dell’art. 5 dello stesso testo di legge non possono essere inferiori a sei mesi e superiori a tre anni; il D.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85 per il quale con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli artt. 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni, sebbene le pene detentive irrogabili per le predette fattispecie di reato possano superare la soglia massima di tre anni; il D.Lgs. n. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12, alle lett. b) e c) introduce sanzioni accessorie di durata compresa tra il minimo di un anno e massimi differenziati sino a tre e sino a cinque anni, che non trovano coincidenza con le pene detentive stabilite per le ipotesi di reato di cui agli artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater, 11 dello stesso D.Lgs., per le quali il minimo edittale è fissato in sei mesi, per cui l’irrogazione di sanzione detentiva nel minimo assoluto non potrebbe comportare l’automatica perequazione di quelle accessorie ai sensi dell’art. 37 c.p. per la conseguente illegalità per difetto della loro durata.
Orbene, a fronte di ciò, si faceva presente come tutti gli inconvenienti segnalati trovassero, invece, agevole soluzione qualora si ammetta che le rispettive sanzioni accessorie sono determinabili dal giudice anche in entità svincolata da quella della reclusione o dell’arresto.
Le Sezioni Unite, pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, ritenendo di dover superare il proprio precedente arresto, espresso nella sentenza n. 6240 del 2015, formulavano il seguente principio di diritto: “Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p.“.
Conclusioni
La sentenza in commento è sicuramente condivisibile in quanto provvista di una motivazione fondata su articolate e ben argomentate considerazioni giuridiche.
Nel rinviare quindi a quanto enunciato in tale pronuncia, lo scrivente si limita unicamente a rilevare che il principio di diritto ivi formulato secondo cui le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p. sembra porsi in perfetta sintonia con quanto postulato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 222 del 25/09/2018 , nella parte in cui è stato postulato che essenziale a garantire la compatibilità delle pene accessorie con il “volto costituzionale” della sanzione penale è che esse non risultino manifestamente sproporzionate per eccesso rispetto al concreto disvalore del fatto di reato, tanto da vanificare lo stesso obiettivo di «rieducazione» del reo imposto dall’art. 27, terzo comma, Cost..
Orbene, proprio da tale passaggio motivazionale pare di chiara evidenza che solo una valutazione della determinazione della durata della pena accessoria sulla scorta dei criteri previsti dall’art. 133 c.p. consente di evitare un’applicazione sproporzionata di queste sanzioni rispetto alla gravità del fatto commesso.
Come è noto, difatti, i criteri menzionati da questa norma codicistica contengono dei parametri da cui può verificarsi siffatta gravità come si evince dal chiaro tenore letterale di questo precetto penale nella parte in cui è stabilito che “il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta”.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatta pronuncia, dunque, non può che essere positivo.
Volume consigliato


















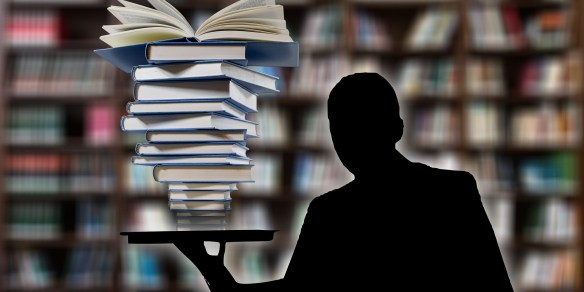


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento