(Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere)
(Riferimenti normativi: D.lgs., 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, c. 3-quater; Cod. proc. pen., art. 550)
Il fatto
In seguito a decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 del codice di procedura penale, il giudicante (Tribunale di Firenze) era chiamato a giudicare nel procedimento a carico di un cittadino straniero imputato del reato previsto dall’art. 624-bis del codice penale rubricato «Furto in abitazione e furto con strappo».
In particolare, il Tribunale rimettente esponeva come, a seguito di verifiche fatte prima dell’apertura del dibattimento e a seguito di sollecitazione della difesa dell’imputato, fosse emerso che l’imputato era stato espulso dal territorio nazionale in forza del provvedimento del 23 ottobre 2017 del Prefetto di Milano che era stato portato a esecuzione il giorno dopo con accompagnamento dello straniero alla frontiera aerea e successivo imbarco su un volo per il paese di origine riferendosi al contempo che «in data 30 gennaio 2018 era emesso dal pubblico ministero il decreto di citazione a giudizio, poi notificato all’imputato presso il difensore domiciliatario».
Quindi, l’esecuzione dell’espulsione era avvenuta prima – e non già dopo – dell’emissione del provvedimento che dispone il giudizio.
Quanto all’incidenza della disposizione sul procedimento penale pendente, il giudice a quo ricordava come la giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, avesse affermato che l’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs n. 286 del 1998 trova applicazione anche nell’ipotesi di citazione diretta in giudizio ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen. sottolineandosi contestualmente che in tal senso si era espressa anche la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 143 del 2006.
Il Tribunale rimettente, richiamando in particolare tale ultima pronuncia, evidenziava come l’istituto contemplato dall’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 costituisca «una condizione di procedibilità atipica, che trova la sua ratio nel diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio, in un’ottica similare – anche se non identica – a quella sottesa alle previsioni degli artt. 9 e 10 cod. pen., non disgiunta, peraltro, da esigenze deflattive del carico penale».
Però, secondo la giurisprudenza di legittimità, la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, non era consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente.
La questione prospettata nell’ordinanza di rimessione
Il rimettente dubitava della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui – applicandosi anche alle ipotesi (come quella al suo esame) in cui, pur a fronte di una già intervenuta espulsione mediante accompagnamento alla frontiera da parte degli organi di polizia, il pubblico ministero abbia emesso il decreto di citazione diretta a giudizio – «non prevede che il giudice del dibattimento, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, pronunci sentenza di non doversi procedere nel caso in cui l’espulsione sia avvenuta prima dell’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero».
Nel dettaglio, il rimettente prospettava la violazione dell’art. 3 Cost. ravvisando un’irrazionale disparità di trattamento sia nei rapporti fra imputati – dandosi luogo a un «diverso trattamento tra il soggetto che, in ragione del corretto operato del pubblico ministero, benefici della non procedibilità ed il soggetto che nelle medesime condizioni si veda viceversa tratto irrimediabilmente a giudizio per effetto di un’erronea valutazione del suo contraddittore processuale» – sia tra i procedimenti in cui è prevista l’udienza preliminare e i procedimenti a citazione diretta a giudizio perché solo «nei primi l’imputato beneficia nel corso dell’udienza preliminare di un vaglio giurisdizionale con riguardo alla sussistenza della condizione di procedibilità e può tramite il proprio difensore difendersi sul punto».
Il rimettente, poi, prospettava la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. osservandosi a tal riguardo che, nei procedimenti a citazione diretta, in cui la prima udienza dibattimentale viene celebrata successivamente all’emissione del decreto di citazione a giudizio, l’applicazione della disciplina prevista dalla disposizione censurata preclude all’imputato di eccepire l’insussistenza della condizione di procedibilità con violazione del principio del contraddittorio e della parità di condizioni tra le parti processuali.
Inoltre, sarebbe violato anche l’art. 101 Cost. nella misura in cui la regola posta dall’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 «comporta che l’atto di una parte processuale (l’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero), per quanto realizzato in violazione della normativa, sia vincolante per il giudice».
In punto di rilevanza, il giudice a quo, premesso che l’espulsione dell’imputato risultava comprovata, osservava che, se le questioni sollevate fossero accolte, il giudizio avrebbe potuto concludersi con la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere; diversamente, il giudizio avrebbe dovuto proseguire secondo le vie ordinarie con l’apertura del dibattimento.
Infine, il rimettente affermava come la possibilità di addivenire a un’interpretazione costituzionalmente orientata fosse preclusa dal tenore letterale della norma.
Si legga anche:”Immigrazione: quale cooperazione della Unione Europea con gli Stati di vicinato”
Le argomentazioni sostenute dalle parti
Con apposito atto interveniva in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale venissero dichiarate inammissibili o comunque manifestamente infondate.
In punto di ammissibilità, la difesa dello Stato affermava che il giudice rimettente avrebbe operato una ricostruzione incompleta del quadro normativo in cui è inserita la disposizione censurata trascurando che, secondo quanto da essa stabilito, la sentenza di non luogo a procedere può essere pronunciata solo nei «casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter» i quali a loro volta fanno riferimento all’espulsione amministrativa con nulla osta dell’autorità giudiziaria.
Nel merito, l’Avvocatura generale osservava come le questioni fossero state prospettate indicando come motivi di incostituzionalità quelle che erano, in realtà, le conseguenze di un errore compiuto dal pubblico ministero nell’applicazione della norma: dunque, non si sarebbe trattato di difetti intrinseci della stessa.
Tal che se ne faceva discendere come nessuna disparità di trattamento potesse essere ravvisata, né nel rapporto tra imputato e PM, né nel rapporto tra imputati, così come allo stesso modo si riteneva come andasse esclusa la violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio.
Al riguardo, la difesa statale richiamava l’ordinanza n. 142 del 2006 della Consulta che ‒ con riferimento alla diversa ipotesi dell’espulsione avvenuta dopo l’emissione del provvedimento che dispone il giudizio ‒ aveva affermato che il diverso trattamento riservato all’imputato, a seconda che ricorrano, o meno, le condizioni previste dall’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998, si risolve in una disparità di mero fatto, inidonea, come tale, a fondare un giudizio di violazione del principio di eguaglianza fermo restando che, con la stessa pronuncia, ricordava sempre l’Avvocatura generale, la Corte costituzionale aveva ritenuto come la disposizione censurata esprimesse una scelta riconducibile alla discrezionalità del legislatore.
Volume consigliato
Le valutazioni giuridiche formulate dalla Corte costituzionale
Il giudice delle leggi, in via preliminare, rilevava come dovesse essere rigettata l’eccezione, sollevata dell’Avvocatura generale dello Stato, di inammissibilità delle questioni per insufficiente descrizione della fattispecie in particolare non avendo il rimettente riferito se il PM procedente avesse, o no, assentito il nulla osta all’espulsione prima di richiedere la citazione diretta a giudizio.
Si osservava a tal riguardo come il Tribunale rimettente – investito del giudizio penale con citazione diretta ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen., sull’assunto che il contestato reato di furto in abitazione (art. 624-bis del codice penale) rientri tra quelli contemplati da tale norma di rito (in tal senso, Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 16 ottobre 2018-16 gennaio 2019, n. 1792) – avesse ritenuto di non poter fare applicazione della disposizione censurata perché, ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen., era già stato emesso il decreto di citazione diretta a giudizio da parte del PM posto che l’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che il giudice, sussistendone i presupposti, pronuncia sentenza di non luogo a procedere solo «se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio».
Da ciò se ne faceva discendere come le sollevate questioni di legittimità costituzionale fossero dirette proprio a rimuovere questo impedimento, con riferimento all’ipotesi del rito a citazione diretta, e tale da escludere l’applicazione della disposizione censurata (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 ottobre-29 novembre 2013, n. 47454) stimandosi ciò sufficiente per ritenere la loro rilevanza essendo l’esito delle questioni decisivo al fine dell’applicabilità, o no, della disposizione censurata da parte del giudice rimettente.
Invece, ad avviso della Consulta, la diversa questione della rilevanza del previo nulla osta dell’autorità giudiziaria all’espulsione amministrativa dello straniero irregolare, nei cui confronti pende un procedimento penale, si può porre solo quando, una volta rimosso l’impedimento censurato dal giudice rimettente, quest’ultimo poi possa passare a verificare le condizioni previste dalla disposizione censurata per l’applicabilità della condizione di improcedibilità sopravvenuta ivi prevista tenuto conto che ciò che peraltro egli sarà chiamato a fare anche in caso di mancanza di nulla osta.
Premesso questo, nel merito, le questioni venivano reputate fondate in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost..
Si notava a tal fine innanzitutto come la disposizione censurata chiamasse in causa la disciplina dell’espulsione amministrativa dello straniero irregolare, inserita in un complesso quadro normativo di riferimento, che la Consulta riteneva opportuno richiamare nelle sue linee essenziali nei seguenti termini: “Chi è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera o non ha titolo per rimanere nel territorio dello Stato può essere destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa (con avvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza) disposta dal prefetto ed eseguita dal questore, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria che procede per reati a carico dello straniero espulso, «salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali» (art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998). Una volta eseguita l’espulsione, lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno; in caso di trasgressione, è punito con la pena che inizialmente era quella dell’arresto da due a sei mesi e da ultimo è diventata quella della reclusione da uno a quattro anni; inoltre, lo stesso è nuovamente espulso con accompagnamento immediato. Fin dalla sua originaria formulazione, la disposizione in esame (art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998) prevedeva, al terzo comma, che, quando lo straniero era sottoposto a procedimento penale, occorreva il nulla osta che il questore era tenuto a richiedere all’autorità giudiziaria procedente, la quale poteva negarlo solo quando riteneva che sussistessero «inderogabili esigenze processuali». Ma inizialmente nulla era previsto quanto alla procedibilità dell’azione penale per eventuali reati commessi dall’immigrato irregolare. L’intervenuta espulsione dello straniero – e quindi la sua mancata presenza sul territorio dello Stato – non aveva alcuna incidenza impeditiva della procedibilità dell’azione penale, che seguiva le regole ordinarie. Ciò comportava che, pur dopo l’esecuzione dell’espulsione, l’eventuale procedimento (e processo) penale a carico dell’immigrato irregolare non si arrestava, ma proseguiva normalmente. Per l’esercizio del diritto di difesa dell’immigrato espulso, l’art. 17 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevedeva – e prevede tuttora – che lo straniero sottoposto a procedimento penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l’esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la sua presenza. Successivamente, con la legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) – adottata con l’esplicito intento di «contrastare in modo più efficace l’immigrazione clandestina» (così la relazione introduttiva al disegno di legge) – la disciplina dell’immigrazione è stata inasprita con l’introduzione di misure più severe nel trattamento dei migranti irregolari e con più ampio ricorso alla sanzione penale e a misure restrittive della libertà personale (come indicato nelle sentenze n. 223 e n. 222 del 2004). Il complessivo irrigidimento della disciplina di contrasto all’immigrazione irregolare si rinviene anche nella regolamentazione dell’espulsione amministrativa essendo previste misure più severe per rendere effettive le espulsioni. La scelta del legislatore è stata quella di favorire il più possibile l’espulsione dell’immigrato irregolare, imputato di un reato, e nello stesso tempo di limitare il rientro per presenziare al processo a suo carico, ove questo dovesse proseguire invece che arrestarsi in ragione della sopravvenuta espulsione. Da una parte, l’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede il silenzio-assenso dell’autorità giudiziaria: il nulla osta si intende concesso qualora l’autorità giudiziaria non provveda entro quindici (in seguito ridotti a sette) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Nello stesso tempo si ridimensionano le «inderogabili esigenze processuali» che possono impedire il rilascio del nulla osta, circoscrivendole a quelle relative all’«accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi», in tal modo rendendole anche contingenti e temporanee. Sono solo queste le esigenze processuali che possono impedire, fin quando sussistono, l’espulsione amministrativa. L’esecuzione del provvedimento resta sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Altresì, l’applicazione della custodia cautelare in carcere è di ostacolo al provvedimento di espulsione. Ma questo ridimensionamento è coniugato all’introduzione di un altro fattore di condizionamento, che è sostanziale piuttosto che processuale e quindi non già contingente e temporaneo: l’autorità giudiziaria procedente deve farsi carico anche dell’«interesse della persona offesa» − e, quindi, del vulnus al titolare del bene giuridico protetto − che può essere tale da richiedere che il processo si faccia. Dall’altra parte, si introduce (al comma 3-quater dell’art. 13 citato) una norma inedita, quella attualmente censurata di illegittimità costituzionale: «il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere». (…) Ciò però inizialmente non valeva per qualsiasi reato, perché vi erano delle eccezioni. Il comma 3-sexies dell’art. 13 prevedeva che il nulla osta all’espulsione non potesse essere concesso qualora si procedesse per reati particolarmente gravi, ossia per uno o più dei delitti previsti dall’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. (tra cui l’associazione a delinquere di tipo mafioso, l’omicidio, i delitti commessi per finalità di terrorismo), nonché dall’art. 12 dello stesso d.lgs. n. 286 del 1998 (immigrazione clandestina). In tal modo era il legislatore stesso a prevedere che, nel bilanciamento tra la ritenuta esigenza di tenere fuori dal territorio dello Stato l’immigrato irregolare già espulso e il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, prevalesse quest’ultimo quando si trattava di reati gravi e gravissimi. In sintesi, in occasione di questo innalzamento del livello di contrasto dell’immigrazione irregolare, da una parte il diniego di nulla osta dell’autorità giudiziaria veniva ridimensionato al fine di favorire l’espulsione amministrativa, in un ben più ristretto ambito di particolari esigenze processuali, salvo comunque il rilievo particolare dell’«interesse della persona offesa»; dall’altra parte, al fine di limitare il successivo ingresso dell’imputato immigrato irregolare per difendersi dall’accusa in sede penale, veniva introdotta la regola (prima sconosciuta al regime dell’espulsione amministrativa) della sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale in caso di intervenuta esecuzione dell’espulsione con l’eccezione di alcuni gravi reati. Occorre aggiungere anche che la nuova fattispecie di sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale non riguardava i reati più gravi richiamati dal comma 3-sexies dell’art. 13, nonché i reati tipici dell’immigrazione, quali quelli contemplati dall’art. 10-bis e dall’art. 14 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998 che prevedevano – e prevedono tuttora – una distinta fattispecie di sentenza di non luogo a procedere. In caso di intervenuta espulsione è questa specifica disciplina ad applicarsi in ragione del principio di specialità, disciplina che prevale su quella dell’art. 13, comma 3-quater, in esame; la quale è analoga, ma non identica: non è previsto il nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente, né è prescritto come condizione ostativa che al momento dell’avvenuta espulsione non sia già stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio. Successivamente, il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, in legge 31 luglio 2005, n. 155, adottato a seguito dei noti attentati di Madrid e Londra, ha previsto misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. All’art. 3 si introduce l’espulsione degli stranieri, come indicato nella rubrica, per «motivi di prevenzione del terrorismo», autorizzando il prefetto a espellere lo straniero qualora ci siano «fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali» (comma 1). Tale espulsione con decreto del Ministro dell’interno si affianca a quella già prevista dal comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998: l’espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Ciò che in particolare rileva – al fine delle presenti questioni di legittimità costituzionale in esame – è l’art. 3, comma 7, del d.l. n. 144 del 2005, che abroga il comma 3-sexies dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998: viene così meno il divieto di nulla osta all’espulsione in caso di reati particolarmente gravi, già tipizzati in tale disposizione con il richiamo dell’elenco previsto dall’art. 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. e dall’art. 12 del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998. Quindi, anche nel caso di pendenza di un procedimento penale per uno di questi gravi reati, non di meno l’autorità giudiziaria può assentire il nulla osta all’espulsione se non sussistono le specifiche e limitate esigenze processuali di cui al comma 3 (legate all’«accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi») e sempre che non sia ostativo l’«interesse della persona offesa», maggiormente rilevante una volta venuta meno l’esclusione dei reati più gravi, con l’ulteriore conseguenza che, una volta eseguita l’espulsione, ma non ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, viene in rilievo l’applicabilità della disposizione censurata e, quindi, la regola della sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale. I successivi interventi in materia di sicurezza, fino al recente decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77, non hanno più modificato la disposizione censurata”.
Ciò posto, una volta terminato questo excursus normativo, i giudici di legittimità costituzionale evidenziavano come andasse per prima esaminata la questione che faceva riferimento all’art. 3 Cost..
Si rilevava prima di tutto come il comma 3-quater dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 preveda, come suesposto anche prima, in generale, una sopravvenuta condizione di non procedibilità dell’azione penale per il reato commesso nel territorio dello Stato dall’immigrato irregolare allorché l’esecuzione della sua espulsione (amministrativa) intervenga prima dell’emissione del provvedimento che dispone il giudizio; espulsione condizionata alla verificata insussistenza delle condizioni ostative previste dal comma 3 della stessa disposizione e connesse a specifiche esigenze processuali nonché all’interesse della persona offesa che possono giustificare il diniego di nulla osta da parte dell’autorità giudiziaria procedente.
L’interpretazione di questa regola processuale, nell’articolato contesto normativo di contrasto dell’immigrazione irregolare e a fronte del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale, a sua volta, ad avviso della Corte, porta a escludere che si tratti di una sorta di immunità dalla giurisdizione dato che la presenza dello straniero irregolare nel territorio dello Stato non costituisce di per sé una generale condizione di procedibilità dell’azione penale in quanto è solo per i reati commessi all’estero (art. 10, primo comma, cod. pen.) che la presenza dello straniero nel territorio dello Stato integra una generale condizione di punibilità, non per quelli commessi in Italia che sono punibili secondo le norme ordinarie.
La norma, invece, sempre secondo la Consulta, è la risultante di un bilanciamento, operato dal legislatore, tra l’esigenza di limitare il rientro dell’immigrato irregolare nel territorio dello Stato una volta che l’espulsione è stata eseguita (stante anche la difficoltà concreta di dar seguito ai rimpatri forzati) e la necessità che i reati commessi dallo straniero nel territorio dello Stato siano puniti ed è in ciò che risiede il «diminuito interesse dello Stato alla punizione di soggetti ormai estromessi dal proprio territorio» (ordinanza n. 142 del 2006) rilevandosi al contempo come sia particolarmente indicativo di questo bilanciamento il fatto che, tra le condizioni ostative all’espulsione dello straniero che possono giustificare il diniego di nulla osta all’espulsione da parte dell’autorità giudiziaria procedente, vi sia – oltre alle specifiche e contingenti esigenze processuali sopra richiamate – anche, più in generale, l’«interesse della persona offesa» che necessariamente deve essere tenuto in conto dall’autorità giudiziaria procedente, in occasione del rilascio del nulla osta, e poi anche dal giudice chiamato a pronunciare la sentenza di non luogo a procedere.
Orbene, la Consulta faceva presente, a questo punto della disamina, come questa regola di settore – ossia la sopravvenuta improcedibilità dell’azione penale quale conseguenza dell’avvenuta esecuzione dell’espulsione dell’immigrato irregolare – sia formulata dalla disposizione censurata in termini generali con riferimento a tutti i reati essendo venuta meno l’eccezione, originariamente contemplata dal comma 3-sexies dello stesso art. 13, per reati particolarmente gravi fermo restando però che la prevista possibilità per il giudice, di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, appare implicare il necessario passaggio per l’udienza preliminare di cui agli artt. 416 e seguenti cod. proc. pen. e, quindi, secondo la Corte costituzionale, la norma sembra far riferimento a reati più gravi rispetto a quelli per i quali l’esercizio dell’azione penale è invece previsto con citazione diretta (art. 550 cod. proc. pen.) mentre la ratio della norma, che risulta dal richiamato bilanciamento fatto dal legislatore, esclude – per la contraddizione che non lo consente – che essa possa non essere applicabile proprio in caso di reati di minore gravità per i quali, al contrario, è maggiormente evidente il diminuito interesse dello Stato a perseguire la condotta penalmente rilevante dell’imputato immigrato irregolare, allorché l’espulsione amministrativa sia stata eseguita.
I reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, senza l’udienza preliminare, difatti, sono quelli ritenuti dal legislatore di minore gravità sì da giustificare un rito semplificato e accelerato, vale a dire: tutte le contravvenzioni, i delitti puniti con la pena entro un limite massimo (con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva), i reati elencati nel comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen..
Rilevato ciò, i giudici di legittimità costituzionale osservavano come fosse significativa di un qualche parallelismo la circostanza che anche l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva alla detenzione dell’imputato straniero, che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 ossia nelle stesse condizioni che facoltizzano il prefetto ad adottare il provvedimento di espulsione amministrativa, sia prevista (dall’art. 16 del medesimo decreto legislativo) in caso di reati di minore gravità.
Tal che se ne faceva conseguire come la regola di settore in esame, posta dalla disposizione censurata, non possa non trovare applicazione – per l’inferenza a fortiori che discende dalla considerazione della minore gravità del reato (e della più contenuta offensività della condotta) – anche ai reati perseguibili con il rito della citazione diretta di cui all’art. 550 cod. proc. pen..
A fronte di ciò, per la Corte, sarebbe contrario al principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) che la sopravvenuta condizione di improcedibilità dell’azione penale operi per i reati più gravi e non già per quelli di minore gravità.
In particolare, con riferimento alla stessa disposizione attualmente censurata, la Corte costituzionale (ordinanza n. 143 del 2006) aveva ritenuto che le rationes di questa «condizione di procedibilità atipica» «non soltanto non depongono nel senso della limitazione dell’operatività dell’istituto ai soli episodi criminosi di maggiore gravità, ma militano, semmai, in direzione esattamente inversa».
Da ciò se ne faceva discendere il fatto che, a maggior ragione per questi ultimi, l’azione penale può arrestarsi, risultando improcedibile ad tempus e sub condicione, così operando il sopravvenuto difetto di procedibilità laddove non sia stato ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio previsto dalla disposizione censurata e giustificato dal diminuito interesse dello Stato a perseguire queste condotte poste in essere dallo straniero irregolare ormai espulso.
In altre parole, l’improcedibilità è temporanea e sottoposta a una sorta di “condizione risolutiva” nel senso che, se è poi violato l’obbligo di reingresso nel territorio dello Stato per un determinato periodo di tempo, si applica l’art. 345 cod. proc. pen. e l’azione penale torna a essere procedibile.
Ciò posto – una volta rilevato che l’adeguamento al principio di eguaglianza e ragionevolezza può avvenire in via interpretativa – come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (fin dalla pronuncia della Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 16 settembre-28 settembre 2004, n. 38282), alla quale la Consulta aveva fatto riferimento (ordinanza n. 143 del 2006) – per l’ipotesi in cui il PM non abbia ancora richiesto il decreto di citazione diretta posto che era stato ritenuto che quest’ultimo possa chiedere al giudice per le indagini preliminari l’adozione della pronuncia di non luogo a procedere ancorché l’azione penale non sia stata esercitata nei modi previsti dall’art. 405 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 9 marzo-19 luglio 2016, n. 30929) e che la stessa esigenza di adeguamento a Costituzione sussiste anche se il decreto di citazione diretta è stato emesso benché l’esecuzione dell’espulsione sia già avvenuta dato che l’ipotesi più semplice – ma non l’unica – è quella della mancata comunicazione del questore al PM dell’avvenuta esecuzione dell’espulsione che non può giustificare, come inconveniente di fatto, un trattamento differenziato, quale sarebbe la mancata applicazione della regola dell’improcedibilità sopravvenuta nonostante l’espulsione sia avvenuta prima dell’emissione del decreto di citazione diretta stante il fatto che le fattispecie sono analoghe e pienamente comparabili in ragione del decisivo elemento comune costituito dall’esecuzione dell’espulsione prima dell’emissione del provvedimento che dispone il giudizio – si osservava però come non fosse però possibile estendere alla fattispecie in esame l’interpretazione adeguatrice già accolta dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass., sez. prima penale, n. 38282 del 2004) e dalla Consulta (ordinanza n. 143 del 2006) secondo cui la sopravvenuta condizione di improcedibilità dell’azione penale sussiste altresì – e a maggior ragione – se si tratta dei reati meno gravi di cui all’art. 550 cod. proc. pen. per i quali non è prevista l’udienza preliminare e quindi ben può il PM chiedere l’adozione della sentenza di non luogo a procedere dal momento che la formulazione letterale della disposizione censurata ‒ che prevede, come condizione ostativa alla rilevanza dell’avvenuta esecuzione dell’espulsione, l’emissione del provvedimento che dispone il giudizio ‒ non consente un’interpretazione estensiva così fortemente manipolativa del dato testuale, come del resto ritiene la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. prima penale, n. 47454 del 2013).
Dunque, non essendo praticabile l’interpretazione adeguatrice, la ritenuta violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.) comportava irrimediabilmente, secondo il giudice delle leggi, l’illegittimità costituzionale, in parte qua, della disposizione censurata in guisa tale che, per tutti i reati a citazione diretta, per i quali non è prevista – e non c’è stata – l’udienza preliminare, deve poter rilevare, a opera del giudice, la circostanza dell’avvenuta esecuzione dell’espulsione prima dell’emissione del decreto di citazione diretta: la conseguente insorgenza di una condizione di improcedibilità sopravvenuta non può trovare ostacolo nella circostanza che in concreto il PM abbia già formulato l’imputazione nel decreto di citazione diretta e che questo sia già stato emesso.
Quindi – assorbiti gli altri parametri – la Corte disponeva come dovesse essere rimosso nella disposizione censurata, con la presente dichiarazione di illegittimità costituzionale, l’impedimento per il giudice, investito con citazione diretta ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen., di accertare le condizioni previste per la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere; impedimento testuale costituito proprio dalla già intervenuta emissione del decreto di citazione diretta.
Alla stregua di tale censura di illegittimità costituzionale, pertanto, il giudice potrà rilevare d’ufficio – o in ipotesi anche a seguito di eccezione della difesa dell’imputato o finanche dello stesso PM – che sussistono le condizioni della speciale sopravvenuta improcedibilità prevista dalla disposizione censurata al fine di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere contemplata da quest’ultima; sentenza (quella prevista dall’art. 13, comma 3-quater) che – come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 29 aprile-7 giugno 2019, n. 25358) – può, in questa fattispecie particolare, essere emessa anche in una sede processuale diversa dall’udienza preliminare; in altri termini, il giudice potrà rilevare che l’espulsione dell’imputato è stata eseguita prima dell’emissione del decreto di citazione diretta e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
Oltre a ciò, veniva altresì rilevato che per l’esecuzione dell’espulsione occorre – come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 31 maggio-26 giugno 2018, n. 29396; Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 25 settembre-9 ottobre 2012, n. 39835) – che la richiesta del questore ex art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 sia stata assentita con il nulla osta, espresso o tacito, dell’autorità giudiziaria procedente mentre, ove la richiesta del questore non vi sia (ciò che può verificarsi per mancata conoscenza del procedimento penale pendente o per mera posteriorità di quest’ultimo o per altre ragioni), non di meno può il giudice – per il rispetto che richiede il principio di eguaglianza – verificare che sussistevano le condizioni perché il nulla osta potesse essere assentito con particolare riferimento all’interesse della persona offesa.
I giudici di legittimità costituzionale, dunque, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, dichiaravano l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
Conclusioni
La Consulta, nella pronuncia qui in esame, è intervenuta sull’art. 13, c. 3-quater, d.lgs. n. 286/1998 che originariamente prevedeva unicamente quanto segue: “Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell’articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14”.
Orbene, come appena visto, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa disposizione legislativa nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell’art. 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d’ufficio, che l’espulsione dell’imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.
Tal che, per effetto di tale pronuncia, il giudice potrà rilevare che l’espulsione dell’imputato è stata eseguita prima dell’emissione del decreto di citazione diretta e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere fermo restando che, per l’esecuzione dell’espulsione occorre, la richiesta del questore ex art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 deve essere assentita con il nulla osta, espresso o tacito, dell’autorità giudiziaria procedente mentre, ove la richiesta del questore non vi sia (ciò che può verificarsi per mancata conoscenza del procedimento penale pendente o per mera posteriorità di quest’ultimo o per altre ragioni), non di meno può il giudice – per il rispetto che richiede il principio di eguaglianza – verificare che sussistevano le condizioni perché il nulla osta potesse essere assentito con particolare riferimento all’interesse della persona offesa.
I giudici di legittimità costituzionale, dunque, non solo hanno censurato l’illegittimità costituzionale di questo precetto normativo in tal modo, ma hanno evidenziato chiaramente le conseguenze pratiche (specialmente in riferimento al vaglio giudiziale a cui sarà tenuto adesso il giudice in tali casi) che sono scaturite da tale decisione.
La sentenza in commento, quindi, proprio perché incide considerevolmente sulla portata applicativa dell’art. 13, c. 3-quater, d.lgs. n. 286/1998, dovrà essere presa nella dovuta considerazione nei casi in cui si dovrà fare riferimento a tale norma giuridica.
Volume consigliato


















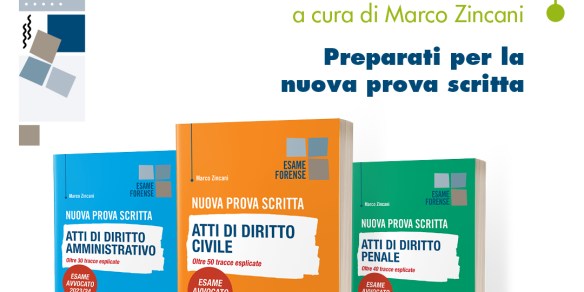

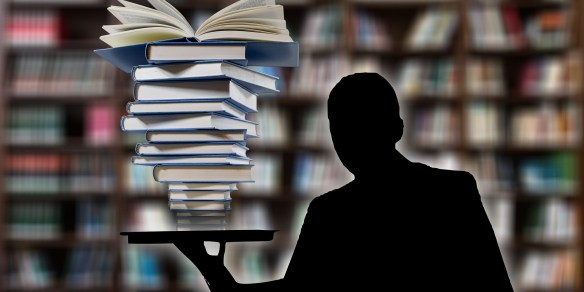
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento