Italia condannata da Strasburgo. Ancora una volta la Corte europea dei diritti umani contesta l’insufficiente rapidità di azione del nostro Paese. La materia ha a che fare proprio con quanto approvato nei giorni scorsi alla Camera, ossia la nuova tutela nei confronti dei figli orfani delle vittime di violenza domestica. Il caso pervenuto dinanzi alla Corte era il seguente: a Remanzacco, in provincia di Udine, una donna e sua figlia hanno subito ripetuti atti di violenza domestica dal marito, sfociati irrimediabilmente nell’assassinio del ragazzo e nel tentato omicidio della moglie. Per questo motivo, l’Italia è stata giudicata colpevole di non aver approntato adeguate difese nei confronti di madre e figlio, rimasto ucciso perché intervenuto in difesa della madre, e dovrà per questo risarcire la donna di 30mila euro per danni non pecuniari e 10mila a titolo di rimborso delle spese affrontate. È la prima volta che per un reato di violenza domestica, l’Italia subisce una condanna dalla Cedu: questa diverrà definitiva entro tre mesi, sempre che lo Stato non faccia opposizione, dopo la pubblicazione delle motivazioni.
L’episodio risale a cinque anni fa, mentre la condanna definitiva dell’omicida – ora in carcere con l’ergastolo – è avvenuta nel 2015. Il colpevole è stato condannato dal Gup di Udine anche a risarcire alla madre della vittima 400 mila euro.
La condanna della Corte Edu è precisa: “non agendo prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio“. Devono essere predisposti strumenti idonei alla prevenzione dei delitti di violenza in questione, in quanto spesso tali avvenimenti sono l’epilogo di una serie infinita di soprusi che le vittime avevano già iniziato a subire, e magari anche denunciato. Si presumono violati l’articolo 2 sul diritto alla vita, 3 sul divieto di trattamenti inumani e degradanti e 14 divieto di discriminazione della Convenzione europea dei diritti umani.
La vicenda.
Già a giugno 2012, la madre si era già rivolta alla “police”, a seguito di percosse da parte del marito, subite anche dalla figlia, a causa del suo alcolismo. I fatti, in questa prima volta, erano stati accertati dalla stessa Autorità, e messi a verbale. Nell’agosto successivo, gli agenti avevano avuto modo di fermare nuovamente il marito, per porto illegale di armi, un coltello, con cui lo stesso aveva minacciato la donna per obbligarla ad avere rapporti sessuali con lui e altri uomini. Pur riuscendo ad impedire l’accaduto, la donna aveva già subito maltrattamenti, accertati dal pronto soccorso presso il quale la stessa si era recata, senza alcuna indicazione o supporto da parte delle Autorità.
Dopo essere riuscita ad andarsene di casa, grazie ad una delle associazioni specializzate in maltrattamenti domestici, pur avendo trovato un lavoro ed essendo indipendente dal punto di vista economico, il marito aveva continuato a perseguitarla, portando la donna a sporgere una formale denuncia nei suoi confronti. Tuttavia, anche a seguito di ciò, l’interrogatorio della donna si è svolto dopo un periodo di tempo ampio, di circa tre mesi, e non sono state prese cautele opportune al fine di proteggerla e di sedare la pericolosità del soggetto.
La Difesa dell’Italia è incentrata sui comportamenti tenuti dalla donna a seguito della denuncia: la stessa, in sede di colloquio, aveva ritrattato le deposizioni precedenti, sostenendo che le stesse erano state fraintese dalle Autorità, “magari anche per motivi di incomprensione linguistica”. Inoltre, la donna si era volontariamente allontanata dal centro antiviolenza.
Diversa la versione fornita dall’avvocato della donna. Per il presidente dell’associazione “Donne in Rete contro la violenza”, la donna non ha abbandonato per sua volontà la struttura, ma sono stati il Comune e il servizio sociale a non ritenere che il suo caso fosse di gravità tale da dover mettere la signora in stato di protezione. “Ci sono documenti depositati da quali si evince che non erano di grado di pagare la retta prevista per garantire alla signora un luogo sicuro”.
Conclusioni.
In primo luogo, non può essere in alcun modo addotta come motivo ostativo all’efficienza e all’efficacia degli strumenti forniti da parte delle Istituzioni, la differenza linguistica. Ogni qualvolta vi sia incomprensione, infatti, è possibile ricorrere ad un interprete, nonché ad un traduttore. Altrimenti appare plausibile che sia violato l’art. 14 Cedu in tema di discriminazione. In secondo luogo, nella generalità dei casi, gli strumenti giudiziari forniti a tutela dei soggetti coinvolti in queste situazioni non sono sufficienti a prevenire la commissione di ulteriori e più gravi reati. Per questo, è necessario che venga predisposto un apparato specifico di risposta al fenomeno. Infine, lo Stato deve riconoscere e potenziare il ruolo delle Associazioni e dei professionisti sparsi sul territorio, che spesso, pur avendo le competenze richieste dal caso, sono sforniti di mezzi e risorse economiche.


















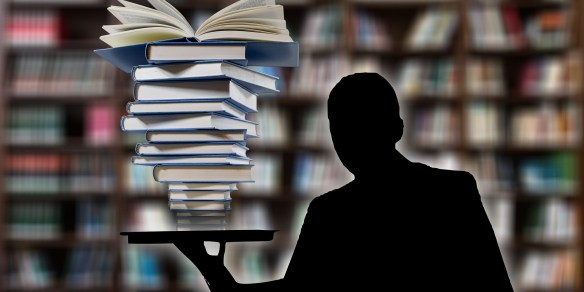


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento