Tribunale di Matera – ordinanza di archiviazione del 19-12-2017
Premessa
Con la decisione in commento, la giurisprudenza di merito esamina uno degli aspetti più problematici del delitto di abusivo esercizio di una professione, ossia quello dell’individuazione degli atti che appartengono ad una professione c.d. “protetta” il cui svolgimento, in assenza della prescritta abilitazione, integra la fattispecie del reato in questione.
In particolare, l’esercizio delle professioni sanitarie si deve espletare nel rispetto reciproco dello specifico ambito di competenza professionale, considerando che spesso risulta difficile definirne i confini.
Paradigmatico, in tale senso, risulta il caso in cui la condotta del responsabile di un laboratorio di genetica possa integrare il reato di cui all’art. 348 c.p.
A tale proposito, giova analizzare quali atti siano di esclusiva competenza del medico e quali rientrino nella competenza concorrente del biologo, il quale ultimo ha dovuto imporsi nel mondo del lavoro, in contesti in cui altre figure erano meglio conosciute e già operanti da tempo. Tale figura professionale, altresì, può avvalersi di leggi “strutturali” estremamente precise e dettagliate.
La vicenda processuale
La premessa fattuale all’ordinanza di archiviazione in analisi riguardava gli accadimenti avvenuti nei confronti del responsabile di un laboratorio di genetica, indagato per il reato di esercizio abusivo della professione.
In particolare, alla luce della ricostruzione dei fatti fornita dalla pubblica accusa, era emerso che il procedimento de quo non doveva essere instaurato dal momento che il medesimo responsabile aveva effettuato esclusivamente attività di consulenza genetica pre e post test genetico ed aveva offerto la sua collaborazione anche ai medici.
La contestazione consisteva nel fatto che la motivazione del Pubblico Ministero risulterebbe viziata poiché il medesimo P.M. aveva considerato che sia il responsabile del laboratorio che la persona offesa fossero medici con specializzazioni diverse. Segnatamente, il primo è laureato in biologica, la seconda in medicina e chirurgia.
La questione, giunta al vaglio del Giudice per le indagini preliminari, veniva accolta, nella misura in cui dalle indagini si evinceva che il suddetto responsabile non aveva effettuato visite mediche né prescrizioni terapeutiche, i quali ultimi sono atti di esercizio dell’attività medica.
Il delitto di esercizio abusivo della professione: considerazioni generali
Il bene giuridico protetto dalla norma di cui all’art. 348 c.p., la quale rappresenta una novità rispetto al sistema previgente, è rappresentato dalla disciplina amministrativa delle professioni. In particolare, si vuole tutelare l’interesse pubblico che determinate attività, socialmente molto rilevanti, vengano svolte da soggetti che siano stati giudicati idonei dal punto di vista professionale e morale al loro esercizio[1].
In tale modo, solo indirettamente sono tutelati coloro che esercitano legittimamente la professione, gli ordini professionali che li rappresentano, nonché i privati che potrebbero avvalersi dell’opera del professionista abusivo[2]. Nel senso che il legislatore ha inteso tutelare gli interessi della collettività al regolare svolgimento delle professioni per le quali sono richieste una speciale abilitazione e l’iscrizione nell’albo[3].
Tuttavia, rispetto al momento in cui è stata introdotta, allorquando assumevano rilevanza le sole professioni liberali, le cui attività di esercizio non presentavano problemi di inquadramento, la disposizione in esame ha subito una dilatazione. Tale processo dilatativo è stato conseguenza della incessante espansione delle professioni il cui accesso richiede una speciale abilitazione e l’iscrizione negli albi tenuti dai relativi consigli degli ordini. Inoltre, il suddetto processo è stato innescato da meccanismi di eterointegrazione con disposizioni extrapenali, alle quali è necessario fare riferimento per definire i profili di abusività dell’esercizio della professione[4].
La struttura della fattispecie è, invero, tale che essa è limitata solo alle c.d. “professioni protette”, cioè quelle il cui esercizio non è consentito a chi non abbia conseguito tale abilitazione (ad esempio, avvocato, medico, farmacista, architetto, ecc.) oppure non possieda i requisiti previsti dalla legge come equivalenti. Ne deriva l’esistenza di professioni che si pongono in una zona grigia tra la res pubblica e le industrie, i mestieri, non menzionati dalla norma, sebbene l’ordinamento per l’esercizio di queste ultime attività richieda una apposita licenza.
Appurato che la normativa italiana relativa alle singole attività professionali deve essere coordinata con le norme del trattato istitutivo della Comunità europea, un profilo di grande rilievo risiede, inoltre, nel c.d. diritto di stabilimento, sancito dall’art. 52, par. 2, che consente al cittadino di uno Stato membro di esercitare, in un altro Paese della Comunità, attività non salariate alle medesime condizioni riservate ai soggetti che fanno parte dello Stato “ospitante”.
La speciale abilitazione cui accenna l’art. 348 c.p. designa l’atto conclusivo del procedimento autorizzatorio, attraverso il quale la Pubblica Amministrazione accerta l’idoneità tecnica del soggetto all’esercizio della professione e rimuove un limite all’esercizio del diritto ad esercitare la professione. Generalmente, alla mancanza dell’abilitazione viene equiparata la mancanza di iscrizione all’albo, nel caso in cui questa sia prescritta dalla legge[5]. Il carattere abusivo dell’esercizio della professione, infatti, può rinvenirsi anche nella inosservanza dell’iter amministrativo che ammette il soggetto allo svolgimento della professione.
A tale proposito, giova evidenziare che l’esercizio professionale da parte di chi non abbia conseguito un diploma sia diverso rispetto a chi sia in possesso del diploma ma non iscritto all’albo[6].
In breve, i requisiti oggettivi del reato sono rappresentati, in primis, da un presupposto normativo, ovvero dalla presenza di altre norme che qualifichino l’attività come “professione” e prescrivano una speciale abilitazione dello Stato per il suo esercizio. Inoltre, vi deve essere un presupposto del fatto, a contenuto negativo, consistente nella mancanza di capacità giuridica all’esercizio della professione del soggetto agente. Infine, la condotta, cioè il compimento di atti di esercizio della professione[7].
Un terreno di scontro tra l’esercizio abusivo della professione e il principio di determinatezza
Una delle questioni più importanti concernenti l’art. 348 cp riguarda la configurabilità della norma de quo alla stregua di una norma penale in bianco.
Più nel dettaglio, secondo una prima ricostruzione, l’espressione “abusivamente” determina che la disposizione in commento non costituirebbe una norma penale in bianco[8]. Questa è la posizione che è stata assunta dalla Corte Costituzionale, la quale, allorquando, a causa del presunto carattere di norma penale in bianco, l’ipotesi delittuosa è stata tacciata, più volte, di incostituzionalità, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 348 c.p.[9] La medesima Corte ha sostenuto che il mero fatto che lo Stato prescriva una speciale abilitazione per l’esercizio della professione non esclude tout court che la norma in commento descriva una fattispecie perfetta in tutti i suoi connotati tipizzanti. In particolare, la Corte ha ritenuto che il provvedimento abilitativo non integra un elemento strutturale della norma incriminatrice, ma rappresenta un presupposto che “in negativo condiziona la capacità giuridica del soggetto in ordine all’oggetto di quella specifica professione, qualificandone la condotta come abusiva e, perciò, illecita”[10].
Pertanto, questa ricostruzione non ammette che si possa parlare di norma penale in bianco. Queste ultime sono incomplete e, di conseguenza, si integrano da un’altra fonte, la quale riempiendosi riesce a formare l’illecito. Dunque, l’art. 348 c.p. è una norma conclusa, comprendente sia il precetto sia la sanzione[11].
Si è, altresì, rilevato che il delitto incorpora, tra i suoi elementi essenziali, la mancanza della speciale abilitazione richiesta, la quale ultima rappresenta un elemento del fatto costruito negativamente.
Sebbene la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha provato a salvare la norma dalle accuse di incostituzionalità, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha ravvisato nell’art. 348 c.p. una norma penale in bianco, la quale necessita di norme giuridiche diverse, che qualificano una determinata attività professionale, prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l’iscrizione in uno specifico albo. In tale modo, si configurano le c.d. professioni protette: il giudice non può colmare l’eventuale lacuna normativa, proveniente dal disinteresse del legislatore verso una determinata professione, per il cui esercizio non viene richiesta la speciale abilitazione, con la prescrizione di regole generali ed astratte[12].
D’altra parte, è evidente che l’accertamento del carattere abusivo ex art. 348 c.p. sia problematico.
In particolare, nelle ipotesi in cui la normativa che regolamenta la specifica professione non individui con certezza gli atti e le attività che possano qualificarsi come “tipici”, ovvero propri di quella peculiare professione.
Si è rilevato come, di frequente, le discipline professionali non comprendono prescrizioni analitiche riguardo le qualità degli atti c.d. “professionali”. Pertanto, laddove si ipotizzasse che l’elemento normativo della mancanza di abilitazione provveda sia a rendere effettivi i tratti di abusività della singola condotta professionale, sia a delineare gli atti tipici della professione, si finirebbe per attribuire all’elemento normativo una funzione di integrazione vera e propria della fattispecie: situazione che si pone in contraddizione con la natura di elemento normativo.
Il compimento di atti tipici è sufficiente per integrare il reato di cui all’art. 348 c.p.?
In relazione alla condotta sufficiente ad integrare il delitto in oggetto, è doveroso asserire che nel rispetto del principio di determinatezza, la legge extrapenale, integratrice del precetto penale in bianco, debba elencare tutti gli atti oggetto della riserva in guisa che solo questi, se compiuti da un soggetto non abilitato, rilevino ai fini della fattispecie criminosa in analisi.
D’altro canto, è opportuno dare conto di un’ altra opzione ricostruttiva – maggiormente flessibile – del suddetto principio, la quale ha statuito che l’ipotesi delittuosa si limita a descrivere i caratteri generali della professione oggetto della riserva.
Il fulcro della questione attiene all’individuazione del contenuto della professione tutelata dall’art. 348 c.p. Considerando gli artt. 2229, 2230, 2231 c.c., la medesima professione è rappresentata dall’attività autonoma e continuativa, di natura intellettuale, stabilmente organizzata e prestata dietro corrispettivo a chiunque chieda di usufruirne. Ne deriva una serie di atti principali ed accessori non sempre preventivamente determinabili. Dunque, secondo una parte della dottrina, la professione è “un’attività umana, caratterizzata da continuità, svolta a fine lucrativo e con autonomia, da un soggetto ritenuto competente in quanto dotato di corredo particolare di cognizioni tecnico-scientifiche”[13].
Ad ogni modo, a prescindere da quale sia l’indirizzo interpretativo prevalente, ci si chiede se, ai fini dell’integrazione della condotta tipica, sia necessario il compimento di un solo atto o, altrimenti, di una pluralità di essi.
L’orientamento maggioritario predilige la tesi del compimento di un solo atto in senso di esclusività del medesimo. Ciò nonostante, accade in alcune circostanze, che il delitto venga integrato da una pluralità di condotte propedeutiche e continuative[14].
La distinzione tra esclusività e continuità rileva in relazione al bene posto a garanzia di una determinata professione. In virtù di ciò, un atto esclusivo incidente sul bene della salute avrà una preminenza assoluta rispetto, rispetto ad una pluralità di atti continui propri di un’altra professione, non sanitaria, incidenti su un interesse giuridico meno rilevante[15].
Tale premessa rimanda ad altra questione attinente alla delimitazione dell’ambito applicativo della fattispecie dell’art. 348 c.p. in relazione all’estensione concettuale degli atti di esercizio della professione per i quali è necessario la “speciale abilitazione dello Stato”. Dunque, il principale problema in ordine al rispetto del principio di determinatezza si rinviene nella determinazione degli “atti tipici”.
Secondo un primo orientamento, gli atti rilevanti per configurare il reato de quo sarebbero solo quelli tipici o propri, ovvero quelli attribuiti in esclusiva ad una determinata professione, mentre si collocherebbero fuori dall’ambito di applicazione della norma incriminatrice gli atti c.d. collaterali, che, nonostante siano connessi all’esercizio professionale, non rientrano nella riserva di competenza e sono suscettibili di essere posti in essere da chiunque[16].
Un più recente orientamento[17] dilata l’ambito di estrinsecazione delle modalità di “esercizio della professione”. La norma sarebbe formata da tutti gli atti peculiari di una specifica professione. In particolare, sia gli atti attribuiti in via esclusiva -i c.d. atti “tipici”, “propri” o “riservati”-, il cui compimento, anche se occasionale, isolato e gratuito, integra il reato, sia quelli c.d. “relativamente liberi” che possono rappresentare un esercizio della “professione”, quando compiuti in modo continuativo, organizzato e remunerato[18]. Questi ultimi esulano, tuttavia, dalla ipotesi delittuosa quando siano compiuti a titolo occasionale e gratuito[19].
Alla luce di quanto esposto, si evince che una simile interpretazione pone diversi interrogativici circa la la compatibilità con il principio di determinatezza. Non è una regola il fatto che spesso si rievoca una determinata fonte normativa per individuare le condotte concretamente punibili in ossequio al citato principio, il quale ultimo può essere violato laddove la fattispecie richiamata non permetta di individuare, per la vaghezza delle espressioni utilizzate, i connotati dell’attività da tutelare.
A tale proposito, la Corte Costituzionale ha affermato che“il principio di tassatività … deve considerarsi rispettato anche se il legislatore, nel descrivere il fatto di reato, usi non già termini di significato rigorosamente determinato, ma anche espressioni meramente indicative o di rinvio alla pratica diffusa nella collettività in cui l’interprete opera, spettando a quest’ultimo determinarne il significato attraverso il procedimento ermeneutico di cui all’art. 12, primo comma, delle preleggi”[20].
In tale senso, si osserva che qualora la formula legislativa adoperasse locuzioni che individuano uno spazio semantico aperto, il giudice dovrà accertare se la norma possa essere tassativizzata attraverso il ricorso a canoni interpretativi conosciuti.
Secondo parte della dottrina, in mancanza di specifiche norme legislative o regolamentari, si dovrà ricorrere al prudente apprezzamento del giudice, il quale dovrà esaminare quale siano state le ragioni che hanno indotto il Legislatore a stabilire l’abilitazione per l’esercizio di quella specifica professione[21].
Rapporto problematico tra il soggetto esercente la professione medica e il biologo.
In materia di professione medica, la questione diventa complicata dal momento che non vi sono né norme extrapenali che definiscano i concetti di “medicina” e di “professione medica” né norme che elenchino quelli che possano definirsi “atti tipici” di questa specifica categoria professionale[22].
Segnatamente, è opportuna osservare se sia rispettosa del principio di determinatezza la scarsa descrizione ed elencazione degli atti medici c.d. riservati. Questa affermazione trova un avallo nelle diverse normative sull’abilitazione alla professione medica, richiamate dall’art. 348 c.p., considerando casi non espressamente vietati dalla legge ma nemmeno contemplati dagli insegnamenti universitari su cui si fonda l’abilitazione alla professione medica. Infatti, maggiore sarà l’ambito della sfera professionale ex art. 348 c.p., più ristretti saranno i margini per lo svolgimento libero delle pratiche terapeutiche alternative.
Pertanto, gli atti tipici della professione medica possono essere individuati in modo deduttivo, ovvero dal complesso delle norme che regolano la materia. In particolare, ogni professione ha una propria essenza e, di conseguenza, gli atti tipici sarebbero individuati nelle condotte in grado di estrinsecare, manifestare o attualizzare tale essenza.
Per quando concerne la professione medica, dunque, gli atti tipici dovranno essere individuati sulla base dell’ambito della competenza e del patrimonio di conoscenza in cui la medesima professione consiste[23].
La definizione di professione medica è frutto di rielaborazione giurisprudenziale e, negli ultimi anni, essa è stata indicata come “l’attività diretta a diagnosticare le malattie, nel prescriverne la cura, nel somministrare i rimedi anche se diversi da quelli ordinariamente praticati: così ragionando commette il reato di esercizio abusivo della professione medica chiunque esprima giudizi diagnostici e consigli, ed appresti le cure al malato”[24].
Quindi, l’atto di spettanza del medico viene individuato in qualsiasi atto di diagnosi e cura che sia caratterizzato da potenziali implicazioni pericolose per la salute. Orbene, non bisogna considerare le diverse tecniche utilizzate, differenziando quelle introdotte ufficialmente nei piani di studio universitari dalle c.d. pratiche non convenzionali. Ne deriva che possono reputarsi “atti liberi” solo quelli relativi al corpo o alla mente che non abbiano finalità curative e non siano pericolosi per la salute[25].
Nella specie, applicando tale principio, la Suprema Corte ha ravvisato il delitto qualora vi siano atti di agopuntura[26], chiropratica o medicina non convenzionale[27] e omeopatia[28], effettuati da soggetti non medici. Inoltre, la medesima Corte ha individuato e distinto tra attività mediche finalizzate alla cura di malattie rispetto ai casi in cui sono del tutto assenti patalogie nonostante la condotta sia diretta ad incidere sulla persona fisica, come per esempio attività di tatuaggio[29] oppure vendita di erbe[30].
Rimanendo nell’ambito della professione medica, è interessante verificare come, a differenza del medico, per il quale si devono considerare le fonti normative precedentemente enucleate, ben più complessa è l’individuazione delle competenze del biologo.
L’attività di medicina di laboratorio fornisce informazioni su tessuti o liquidi biologici di origine umana sia per quanto concerne la prevenzione, le diagnosi e il follow up delle malattie sia per il fine della ricerca.
Il tipo di prestazione effettuata nei diversi laboratori e la dotazione strumentale hanno un diverso grado di complessità che risulta commisurata alla realtà sanitaria ed alla tipologia di quesiti diagnostici posti al laboratorio. In tale situazione, gli specialisti dell’équipe multidisciplinare, compreso il biologo, discutono in modo approfondito dei casi dei pazienti, conformandosi alla normativa nazionale e regionale.
Ai professionisti è richiesta una adeguata formazione, generica e specifica, che gli permetta di garantire una combinazione contestuale di qualità ed economicità del servizio, anche per sopperire a sprechi gravosi per il sistema sanitario nazionale.
A tale proposito, è opportuno evidenziare che nei servizi di patologia clinica si possono distinguere tre fasi: fase pre analitica[31], fase analitica[32] e fase post analitica[33].
Inoltre, è bene rammentare come all’interno del medesimo servizio di patologia è possibile individuare delle aree specialistiche che comprendono tra le altre: ematologia, chimica clinica, microbiologia e virologia, cito/istopatologia e genetica.
Segnatamente, compito del biologo genetista, operante nel laboratorio di genetica, è, ictu oculi, quello di eseguire consulenze genetiche pre e post. Tale attività non è riservata in modo esclusivo ai laureati in medicina e chirurgia con specializzazione in genetica medica, come si desume dalla normativa in materia.
In primis, dall’art. 3, comma 1, lett. c), della L. n. 396 del 1967, c.d. legge istitutiva dell’ordinamento della professione di biologo, il quale statuisce che “formano oggetto della professione di biologo … problemi di genetica dell’uomo, degli animali e delle piante”.
Inoltre, dal documento redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’Editoria, il quale afferma che “le richieste di test genetici rivolte a Strutture di Genetica Medica devono essere valutate dal Laboratorio di Genetica e nel caso non vi siano sufficienti informazioni o indicazioni, la richiesta va discussa con il medico che la formula” (p. 9, par. 5.2.).
Vieppiù, degne di nota sono le linee guida per la diagnosi citogenetica del 2013, in cui si legge testualmente “la gestione della consulenza collegata all’esecuzione degli esami e la conservazione dei consensi informati sono sotto la responsabilità del laboratorio e, quindi, dei dirigenti sentirai sia essi biologi o medici genetisti che ne fanno parte” (p. 13 ss., par. 2.7.“Rapporti con gli utenti”).
Documenti che validano quanto detto sono, altresì, l’autorizzazione n. 8/2016, cioè l’autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici, rilasciata il 15 dicembre 2016 dal Garante per la protezione dei dati personali (pp. 4, 5, 6 e 8) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), pubblicato in G. U. n. 65 del 18 marzo 2017- supplemento ordinario n. 15, il quale ultimo fra le “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale” (Allegato 4), è stata finalmente fatta una differenziazione fra il termine “consulenza genetica” e “visita genetica”.
Per quanto concerne la prima, identificata con il codice G9.01, fa parte della branca “Laboratorio” ed è definita “Consulenza genetica associata al test” – Consulenza Genetica in paziente con ipotesi diagnostica specifica già formulata e con prescrizione di test genetico. La suddetta consulenza può essere pre o post test. Nel primo caso, si ha la spiegazione dei vantaggi e dei limiti del test genetico e la somministrazione dei consensi informati (se non effettuati nell’ambito della visita). Nel secondo, invece, si ha la spiegazione del risultato del test genetico.
Per quanto concerne la “Visita Genetica di controllo”, codice 89.01, viene descritta come “Consulenza Genetica successiva alla prima in paziente ancora senza diagnosi. Visita specialistica genetica con esame obiettivo, rivalutazione della documentazione clinica recente e remota. Consultazione della letteratura scientifica e di database di genetica clinica specifici. Affinamento dell’ipotesi diagnostica pregressa e scelta di eventuale nuovo test genetico appropriato. Spiegazione di vantaggi e limiti del test genetico e somministrazione dei consensi informati. Scrittura della relazione”. La branca medica alla quale è affidato il compito clinico è definita “ALTRE”, quindi non avendo individuato il professionista specifico la visita genetica può essere eseguita dal clinico di riferimento. Ad esempio, se l’ematologo ravvisa un sospetto di leucemia mieloide cronica decide in maniera autonoma di prescrivere l’esame cariotipo per verificare la presenza/assenza del cromosoma Philapelphia o l’indagine molecolare per verificare la presenza della malattia minima residua.
Riassumendo, il responsabile di un laboratorio di genetica non può effettuare né visite mediche né prescrizioni terapeutiche dal momento che questi atti sono di competenza del medico. Pertanto, se il medesimo responsabile invade il campo del soggetto esercente la professione medica, si applicherà l’art. 348 c.p.
Dalla ricostruzione esposta, si evincono problemi da un punto di vista pratico e teorico.
Per quanto riguarda il primo profilo, nella letteratura non si rinviene un criterio astratto ed univoco per determinare le attività riservate, in via esclusiva, al medico. Quindi, la soluzione sarebbe diversa a seconda della nozione di “atto medico” considerato.
Invece, per quanto concerne il secondo aspetto, sorgono dubbi poiché la fattispecie, per l’individuazione del precetto rimanda ad una diversa fonte normativa, la quale per descrivere un dato essenziale della norma, cioè la nozione di atto medico “riservato”, rievochi dei criteri di giudizio non legali e neppure accreditati.
Per risolvere tale problema, si potrebbe considerare il bene protetto dall’art. 348 c.p., ricavandolo dall’interpretazione e comprensione dell’elemento normativo extrapenale. In altre termini, l’interesse tutelato assume notevole rilievo per la individuazione del precetto[34].
Se quindi, si intendesse considerare la fattispecie delittuosa in analisi come strumento di salvaguardia dei beni giuridici costituzionali della vita, integrità e salute, ponendo quale garanzia una minaccia di sanzione nei confronti di personale addetto inesperto e privo di conoscenze adeguate a limitare la potenzialità lesiva degli atti medici, ne deriverebbe che la riserva statale consisterebbe nell’attività curativa in sè e per sè considerata.
Pertanto, la professione medica rappresenta l’insieme dei doveri del medico rispetto al paziente, ai colleghi, ai cittadini. Si presuppone, dunque, che tale professione comporta valutazioni diagnostiche e curative del corpo e della psiche dell’uomo. Di conseguenza, si dovrebbe reputare “libero” qualunque atto che non abbia come fine la cura della malattia.
[1] R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale. Parte generale e speciale, Roma, 2017, p. 529; M. ROMANO, Commentario sistematico al codice penale. I delitti contro la Pubblica Amministrazione, Milano, 2008, p. 144. Giova rinviare anche a Cass. Pen., sez. VI, 15 novembre 1984, in Cass. Pen., 1986, p. 459; Cass. Pen., sez. VI, 29 novembre 1983, Rosellini, ivi, 1985, p. 1058.
[2] A. PAGLIARO, Principi di diritto penale, parte speciale, 9ª ed., I, Milano, 2000, p. 421.
[3] In dottrina v. G. FIANDACA – E. MUSCO, Diritto penale. Parte speciale, I, Bologna, 2002, p. 308; E. CONTIERI, voce Esercizio abusivo di professioni, in Enc. dir., vol. XV, Milano, 1966, p. 606; in giurisprudenza v. Cass. Pen., sez. VI, 29 novembre 1983, Rosellini, in Cass. Pen., 1985, p. 1058; Cass. Pen., sez. VI, 18 ottobre 1990, Lupi, in Riv. it. med. leg., 1991, p. 264; Cass. Pen., sez. V, 18 novembre 2004, n. 3996, in C.E.D., (RV230430).
[4] G. MARCONI, Abusivo esercizio di una professione, in (a cura di) M. CATENACCI, Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia, Torino, 2011, p. 249.
[5] Cfr. per tutti, F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale. Parte Speciale, II, Milano, 2003, p. 406. Sul punto, anche, Cass. Pen., sez. VI, 16 ottobre 2008, n. 41183, in Guida dir., 2008, f. 49, p. 92; Cass. Pen., sez. VI, 15 febbraio 2007, n. 20439, in Guida dir., 2007, f. 24, p. 68.
[6] Infatti, ai casi di mancata iscrizione all’albo o di difetto di abilitazione, si possono equiparare la radiazione o la sospensione dell’esercizio della professione, per qualsiasi causa, ritenendo sussistente l’ipotesi delittuosa anche nel caso in cui vi sia una mera violazione del regime di incompatibilità. Ad esempio, un impiegato statale, il quale svolge l’attività di geometra, essendo iscritto all’albo, nonostante il divieto.
Contra, M. ROMANO, op. cit., Milano, 2008, p. 149, secondo il quale la norma non ha nulla a che vedere con l’eventuale inosservanza di doveri di esclusività del servizio, senza contare che una reazione sensata a questo genere di irregolarità sembrerebbe da trovare nei limiti di illeciti disciplinari o amministrativi in genere.
[7] Su tali profili, sia consentito il rinvio a S. MARANI, Principio di determinatezza e norma integratrice del precetto penale, Edizioni Accademiche Italiane, 2013, p. 95 ss.
[8] Cfr. per una ricostruzione di questa problematica M. MANTOVANI, L’esercizio di un’attività non autorizzata, Torino, 2003, p. 92; G. FIANDACA – E. MUSCO, op. cit., p. 308; E. CONTIERI, op. cit., p. 607; S. RICCIO, voce Professione (esercizio abusivo di una), in Noviss. dis. it., vol. XIV, Torino, 1957, p. 11.
[9] Corte Cost., 13 giugno 1983, n. 169, in Cass. Pen., 1983, p. 1927: è infondata la q.l.c. dell’art. 348 c.p. “nella parte in cui tale norma penale verrebbe integrata da una disposizione di natura esclusivamente regolamentare e priva di un adeguato grado di determinatezza, in riferimento agli artt. 25 e 27 Cost.”. Tale Corte, altresì, ha recepito un orientamento accolto anche da Cass. Pen., SS. UU., 29 novembre 1958, in Giust. pen., 1959, II, p. 1165.
[10] Cass. Pen., sez. VI, 20 giugno 2007, M., in Rass. dir. farmaceutico, 2008, 1, p. 37; Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, in Foro it., 1994, I, p. 2980.
[11] Cfr. A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte speciale, I, Delitti contro la pubblica amministrazione, Milano, 2000, p. 423.
[12] Cass. Pen., sez. VI, 29 maggio 1996, n. 2076, in Studium Juris, 1996, p. 1303; Cass. Pen., sez. VI, 3 aprile 1995, n. 9089, in Dir. pen. proc., 1996, p. 595.
[13] G. DE VINCENTIIS – E. DURANTE, Il delitto di esercizio abusivo della professione sanitaria dal punto di vista medico legale. Le norme e la giurisprudenza, in Giust. pen., 1972, I, p. 323.
[14] Cass. Pen., sez. VI, 24 ottobre 2005, n. 7564, in C.E.D. 2006.
[15] M. MANTOVANI, op. cit., p. 25.
[16] Cass. Pen., sez. VI, 3 marzo 2004, n. 17702, in Studium Juris, 2004, p. 1584; Cass. Pen., sez. VI, 11 aprile 2001, n. 500, in Cass. Pen., 2002, p. 1677.
[17] Cass. Pen., sez. VI, 8 ottobre 2002, n. 43, Notaristefano, in C.E.D. Cass, (RV223215).
[18] Significativi, in proposito, i principi della decisione della Cass. Pen., sez. VI, 8 ottobre 2002, n. 49, in Cass. Pen., 2004, p. 1, con nota di G. ARIOLLI e V. BELLINI.
[19] Cass. Pen., sez. VI, 5 luglio 2006, n. 26829, in C.E.D. 2006.
[20] Corte Cost., ordinanza 13 giugno 1983, n. 169, in Cass. Pen., 1983, p. 1927.
[21] F. ANTOLISEI, op. cit., p. 407.
[22] Nonostante vi siano parecchie fonti normative relative all’attività sanitaria, non si può tacere sul fatto che in tali fonti difettino sia l’elencazione degli atti tipici, sia la stessa definizione di professione medica. Si vedano, ad esempio, il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, recante il Testo Unico delle leggi sanitarie; il r.d. 30 settembre 1938, n. 1652, in tema di esami fondamentali e necessari per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia; il D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, relativo ai requisiti per l’iscrizione agli albi degli ordini medico-chirurgici.
[23] Questo è il pensiero di P. CIPOLLA, La responsabilità dell’omeopata per il reato di cui all’art. 348 c.p., tra principi costituzionali, disciplina positiva e orientamenti della giurisprudenza, in Giur. merito, 2006, 11, p. 2547.
[24] Cfr. Cass. Pen., sez. II, 17 dicembre 2010, n. 4641, in D&G, 2011; Cass. Pen., sez. II, 9 febbraio 1995, n. 5838, in Cass. Pen., 1997, p. 394. Sia consentito, inoltre, il rinvio a F. CROCETTI – A. CUCINO – N. MAIORANO – P. STAMPA, Manuale etico-giuridico della professione di psicologo, Bologna, 2008, p. 9 ss.
[25] Come puntualmente osservato da M. MENEGHELLO, Esercizio abusivo della professione sanitaria, in (a cura di), A. BELVEDERE – S. RIONDATO, Trattato di biodiritto. Le responsabilità in medicina, Milano, 2011, p. 1384.
[26] Cass. Pen., sez. VI, 27 marzo 2003, n. 22528, in Riv. it. med. leg., 2003, p. 427.
[27] Cass. Pen., sez. VI, 4 aprile 2005, n. 16626, in Rass. dir. farmaceutico, 2005, p. 1213.
[28] Cass. Pen., sez. VI, 20 giugno 2007, n. 34200, in Cass. Pen., 2008, p. 2412.
[29] Cass. Pen., sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 524, in Riv. giur. polizia, 1997, p. 234.
[30] Cass. Pen., sez. VI, 8 gennaio 1997, n. 1557, in Rass. dir. farm., 1998, p. 669.
[31] In particolare, nel corso della fase immediatamente precedente quella analitica, si preleva il campione biologico del paziente, dopo averne identificato la idoneità. Verificati i requisiti identificativi di trasporto e la quantità richiesta, segue la centrifugazione o preparazione del materiale e la distribuzione.
[32] Segnatamente, nella fase prettamente analitica, si effettuano le analisi richieste, con l’impiego dei metodi e della strumentazione specifica per il tipo di attività da svolgersi. Per quanto concerne la manutenzione degli strumenti, nonchè dell’esame è competente tanto il biologo, quanto il personale tecnico di laboratorio.
[33] Concluse le analisi, infine, si arriva alla refertazione. Dunque, nella fase post analitica si valutano i risultati ottenuti, in relazione agli standard di riferimento praticati. Si procede, poi, alla redazione del referto, in maniera facilmente intelligibile, con la precipua indicazione delle informazioni necessarie. E’ opportuno specificare che è di competenza del medico, e non del biologo, includere il referto nel quadro clinico del paziente; sicché è auspicabile una collaborazione tra biologo e medico.
Inoltre, al fine di garantire la genuinità dell’esito delle analisi e della loro correttezza, si devono effettuare periodicamente controlli, secondo una frequenza variabile caso per caso, in modo tale da provare la strumentazione di laboratorio, il suo funzionamento, la taratura e la calibrazione dei reagenti chimici coinvolti nel processo.
Su tali profili, sia consentito il richiamo a Il Biologo. Figura dinamica nel mondo del lavoro. Vademecum di orientamento alla professione, a cura della Commissione Permanente di studio, Rapporti con le Università, Ordine Nazionale dei Biologi, 14 novembre 2013, in www.onb.it.
[34] Nello stesso senso P. CIPOLLA, op. cit., p. 2547.



















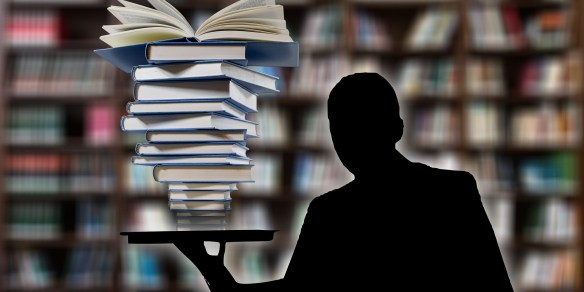

Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento