(Ricorsi rigettati)
Il fatto
La Corte d’appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia.
I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati.
Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell’erronea qualificazione giuridica del fatto con particolar riguardo alla diversa configurabilità giuridica nell’ambito del delitto preveduto dall’art. 393 c.p..
Volume consigliato
Le questioni prospettate nell’ordinanza di rimessione
I ricorsi venivano assegnati alla Seconda Sezione penale, che, con ordinanza, ne disponeva la rimessione alle Sezioni Unite rilevando l’esistenza di contrasti interpretativi in ordine alla distinzione tra i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione, alla natura giuridica (di reato comune o proprio) dei primi ed alla configurabilità del concorso in essi del terzo non titolare del diritto azionato.
In particolare, l’ordinanza di rimessione rilevava l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine ai rapporti tra i reati di cui agli articoli 629 e 393 cod. pen., peraltro circoscritto soltanto ai casi «in cui l’aggressione alla persona è funzionale alla soddisfazione di un diritto tutelabile innanzi all’autorità giudiziaria», tra i quali sarebbe rientrato quello in esame, ritenendo pacificamente configurabili come estorsioni le condotte funzionali a soddisfare pretese sfornite di tutela; sarebbero, in proposito, emersi due macro-orientamenti: (a) il primo distingue i predetti reati valorizzando le differenze esistenti sotto il profilo della materialità; (b) l’altro li distingue valorizzando le differenze esistenti sotto il profilo dell’elemento psicologico.
Nell’ambito di quest’ultimo orientamento, si evidenziava come alcune decisioni valorizzino, come elemento distintivo, soltanto la direzione della volontà dell’agente alla soddisfazione del credito, altre, invece ritengano che le modalità della condotta, e dunque l’intensità della violenza e della minaccia, rilevino ai fini della prova del dolo dell’estorsione rilevandosi al contempo che entrambi gli orientamenti presuppongono l’esistenza di un concorso apparente di norme e, dunque, di un reato “con capacità assorbente“, senza prendere in esame la possibilità del concorso formale tra i reati che potrebbe trovare plausibile legittimazione, secondo l’ordinanza di rimessione, «nella diversa collocazione sistematica delle norme che prevedono i reati di estorsione e di esercizio arbitrario e nella diversità dei beni giuridici tutelati».
Inoltre, questa Sezione rilevava l’esistenza di un ulteriore contrasto giurisprudenziale riguardante la configurabilità del concorso di persone nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 cod. pen.) che l’ultimo approdo della giurisprudenza di legittimità colloca tra i cc.dd. reati propri esclusivi o di mano propria con la conseguenza che, se la condotta tipica sia posta in essere da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio fondato sulla pretesa civilistica asseritamente vantata nei confronti della persona offesa, agente su mandato del creditore, essa non potrà mai integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma soltanto altra fattispecie mentre, nei casi in cui la condotta tipica sia invece posta in essere da chi intenda “farsi ragione da sé medesimo“, sarebbe, al contrario, configurabile il concorso (“per agevolazione“, od anche “morale“) dei terzi estranei alla pretesa civilistica vantata dall’agente nei confronti della persona offesa nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Ebbene, questo orientamento, che «indirizza chiaramente verso la qualificazione del fatto come estorsione ogni volta che la condotta violenta sia posta in essere da un terzo, sebbene su mandato del titolare del diritto che si intende soddisfare», non era condiviso dal collegio rimettente, essenzialmente perché l’art. 393 cod. pen. (come d’altro canto l’art. 392 stesso codice) indica il soggetto attivo del reato con il termine “chiunque“, e ciò indicherebbe «che ci si trov[i] al cospetto di un “reato comune”, come risulta confermato dal fatto che gli elementi costitutivi del reato (pretesa giuridicamente tutelabile in sede giudiziaria; violenza o minaccia) non riguardano, né richiamano la qualifica o la qualità del soggetto agente».
Ciò posto, con decreto, a sua volta, il Presidente Aggiunto, preso atto dell’esistenza e della rilevanza ai fini della decisione dei contrasti giurisprudenziali ravvisati dall’ordinanza di rimessione, assegnava i ricorsi alle Sezioni Unite fissandone la trattazione (dopo un rinvio dovuto alla sospensione delle attività processuali non urgenti, normativamente disposta per fronteggiare l’emergenza COVID-19) in udienza pubblica.
Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite, prima di entrare nel merito delle questioni, le delimitavano nei seguenti termini: a) “se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione all’elemento oggettivo, in particolare con riferimento al livello di gravità della violenza o della minaccia esercitate, o, invece, in relazione al mero elemento psicologico, e, in tale seconda ipotesi, come debba essere accertato tale elemento“; b) “se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni debba essere qualificato come reato proprio esclusivo e, conseguentemente, in quali termini si possa configurare il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile” .
Premesso ciò, veniva esaminata per prima la questione controversa riguardante l’individuazione del soggetto attivo dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Si osservava a tal proposito prima di tutto come la dottrina abbia osservato che il reato proprio «trova la propria genesi storica e ragione politica in una struttura sociale evoluta, in cui siano differenziate le funzioni spettanti ai singoli e, quindi, attribuiti particolari doveri e responsabilità» e si caratterizza perché il soggetto che ha una particolare qualifica acquisisce la c.d. legittimazione al reato in quanto la sua qualifica, alternativamente: I) lo pone in rapporto col bene protetto, consentendogli di arrecarvi l’offesa incriminata; II) gli conferisce la possibilità di porre in essere la condotta offensiva incriminata; III) rende opportuna l’incriminazione di fatti altrimenti non ritenuti meritevoli di pena; IV) limita la meritevolezza di un trattamento sanzionatorio di favore (come accade in favore della sola madre in relazione al reato d’infanticidio).
Oltre a ciò, veniva osservato come esso non si ponga in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.) se ed in quanto trovi ragionevole giustificazione nella tutela di interessi tali da legittimare, a seconda dei casi, il trattamento deteriore o di favore.
Detto questo, le Sezioni Unite facevano presente come l’incriminazione dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni risponda ad una esigenza istintivamente avvertita dalle coscienze dei popoli sin dai primordi del diritto penale: il diritto romano incriminava l’impossessamento delle cose del proprio debitore contro la volontà di quest’ultimo e la sottrazione violenta della propria res posseduta da terzi; il diritto intermedio puniva, in linea di principio, l’impossessamento violento della cosa propria posseduta, anche se illegittimamente, da terzi e l’uso delle armi per farsi giustizia, pur tollerando talora l’impiego delle armi per la rivendicazione dei propri diritti trattandosi, peraltro, di fattispecie non paragonabili al tipo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni inteso nel senso moderno.
Il precedente immediato degli articoli 392 e 393 cod. pen., invece, era costituito dall’articolo 235 del codice penale Zanardelli del 1889, a sua volta promanante dall’art. 146 del codice toscano del 1853 e dagli artt. 286 e seguenti del codice penale sardo-italiano del 1859.
Orbene, con riguardo all’individuazione del soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (con violenza sulle cose oppure alle persone), le Sezioni Unite notavano come la dottrina fosse divisa.
Se infatti la dottrina tradizionale qualificava i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reati comuni, che potevano essere commessi da “chiunque” agisse come privato (e non come pubblico ufficiale etc.) e non avesse il possesso della res oggetto di contesa, e precisava che «insieme con colui che agisce per esercitare un preteso diritto possono concorrere persone che non abbiano alcun preteso diritto da far valere fermo restando che costoro, nondimeno, rispondono dello stesso titolo delittuoso, in base alle norme generali sulla compartecipazione criminosa» e sebbene una Parte minoritaria della dottrina più recente avesse ribadito l’orientamento essenzialmente valorizzando il termine “chiunque” con il quale gli articoli 392 e 393 cod. pen. indicano il soggetto attivo dei predetti reati, l’orientamento senz’altro dominante in seno alla dottrina più recente ritiene, al contrario, che i reati in oggetto abbiano natura di reato proprio potendo essere commessi unicamente dal titolare del preteso diritto, dal soggetto che eserciti legittimamente in sua vece il predetto diritto e dal negotiorum gestor fermo restando come sia stato, talora, precisato che il terzo non titolare del preteso diritto che ne reclami arbitrariamente soddisfazione deve avere un particolare legame con il creditore ed essere assolutamente privo di un interesse proprio.
Conclusa questa disamina scientifica, sotto il versante giudiziale, veniva evidenziato come le prime decisioni giurisprudenziali intervenute in argomento (Cass. 25 luglio 1934, Giust. pen., 1935, II, 799; Cass. 17 giugno 1936, Giust. pen., 1936, II, 1068) avessero ritenuto che «il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è configurabile anche se il soggetto attivo abbia usato violenza per esercitare una pretesa giuridica accampata da altri, se ciò sia, però, avvenuto in nome e vece del titolare, come nel caso di mandatari, congiunti o dipendenti, e nell’interesse esclusivo di lui» deducendosi al contempo che questo orientamento, che richiede sempre e comunque il coinvolgimento nel reato di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen. del soggetto “qualificato“, ovvero il titolare del preteso diritto azionato, è stato in seguito costantemente ribadito.
E’ stata difatti ammessa la configurabilità dei reati in oggetto anche nei casi in cui il preteso diritto appartenga a soggetto diverso dall’agente a condizione che quest’ultimo non sia animato da finalità proprie: in particolare, Sez. 6, n. 8434 del 30/04/1985, riconobbe che soggetto attivo del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere anche colui che eserciti un diritto pur non avendone la titolarità, ma agendo per conto dell’effettivo titolare (nel caso esaminato, l’imputata aveva consumato il delitto esercitando, nella sua qualità di coniuge, una pretesa di natura reale vantata dal consorte e nell’interesse di questo ultimo); secondo Sez. 2, n. 8778 del 09/04/1987, «ai fini della sussistenza del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all’art. 393 cod. pen., riconosciuto che l’agente può operare anche a vantaggio di un terzo, non è necessario che l’interessato abbia conferito mandato o dato informale incarico al soggetto di operare per suo conto, ne’ che la ragione vantata sia effettivamente realizzabile in giudizio (è sufficiente, infatti, il convincimento della legittimità della pretesa), ne’ è richiesta l’impossibilità per l’interessato di far valere personalmente il proprio diritto»; nel medesimo senso, si è anche ritenuto che «il reato di “ragion fattasi” di cui all’art. 393 cod. pen. non è escluso dalla circostanza che il preteso diritto appartenga a soggetto diverso dall’agente, se questi, nella qualità di negotiorum gestor e senza la necessità di investiture formali, operi nel di lui interesse, concorrendo, così, nella commissione del reato» (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991; conformi, Sez. 6, n. 14335 del 16/03/2001: fattispecie relativa all’arbitrario esercizio di un diritto del quale era titolare il coniuge del soggetto agente; Sez. 6, n. 15972 del 05/04/2001; Sez. 6, n. 1257 del 03/11/2003,: fattispecie in cui la violenza sulle cose era stata attuata per esercitare il presunto diritto di proprietà di un figlio dell’agente).
A fronte di ciò, si sottolineava come quest’orientamento fosse stato più recentemente ribadito da Sez. 6, n. 23322 del 08/03/2013 per la quale: «soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose può essere anche chi esercita il preteso diritto pur non avendone la titolarità, in quanto, ai fini della configurabilità del delitto, rileva che l’agente si comporti come se fosse il titolare della situazione giuridica e ne eserciti le tipiche facoltà» (principio affermato con riferimento ad un caso nel quale l’imputato, al fine di assicurare la somministrazione di energia elettrica al fondo del padre, aveva collocato nel fondo di un vicino dei pali perché l’Enel potesse esercitare la servitù di elettrodotto).
Ebbene, terminato di illustrare questo panorama giurisprudenziale, gli Ermellini affermavano, in questa pronuncia, come i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni abbiano natura giuridica di reati propri.
Si evidenziava a tal proposito come la dottrina sia pressoché concorde nel ritenere che, attraverso l’incriminazione dei fatti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è stato perseguito «lo scopo di impedire la violenta sostituzione dell’attività individuale all’attività degli organi giudiziari» onde evitare «che il privato si faccia ragione con le proprie mani, compromettendo la pubblica pace»; coerentemente con tale ratio dell’incriminazione, «l’oggetto della tutela è stato ravvisato in un interesse pubblico, e precisamente nell’interesse dell’Autorità giudiziaria all’esercizio esclusivo dei suoi poteri», e le relative norme incriminatrici sono state collocate nel titolo del codice penale relativo ai delitti contro l’amministrazione della giustizia.
Ciò posto, veniva fatto altresì presente che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni assume rilevanza penale se commesso con violenza sulle cose o con violenza o minaccia alle persone.
Come pure evidenziato dalla dottrina, e come già emerso in seno alla giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 15972 del 05/04/2001), nel reato previsto dall’art. 392 cod. pen. ricorrono sempre o quasi gli estremi del fatto di danneggiamento (art. 635 cod. pen.), mentre in quello previsto dal successivo art. 393 sono configurabili in ogni caso gli estremi del delitto di violenza privata (art. 610 cod. pen.): l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni è, tuttavia, punito meno gravemente dei delitti che in esso sono necessariamente contenuti (salvo che nel caso del danneggiamento non aggravato, trasformato in illecito civile dall’art. 4, comma 1, d. Igs. n. 7 del 15 gennaio 2016), nonostante il fatto che, rispetto al danneggiamento previsto dal testo attualmente vigente dell’art. 635 cod. pen. ed alla violenza privata, in esso, alla lesione, rispettivamente, del patrimonio o della persona, si aggiunga l’offesa dell’interesse all’amministrazione della giustizia; inoltre, nonostante comporti anche la lesione di un interesse pubblico, esso è perseguibile non d’ufficio, ma a querela di parte, il che comporta che il danneggiamento e la violenza privata, ordinariamente procedibili d’ufficio, quando ledono una prerogativa dell’Autorità giudiziaria, oltre ad essere puniti meno gravemente, diventano procedibili a querela di parte.
Alla stregua di quanto appena esposto, si conveniva pertanto con la dottrina che questa disciplina trova l’unica plausibile giustificazione nella considerazione che «il fatto di agire col convincimento di esercitare un diritto è sentito dalla coscienza sociale come un motivo di attenuazione della pena»; in proposito, un pur risalente precedente di questa Corte (Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969) aveva osservato che, nei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’agente opera con il convincimento di esercitare un suo diritto il che è avvertito dalla coscienza sociale come motivo di attenuazione della pena ed importa che i delitti in oggetto vengano considerati dalla legge, nella loro essenza unitaria, come una forma attenuata di danneggiamento, nell’ipotesi di cui all’art. 392 cod. pen., o di violenza privata, in quella di cui all’art. 393 c.p. così come la medesima ratio può ritenersi suscettibile anche di affievolire l’interesse statale all’esercizio della pretesa punitiva, destinato ad insorgere soltanto a seguito della tempestiva iniziativa del presunto debitore/querelante.
I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si caratterizzano, quindi, per il fatto che il soggetto, che vanta la titolarità di un preteso diritto, e per tale ragione potrebbe “ricorrere al giudice“, acquisisce la c.d. legittimazione al reato in quanto la sua qualifica limita la meritevolezza di un trattamento processuale e sanzionatorio indiscutibilmente di favore; detto trattamento di favore non si pone in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), trovando ragionevole giustificazione nella tutela di un interesse che lo legittima fermo restando che non costituisce apprezzabile ostacolo alla qualificazione dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reati propri, l’indicazione, negli articoli 392 e 393 cod. pen., del soggetto attivo come “chiunque”, al contrario sic et simpliciter valorizzata da parte minoritaria della dottrina più recente e dalla stessa ordinanza di rimessione atteso che, per confutare l’assunto, appare per la Suprema Corte sufficiente ricordare che in numerosi reati pacificamente “propri”, il soggetto attivo è normativamente indicato in “chiunque“: si pensi, per tutti, alla falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) ed addirittura all’incesto (art. 564 cod. pen.).
Ebbene, per il Supremo Consesso, il “chiunque” indicato dagli articoli 392 e 393 cod. pen. è, dunque, soltanto il soggetto che potrebbe ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto.
Secondo il tradizionale e consolidato insegnamento della giurisprudenza civile, l’istituto della negotiorum gestio, previsto e disciplinato dagli artt. 2028 ss. cod. civ., postula lo svolgimento di un’attività, da parte del gestore, diretta al conseguimento dell’esclusivo interesse di un altro soggetto, caratterizzato dall’assoluta spontaneità dell’intervento del gestore, e quindi dalla mancanza di un qualsivoglia rapporto giuridico in forza del quale egli sia tenuto ad intervenire nella sfera giuridica altrui (Sez. 3, n. 23823 del 22/12/2004; Sez. 1, n. 16888 del 24/07/2006) così come, sempre sotto il profilo civilistico, la legittimazione ad esercitare nel processo un diritto altrui è eccezionale (cfr. art. 81 cod. proc. civ., a norma del quale, “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”).
A fronte di ciò, sebbene nella giurisprudenza penale di legittimità sia talora emersa la preoccupazione che, legittimando incondizionatamente il terzo ad attivarsi in luogo del reale creditore, il debitore/vittima possa trovarsi esposto a danni ulteriori rispetto a quelli connaturali alle fattispecie di reato tipiche perché «costretto a versare denaro nelle mani di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, senza alcuna garanzia di effetto liberatorio» (Sez. 5, n. 5193 del 27/02/1998) potendo in tali casi ingenerarsi una situazione «che non avrebbe permesso alla vittima di ottenere garanzie dell’estinzione del proprio debito con il versamento sollecitato» (Sez. 6, n. 41329 del 19/10/2011), la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (a seconda dei casi, con violenza sulle cose oppure con violenza o minaccia alle persone) delle condotte poste in essere sponte da terzi non appartenenti al nucleo familiare del creditore (coniuge, figlio, genitore, come emerso nella casistica giurisprudenziale innanzi riepilogata), che si siano attivati di propria iniziativa, senza previo concerto o comunque non d’intesa con il creditore, comporterebbe però l’immotivata applicazione del previsto regime favorable che trova giustificazione anche quanto al rispetto del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. proprio e soltanto nella contrapposizione tra un presunto creditore ed un presunto debitore che a loro volta risolvono la propria controversa senza adire le vie legali pur potendo farlo (il creditore ricorrendo al giudice civile, il debitore sporgendo querela).
Nel caso in cui il presunto creditore sia del tutto estraneo all’iniziativa del terzo negotiorum gestor, non potrà, quindi, essere configurato per i giudici di piazza Cavour un reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ma ricorreranno quanto meno (e salvo quello che si osserverà in seguito con riguardo ai rapporti tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione) gli estremi dei corrispondenti reati comuni (danneggiamento o violenza privata).
Orbene, una volta affermata la natura di reato proprio dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per le Sezioni Unite, era necessario affrontare la questione accessoria e consequenziale, ovvero se si tratti, o meno, di un reato proprio esclusivo, o di mano propria.
Per rispondere a tale quesito, si faceva prima di tutto presente come l’orientamento attualmente dominante nella giurisprudenza della Cassazione, premesso che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere commesso, ai sensi degli artt. 392 e 393 cod. pen., unicamente da “chiunque … si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo“, ritenga che quest’ultima espressione induca a ritenere che i predetti reati rientrino tra i cc.dd. reati propri esclusivi, o di mano propria, che si caratterizzano in quanto richiedono che la condotta tipica deve essere posta in essere dal soggetto “qualificato” ovvero, nel caso di specie, dal presunto creditore: di conseguenza, quando la condotta tipica di violenza o minaccia prevista dagli artt. 392 e 393 cod. pen. sia posta in essere da un soggetto diverso dal creditore ovvero estraneo al rapporto obbligatorio che fonderebbe la pretesa azionata, ad avviso della Cassazione, non potrebbe ritenersi integrato l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e ciò in quanto tale assunto sarebbe corroborato dalla particolare oggettività giuridica dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni posti a tutela anche dell’interesse statuale al ricorso obbligatorio alla giurisdizione (il c.d. monopolio giurisdizionale) nella risoluzione delle controversie in riferimento al quale, se può — in determinati casi (ovvero in difetto della presentazione della querela da parte del soggetto a ciò legittimato) – essere tollerato che chi ne ha diritto si faccia ragione “da sé medesimo“, non può mai essere tollerata l’intromissione del terzo estraneo che si sostituisca allo Stato esercitandone le inalienabili prerogative nell’amministrazione della giustizia (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016,; nel medesimo senso, pur implicitamente, Sez. 5, n. 5241 del 20/06/2014; Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016; Sez. 2, n. 20/12/2017; Sez. 1, n. 6968 del 20/07/2017).
Del resto, si evidenziava come a siffatto orientamento mostrassero di aderire anche Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, e Sez. 2, n. 31725 del 05/04/2017, che avevano configurato il reato di cui all’art. 393 cod. pen. con riferimento ad una fattispecie nella quale l’imputato (un avvocato nell’esercizio del proprio mandato professionale) aveva inviato una missiva con richieste di rilevanti somme di denaro per chiudere la controversia minacciando altrimenti denunce che avrebbero portato l’emissione di provvedimenti applicativi di misure cautelari nei confronti della controparte e del suo difensore osservando che «il professionista che agisca nell’interesse di un cliente non può considerarsi “estraneo” alla contesa che opponga il proprio patrocinato ad un terzo (…): l’avvocato è una parte tecnica che si affianca alla parte sostanziale della contesa, nella conclusiva unitarietà di una parte complessa».
Si notava, tra l’altro, come il riferimento al farsi ragione «da sé medesimo», mai valorizzato dalla giurisprudenza tradizionale, fosse stato generalmente interpretato dalla dottrina come pleonastico.
Secondo la dottrina tradizionale, invero, l’espressione “farsi ragione da sé medesimo” significa unicamente «realizzare con le proprie forze quella pretesa che l’agente ritiene giusta in sé: per rendersi, insomma, giustizia da sé stesso»; essa evocherebbe, quindi, «null’altro che la realizzazione dello scopo (di regola economico) al cui soddisfacimento è preordinato il diritto che si vanta».
Nell’ambito della dottrina più recente, si è ritenuto che l’espressione integri la materialità dei reati in oggetto evocando o l’arbitraria realizzazione di una situazione di fatto corrispondente al preteso diritto oppure l’impiego della forza privata per realizzare la pretesa; talora essa è stata interpretata in duplice accezione, «in un’ottica oggettivistica non è niente altro che il momento realizzativo dello scopo economico del diritto esercitato; in chiave soggettivistica l’autosoddisfazione è invece la affermazione unilaterale ed autoritaria di una situazione attualmente o potenzialmente favorevole al reo, tale da mostrarsi soltanto “congrua” rispetto al diritto al fine dell’esercizio del quale essa è realizzata».
Orbene, in relazione a tali considerazioni giuridiche, le Sezioni Unite ritenevano che l’orientamento che considera i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni come reati propri esclusivi, o di mano propria, non potesse essere condiviso.
Il riferimento, per integrare la descrizione della fattispecie tipica di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, alla necessità che il soggetto che vanta il preteso diritto si faccia ragione “da sé medesimo“, già esistente nell’art. 235 del codice penale Zanardelli del 1889, infatti, è stato mutuato dall’art. 146 del codice toscano del 1853, in relazione al quale esso era stato pacificamente interpretato dalla dottrina come meramente descrittivo: «quando chi crede di avere una pretesa giuridica sostituisce la sua forza al potere del giudice, si fa ragione da sé medesimo. Perciò i giureconsulti toscani denominarono l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni: ragion fattasi».
I lavori preparatori del codice penale del 1889, a loro volta, non avevano attribuito all’espressione un diverso significato: i verbali della Commissione istituita con R.D. 13 dicembre 1888 (cfr. intervento del relatore Auriti) confermano, anzi, che l’espressione “da sé medesimo” esprime unicamente «la surrogazione dell’arbitrio individuale al potere della pubblica Autorità, in che il reato consiste».
I lavori preparatori del codice penale del 1930 erano, invece, sul punto, assolutamente silenti.
Tali rilievi, dunque, ad avviso delle Sezioni Unite, consentivano di confermare il significato meramente pleonastico tradizionalmente attribuito all’espressione in oggetto, mai messo in discussione, unitamente alla genericità di essa, di per sé considerata, così come non consentivano di avvalorare l’orientamento che la valorizza per argomentare la natura giuridica di reati propri esclusivi, o di mano propria, dei reati de quibus.
Chiarita tale questione giuridica, gli Ermellini ritenevano opportuno esaminare, a questo punto della disamina, i rapporti tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione.
Nel far ciò, si evidenziava come, sin da epoca risalente, la giurisprudenza della Cassazione avesse ritenuto che il criterio differenziale tra i delitti di cui agli articoli 629 e 393 cod. pen. consiste nell’elemento intenzionale in quanto, nel primo, l’intenzione dell’agente è di procurarsi un ingiusto profitto mentre, nel secondo, il reo agisce per conseguire un’utilità che ritiene spettargli nonostante che il suo diritto sia contestato o contestabile, senza adire l’Autorità giudiziaria (Cass. 21 gennaio 1941, Giust. pen., 1941, II, 810, 1078; Cass. 27 marzo 1950, Riv. pen., 1950, 679).
Ponendosi sulla scia di questo pur risalente insegnamento, in epoca successiva, l’orientamento prevalente sempre elaborato in sede nomofilattica aveva distinto i delitti di cui agli articoli 393 e 629 cod. pen. essenzialmente in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se in ipotesi infondata, di esercitare un suo diritto giudizialmente azionabile; nell’estorsione, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza di non averne diritto (Sez. 2, n. 56400 del 22/11/2018; Sez. 1, n. 6968 del 20/07/2017; Sez. 2, n. 1901 del 20/12/2016; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016; Sez. 2, n. 46628 del 03/11/2015; Sez. 2, n. 44674 del 30/09/2015; Sez. 2, n. 42734 del 30/09/2015; Sez. 2, n. 23765 del 15/05/2015; Sez. 2, n. 42940 del 25/09/2014; Sez. 2, n. 31224 del 25/06/2014; Sez. 2, n. 24292 del 29/05/2014; Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014; Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013; Sez. 2, n. 705 del 01/10/2013, dep. 201; Sez. 2, n. 22935 del 29/05/2012; Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010; Sez. 2, n. 9121 del 19/04/1996; Sez. 2, n. 6445 del 14/02/1989; Sez. 2, n. 5589 del 12/11/1982,).
Nell’ambito di questo orientamento, si notava come dovesse essere anche collocata Sez. 6, n. 58087 del 13/09/2017, per la quale il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non già in base alla intensità della violenza che connota la condotta, bensì in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, è volta al conseguimento di un profitto ingiusto e, nell’altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile: in tal caso, infatti, l’ingiusto profitto sussiste sia nel caso in cui il vantaggio ricercato dal reo coincida con il prezzo della liberazione, sia nel caso in cui detto vantaggio derivi dall’esecuzione di un pregresso rapporto illecito con la vittima del reato, trattandosi di una pretesa non tutelabile dinanzi all’autorità giudiziaria.
A fronte di ciò, si evidenziava come un altro orientamento avesse, al contrario, valorizzato, ai fini della distinzione, la materialità del fatto, affermando che, nel delitto di cui all’art. 393 cod. pen., la condotta violenta o minacciosa non è fine a sé stessa ma risulta strettamente connessa alla finalità dell’agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, per cui non può mai consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza: di conseguenza, quando la minaccia o la violenza si estrinsechino in forme di forza intimidatoria e sistematica pervicacia tali da eccedere ogni ragionevole intento di far valere un diritto, la coartazione dell’altrui volontà è finalizzata a conseguire un profitto che assume ex se i caratteri dell’ingiustizia ed, in determinate circostanze e situazioni, anche la minaccia dell’esercizio di un diritto, di per sé non ingiusta, può diventare tale, se le modalità in cui essa risulti formulata denotino una prava volontà ricattatoria che le facciano assumere connotazioni estorsive (Sez. 5, n. 35563 del 15/07/2019; Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017; Sez. 6, n. 11823 del 07/02/2017; Sez. 2, n. 1921 del 18/12/2015; Sez. 2, n. 44657 del 08/10/2015; Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015; Sez. 6, n. 17785 del 25/03/2015; Sez. 2, n. 9759 del 10/02/2015; Sez. 1, n. 32795 del 02/07/2014; Sez. 5, n. 19230 del 06/03/2013; Sez. 5, n. 28539 del 14/04/2010; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010; Sez. 6, n. 32721 del 21/06/2010; Sez. 2, n. 35610 del 27/06/2007; Sez. 2, n. 14440 del 15/02/2007; Sez. 2, n. 47972 del 01/10/2004; Sez. 1, n. 10336 del 02/12/2003).
Nell’ambito di questo orientamento, si osservava come fosse enucleabile un sottoorientamento, ampiamente illustrato nell’ordinanza di rimessione, a parere del quale il delitto di estorsione sarebbe configurabile quando la condotta minacciosa o violenta, anche se finalisticamente orientata al soddisfacimento di un preteso diritto, si estrinsechi nella costrizione della vittima attraverso l’annullamento della sua capacità volitiva mentre sarebbe, invece, configurabile il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando un diritto giudizialmente azionabile venga soddisfatto attraverso attività violente o minatorie che abbiano un epilogo “non costrittivo“, ma “più blandamente persuasivo” (così, più o meno pedissequamente, Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016; Sez. 2, n. 55137 del 03/07/2018; Sez. 2, n. 36928 del 04/07/2018).
In dottrina, si evidenziava come fosse unanime il convincimento che i due reati in oggetto si distinguano in relazione al fine perseguito dall’agente.
Se, invero, le dottrine tradizionali avevano affermato che, nel caso in cui l’agente «non agì per trarre ingiusto profitto dall’azione o dall’omissione imposta al soggetto passivo, ma per uno scopo diverso, potrà ricorrere il titolo di (..) esercizio arbitrario delle proprie ragioni, o altro; ma non quello di estorsione», precisando che «spesso però l’affermazione di voler esercitare un opinato diritto (…), non è che un pretesto per larvare l’estorsione», ed ammonendo i giudici quanto all’opportunità di adoperare «molta cautela nell’accertare il vero scopo dell’agente» e, naturalmente, «pur mirando l’agente anche a conseguire il profitto relativo a un preteso diritto esistente o supposto, la estorsione sussist[e] quando egli chieda più di ciò che tale diritto comporta»; si ammetteva che l’estorsione presentasse tratti comuni con l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, «ma a stabilirne la diversità basta l’elemento psicologico, che nel secondo consiste nel fine di esercitare un preteso diritto, quando si abbia la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria», altra dottrina aveva successivamente ritenuto che l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni «richiede il fine di esercitare un preteso diritto azionabile e l’estorsione la coscienza e volontà di conseguire un profitto non fondato su alcuna pretesa giuridica» così come, nel medesimo senso, la dottrina più recente affermava che «il criterio discretivo tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni si fonda sulla finalità perseguita dall’agente: nell’esercizio arbitrario il soggetto attivo, supponendo di essere titolare di un diritto, agisce con lo scopo di esercitarlo, mentre nell’estorsione l’agente è consapevole di conseguire un ingiusto profitto».
Orbene, una volta terminato di illustrare questi orientamenti scientifici, le Sezioni Unite ritenevano che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenzino tra loro in relazione all’elemento psicologico.
Si rilevava a tal riguardo prima di tutto che la materialità dei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione non appare esattamente sovrapponibile (così Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016) poiché, soltanto ai fini dell’integrazione della fattispecie tipica di estorsione, è normativamente richiesto il verificarsi di un effetto di “costrizione” della vittima, conseguente alla violenza o minaccia, queste ultime costituenti elemento costitutivo comune ad entrambi i reati (art. 392 cod. pen.: “mediante violenza sulle cose“; art. 393 cod. pen.: “usando violenza o minaccia alle persone“; art. 629 c.p.: “mediante violenza o minaccia“): all’uopo occorre, secondo la dottrina più recente, «che vi sia un nesso causale tra la condotta e la situazione di coazione psicologica che costituisce, a sua volta, l’evento intermedio tra la condotta stessa e l’atto di disposizione patrimoniale che arreca l’ingiusto profitto con altrui danno. Si tratta di un evento psicologico che deve essere causato direttamente dalla condotta del soggetto attivo del reato: se l’effetto di coazione trovasse nell’azione o nell’omissione dell’autore solo uno dei tanti antecedenti non potrebbe mai parlarsi di estorsione. La coazione psicologica si risolve, essenzialmente, nella compressione della libertà di autodeterminazione suscitata dalla paura del male prospettato».
Cionondimeno, come già rilevato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016), la possibile valenza dimostrativa di tale disomogeneità strutturale può agevolmente essere ridimensionata ove si pensi che l’effetto costrittivo della condotta estorsiva appare consustanziale proprio alla diversa finalità dell’agente, che mira ad ottenere una prestazione non dovuta, dalla quale l’agente trae profitto ingiusto, e la vittima un danno; diversamente, nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, secondo la Suprema Corte, la violenza o minaccia mira ad ottenere dal debitore proprio e soltanto la prestazione dovuta, come in astratto giudizialmente esigibile.
D’altro canto, sempre secondo il Supremo Consesso, il riferimento all’effetto “costrittivo” della condotta appare, nella sistematica codicistica, piuttosto finalizzato a distinguere il reato di estorsione, previsto e punito dall’art. 629 cod. pen., da quello di rapina, previsto e punto dal precedente art. 628 cod. pen.: come chiarito dalla stessa Relazione del Guardasigilli al Re sul Libro I del Progetto del codice penale del 1930 (pag. 450), infatti, «premesso che in entrambe tali ipotesi delittuose la spogliazione in danno della vittima di consuma mercé violenza o minaccia, il Progetto coglie la nota differenziale dei due delitti negli effetti della coercizione usata, riscontrando la rapina, se l’agente s’impossessa egli stesso della cosa altrui, e l’estorsione, se la persona, a cui la violenza o la minaccia è diretta, è obbligata a consegnare la cosa».
Il criterio in questione, a sua volta, è stato pacificamente accolto dalla giurisprudenza della Cassazione che distingue correntemente le due fattispecie proprio osservando che, nella rapina, il reo sottrae la res esercitando sulla vittima una violenza od una minaccia diretta e ineludibile mentre, nell’estorsione, la coartazione non determina il totale annullamento della capacità del soggetto passivo che è soltanto “costretto” a determinarsi come gli viene imposto dal soggetto agente ma potrebbe determinarsi diversamente (così Sez. 2, n. 44954 del 17/10/2013).
Ebbene, una volta rilevato che, come già evidenziato, tra le altre, da Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, e Sez. 2, n. 51433 del 04/12/2013, sia l’art. 393, comma terzo, cod. pen. che l’art. 629, comma 2, cod. pen. (in quest’ultimo caso, mediante richiamo dell’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.), prevedono che la pena è aumentata «se la violenza o minaccia è commessa con armi», senza legittimare distinzioni tra armi bianche ed armi da fuoco: è quindi normativamente prevista la qualificazione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, aggravato dall’uso di un’arma, anche di condotte poste in essere con armi tali da rendere la violenza o la minaccia di particolare gravità, ovvero “costrittiva” e comunque “sproporzionata” rispetto al fine perseguito, detto riferimento appare decisivo per il Supremo Consesso atteso che, secondo il contrario orientamento, siffatta condotta dovrebbe sempre integrare gli estremi del più grave delitto di estorsione, il che, per espressa previsione di legge, non è.
Del resto, la stessa Relazione del Guardasigilli al Re sul progetto del Codice penale, pur in estrema sintesi (pag. 158), osserva che la fattispecie tipica di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è «comprensiva d’ogni specie di violenza, fisica o morale», senza attribuire, quindi, alcuna rilevanza al quantum di violenza esercitata oppure alla gravità della minaccia profferita fermo restando come sia stato già evidenziato dalla Cassazione (Sez. 6, n. 45064 del 12/06/2014) che le norme sostanziali poste a confronto non contengono alcuna gradazione (né “verso l’alto” né “verso il basso“) delle modalità espressive della condotta violenta o minacciosa, e che le fattispecie si distinguono in base al solo finalismo della condotta medesima, che in un caso è mirata al conseguimento di un profitto ingiusto, e nell’altro allo scopo, soggettivamente concepito in modo ragionevole, di realizzare, pur con modi arbitrari, una pretesa giuridicamente azionabile.
In questa prospettiva, il livello offensivo della coercizione finisce con l’incidere sulla gradazione della pena ma non sulla qualificazione del fatto: risulta, pertanto, evidente la «carenza di tipicità che si connette all’enucleazione, in assenza di qualsiasi segnale linguistico, di una sottofattispecie delle nozioni di violenza e minaccia, così “gravemente intimidatorie” da connotare ex se di ingiustizia qualunque finalismo, e dunque sostanzialmente da annullare la funzione definitoria del corrispondente riferimento alla specifica connotazione del profitto perseguito dall’estorsore».
Si concludeva quindi nel senso che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all’elemento psicologico: nel primo, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria mentre nel secondo, invece, l’agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.
Oltre a ciò, veniva fatto presente che, ai fini dell’integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall’agente deve corrispondere esattamente all’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato e l’agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016).
Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell’illegittima tutela privata sia realmente esistente, ad avviso del Supremo Consesso, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016) poiché il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilità di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017).
Detta verifica deve essere inoltre preliminare: «i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all’autorità giudiziaria del preteso diritto cui l’azione del reo era diretta, giacché tale requisito – che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare – deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua del secondo» (Sez. 2, n. 52525 del 10/11/2016) fermo restando che, in applicazione di tale principio, sia già stata, ad esempio, ritenuta la configurabilità del delitto di estorsione, e non dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, nei confronti del creditore che eserciti una minaccia per ottenere il pagamento di interessi usurari poiché in tal caso egli è consapevole di porre in essere una condotta per ottenere il soddisfacimento di un profitto ingiusto in quanto derivante da una pretesa contra ius (Sez. 2, n. 9931 del 09/03/2015; Sez. 2, n. 26235 del 12/05/2017).
Inoltre, se orientamenti risalenti della giurisprudenza della Cassazione (Cass. 23 gennaio 1952, Riv. it. dir. pen., 1952, 419; Sez. 6, n. 1835 del 15/10/1969) e parte della dottrina tradizionale, premesso che per la sussistenza del delitto di cui all’art. 393 cod. pen. la legge richiede soltanto l’uso della violenza o minaccia alla persona, avevano ritenuto non necessario che la persona rimasta vittima della violenza o della minaccia fosse quella in conflitto d’interessi con l’agente poiché si dovrebbe avere riguardo, non tanto e non solo alla persona verso la quale si indirizza la violenza o la minaccia, «ma al nesso di mezzo al fine che tra il fatto violento o la minaccia e il proposito di farsi ragione da sé deve ricorrere» con l’ulteriore conseguenza che il reato, sempre che un tale nesso sia riscontrabile, sarebbe completo in tutti i suoi elementi anche se la violenza o minaccia siano dirette non contro l’antagonista del soggetto attivo, ma contro altra e diversa persona, per le Sezioni Unite, questo orientamento deve ritenersi ormai superato e comunque non condivisibile proprio in considerazione del fatto che la sussistenza del requisito della tutelabilità dinanzi all’autorità giudiziaria del preteso diritto cui l’azione del reo è diretta va verificata preliminarmente (poiché commette il reato di cui all’art. 393 cod. pen. “chiunque” possa ricorrere al giudice al fine di esercitare un preteso diritto) e quindi risulta evidente che l’agente non potrebbe azionare in giudizio la sua pretesa chiamando in causa, in garanzia, e senza titolo alcuno, i terzi oggetto di violenza o minaccia.
Come già correttamente ritenuto, in più occasioni, dalla Cassazione, per le Sezioni Unite, è, pertanto, configurabile, il delitto di estorsione nei casi in cui l’agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un terzo assolutamente estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes dal quale scaturisce la pretesa azionata, per costringere il debitore ad adempiere (Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi minacce in danno del figlio e della moglie; Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018) poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all’Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell’ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio).
Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo, per i giudici di piazza Cavour, l’esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista purché l’agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell’estorsione mentre, invece, l’agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima ma tende all’ottenimento dell’evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli.
Ciò posto, a sua volta l’elemento psicologico del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e quello del reato di estorsione vanno accertati secondo le ordinarie regole probatorie: alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà, pertanto, riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione posto che la Cassazione è ferma nel ritenere, in generale, che la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell’imputato, ha natura indiretta dovendo essere desunta da elementi esterni ed, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente (Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018); con specifico riferimento al tema in esame, si è inoltre osservato che «il dolo può essere tratto solo da dati esteriori, che ne indicano l’esistenza, e servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisionale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex ante» e, di conseguenza, «le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l’intensità dell’intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell’art. 393 c.p.», ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile (Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015).
Oltre a quanto sin qui esposto, veniva notato come un orientamento abbia ritenuto che integra sempre gli estremi dell’estorsione aggravata dal c.d. “metodo mafioso” (già art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. I. n. 203 del 1991, ora art. 416-bis.1 cod. pen.), e non dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ugualmente aggravato, la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali formulate dal presunto creditore e da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio in danno della persona offesa estrinsecatesi nell’evocazione dell’appartenenza di entrambi ad una organizzazione malavitosa di tipo mafioso, per l’estrema incisività della forza intimidatoria esercitata, costituente indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto ed esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015) ma tale orientamento veniva stimato non condivisibile poiché la formulazione dell’art. 416-bis.1 cod. pen. non consente di affermare che la circostanza aggravante in oggetto sia assolutamente incompatibile con il reato di cui all’art. 393 cod. pen.; residua al più la possibilità di valorizzare l’impiego del c.d. “metodo mafioso” unitamente ad altri elementi, quale elemento sintomatico del dolo di estorsione.
A ben vedere, secondo le Sezioni Unite, il denunciato contrasto di orientamenti riguardante la distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 cod. pen. risultava essere più apparente che reale.
Limitando l’ulteriore disamina da doversi compiere alle decisioni più recenti e significative, nella fattispecie esaminata da Sez. 5, n. 35563 del 17/07/2019, il creditore, agendo con metodo mafioso, aveva dato alle fiamme una minipala nel giardino di una villa di proprietà della persona offesa, con il rischio che il fuoco si propagasse anche all’immobile, arrecando un danno ben superiore rispetto all’entità del credito vantato: in siffatta situazione, l’impiego del metodo mafioso, che aveva comportato l’attuazione della pretesa in forme che, richiamando alla mente del soggetto passivo il potere di intimidazione dell’associazione criminale e la promessa di passare ad ulteriori e più gravi danneggiamenti, ed il rischio di cagionare al debitore danni sproporzionati rispetto all’entità del debito, senz’altro esorbitanti rispetto al fine di ottenere il pagamento del credito ed idonei ad annichilire le capacità di reazione della persona offesa, integravano certamente il necessario dolo di estorsione.
Nella fattispecie esaminata da Sez. 2, n. 33712 del 08/06/2017, la stessa decisione dava preliminarmente atto come l’imputato non vantasse alcun credito ragionevolmente azionabile nei confronti del debitore, e tale rilievo risultava senz’altro assorbente.
Nella fattispecie esaminata da Sez. 2, n. 1921 del 18/12/2015, dep. 2016, si era accertato come l’agente avesse richiesto al proprio debitore «una somma maggiore di quanto dalla stessa in precedenza richiesto perché a suo dire “bisognava pagare i ragazzi” (cioè i concorrenti nel reato da lei chiamati ad agire con violenza e minacce nei confronti della persona offesa)» a prescindere dal fatto che «le modalità di soddisfacimento del preteso diritto erano travalicate in forme di particolare violenza, sistematicità e pervicacia», pure valorizzato, in realtà risultava preliminare il rilievo che l’agente ed i terzi incaricati della riscossione avevano perseguito (anche) la soddisfazione di una pretesa giudizialmente non azionabile.
Nella fattispecie esaminata da Sez. 2, n. 44657 del 08/10/2015, gli imputati avevano posto in essere condotte violente e minacciose nei confronti delle diverse persone offese – per lo più soggetti in situazione di grave crisi finanziaria – finalizzate non solo al recupero di crediti originari ma anche al perseguimento di un autonomo profitto rappresentato dall’acquisizione della percentuale concordata come “tangente” per la riscossione delle somme e quindi per la soddisfazione di una pretesa giudizialmente non azionabile.
Nella fattispecie esaminata dalla già citata Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, alla p.o., sottoposta ad una serie continua di gravi minacce da parte di più persone, singolarmente e in gruppo, «fu poi intimato di firmare cambiali in bianco (che effettivamente in seguito firmò a decine sul cruscotto di un’autovettura nei pressi dello stadio di C. di P.) e venne anche prospettata (..) la possibilità di lavorare, unitamente ai fratelli, presso un’azienda della zona, onde guadagnare le somme necessarie a ripianare l’esposizione debitoria (prospettiva imposta con la forza dell’intimidazione, e non quale espressione sintomatica di una libera scelta lavorativa)»: i soggetti agenti avevano, quindi, perseguito la soddisfazione di una pretesa giudizialmente non azionabile, non essendo mossi dal ragionevole intento di trovare soddisfazione di un preteso diritto.
Nella fattispecie esaminata da Sez. 6, n. 17785 del 25/03/2015, i contratti preliminari rispetto ai quali, con le violenze accertate, si intendeva indurre le pp.oo. a far seguire la stipula un contratto di vendita di quota, «erano stati stipulati nel 1989, non dagli attuali soci della (…) s.r.l. ma dagli originari soci della stessa (…); occorreva, dunque, un formale conferimento della relativa posizione negoziale nella società e di tanto manca agli atti la prova si che, dal punto di vista documentale, come evidenziato dal Tribunale, la pretesa ancorata al citato preliminare risulta comunque riferibile a soggetti diversi dagli odierni indagati (…)»: i soggetti agenti perseguivano, quindi, la soddisfazione di una pretesa giudizialmente non azionabile.
Nella fattispecie esaminata da Sez. 2, 9759 del 10/02/2015, l’imputato, per riscuotere il suo credito, si era avvalso di due pregiudicati che avevano minacciato la persona offesa di dare alle fiamme il suo locale e di cagionare gravi lesioni a lui ed ai suoi familiari ove non avesse pagato il debito ed aveva quindi perseguito la soddisfazione di una pretesa giudizialmente non azionabile avendo agito anche in danno di terzi estranei al rapporto obbligatorio vantato.
Nella fattispecie esaminata da Sez. 5, n. 19230 del 03/05/2013, ricorreva, con riferimento ad entrambi i tentativi di estorsione contestati e ritenuti, la circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla I. n. 203 del 1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.), «in quanto le modalità della minaccia, la sua stessa indeterminatezza, l’intervento di persona formalmente estranea al rapporto tra S. e T., la vicinanza di P. a personaggi della famiglia F. (ovviamente la separazione legale di questo imputato dalla moglie di per sè non può essere circostanza significativa), la richiesta di versare Euro 15.000 a favore proprio della famiglia mafiosa del quartiere, sono tutte circostanze che militano, come correttamente hanno ritenuto i giudici di appello, nel senso della sussistenza dell’utilizzazione del metodo mafioso. E se, erroneamente, anche il secondo giudice ha escluso, con riferimento al primo episodio estorsivo, la sussistenza della predetta aggravante (e tale errore non può essere corretto in mancanza di una impugnazione sul punto della parte pubblica), non vi è ragione per la quale non si debba riconoscerne la sussistenza e la operatività con riferimento al secondo episodio estorsivo»: l’estrema invasività della forza intimidatoria esercitata costituiva, pertanto, indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di soddisfazione di una legittima pretesa civilistica.
Orbene, anche il riferimento, come criterio per distinguere i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni dall’estorsione, all’effetto “costrittivo” della condotta di estorsione, pur essendo stato in più occasioni enunciato, rilevavano le Sezioni, non era stato mai concretamente e decisivamente valorizzato poiché, in tutte le sentenze che lo avevano accolto, la pretesa azionata dal presunto creditore non sarebbe stata in realtà azionabile in giudizio: a) nel caso esaminato da Sez. 2, n. 36928 del 04/07/2018, il credito del quale si pretendeva soddisfazione non era esigibile, «tenuto conto dei vincoli imposti da Equitalia sui beni della vittima»; b) nel caso esaminato da Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016, il terzo incaricato della riscossione aveva agito per la soddisfazione di un credito rispetto al quale era già stata esperita una infruttuosa azione esecutiva, e quindi — attraverso la condotta contestata – pretendeva inammissibilmente di aggredire le cc.dd. res sacra miseris; c) nel caso esaminato da Sez. 2, n. 55137 del 03/07/2018, attraverso la condotta contestata, il creditore aveva richiesto la corresponsione di interessi usurari, pretesa certamente non azionabile in giudizio.
Ciò posto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, le Sezioni Unite ritenevano possibile esaminare le connotazioni del concorso di persone nei reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione.
A tal proposito veniva osservato come la giurisprudenza della Cassazione abbia tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985); qualora il terzo agente – seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell’art. 393 stesso codice – inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013).
Orbene, per le Sezioni Unite, questo orientamento doveva essere condiviso e ribadito.
Due sono per la Suprema Corte, i punti di partenza di questa ulteriore disamina, necessariamente costituiti dai principi in precedenza affermati: I) il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo; II) il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico.
Di conseguenza, se, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante, sempre ad avviso del Supremo Consesso, il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio.
Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione mentre, in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l’interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Detto questo, non appariva inopportuno per il Supremo Consesso precisare che, di conseguenza, nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della c.d. “finalità mafiosa” [art. 416-bis.1 cod. pen.: essere “i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi (…) al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste” dall’art. 416-bis cod. pen.], la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale), rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell’art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalità (anche soltanto latu sensu) di profitto di terzi tenuto conto altresì del fatto di come la Cassazione avesse già chiarito che non è configurabile il reato di ragion fattasi, bensì quello di estorsione (in concorso con quello di partecipazione ad associazione per delinquere), allorché si sia in presenza di una organizzazione specializzata in realizzazione di crediti per conto altrui la quale operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicatile come debitori (Sez. 2, n. 1556 del 01/04/1992; Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006).
Le Sezioni Unite, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, pertanto, postulavano i seguenti principi di diritto: 1) «i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo»; 2) «il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie»; 3) «il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità».
Conclusioni
La decisione in esame è assai interessante in quanto in essa si fornisce risposta ai seguenti quesiti: qual è la natura dei reati di reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; cosa distingue l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone da quello di estorsione; come si configura il concorso nel delitto di cui all’art. 393 c.p..
Difatti, in tale pronuncia, le Sezioni Unite addivengano a pronunciare, come appena visto, i seguenti arresti giurisprudenziali: a) i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo; b) il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie; c) il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.
Tale pronuncia, quindi, deve essere presa nella dovuta considerazione ogniqualvolta venga in rilievo una di tali questione giuridiche.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in siffatto provvedimento, proprio perché fa chiarezza su tali tematiche legali, dunque, non può che essere positivo.
Volume consigliato


















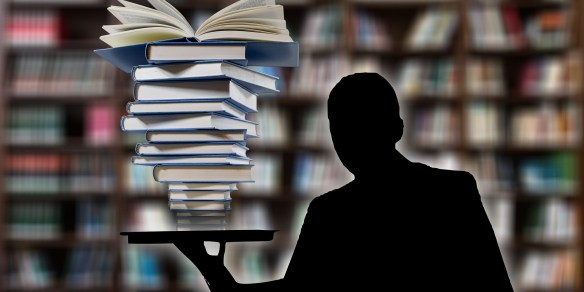


Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento