La Consulta dichiara non illegittimo costituzionalmente l’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, e quindi la pena minima di 24 anni non è “fissa” e resta applicabile: vediamo il perché. Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il caso Lecce: condanna e appello sul reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990
- 2. La questione di costituzionalità: pena “fissa” e violazione degli artt. 3 e 27 Cost.
- 3. La decisione della Consulta: nessuna pena fissa, ma minimo edittale e cornice elastica
- 4. Conclusioni: inammissibilità delle questioni e conferma della disciplina sanzionatoria
- Ti interessano questi contenuti?
1. Il caso Lecce: condanna e appello sul reato associativo ex art. 74 DPR 309/1990
La Corte di Appello di Lecce, sezione unica penale, doveva decidere in merito ad un appello proposto avverso una sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Lecce, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato alla pena di venti anni di reclusione per i reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4, e 73 del menzionato d.P.R. n. 309 del 1990. Per approfondire ulteriormente il tema della legislazione in materia di stupefacenti, consigliamo il volume Stupefacenti – Manuale pratico operativo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
2. La questione di costituzionalità: pena “fissa” e violazione degli artt. 3 e 27 Cost.
Alla luce della situazione giudiziaria suesposta, la Corte territoriale summenzionata sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 74, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede per il “capo-promotore” di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero di associati superiore a dieci, «la pena fissa di 24 anni di reclusione».
In particolare, in punto di rilevanza delle questioni, il giudice a quo premetteva come l’appellante fosse stato condannato all’esito del giudizio abbreviato a una pena finale di venti anni di reclusione, alla cui determinazione il giudice di primo grado era pervenuto, partendo da una pena base, per il reato associativo di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 aggravato ai sensi dei commi 3 e 4, pari ad anni ventiquattro di reclusione, aumentata per la recidiva e per le aggravanti contestate a trentasei anni; pena contenuta, ai sensi dell’art. 78 del codice penale, in anni trenta e infine ridotta, per la scelta del rito, appunto a venti anni.
Le questioni sarebbero state dunque rilevanti, per il giudice rimettente, in quanto, «nell’eventualità del rigetto di tutti i motivi di gravame proposti dalla difesa», la Corte di Appello salentina «si troverebbe nella condizione di confermare anche il trattamento sanzionatorio comminato all’imputato dal GUP, dovendo fare applicazione della disposizione censurata senza possibilità di operare un’eventuale graduazione della pena rispetto al disvalore del fatto ed alla personalità dell’imputato».
Ciò posto, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo riteneva anzitutto che la norma di cui all’art. 74, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 contrasti con gli artt. 3 e 27 Cost., osservandosi, a tal proposito, che la disposizione censurata prevede «una pena che può qualificarsi come “fissa”, in quanto “non inferiore a ventiquattro anni di reclusione” [enfasi nell’originale], a fronte del limite massimo di tale pena detentiva stabilito, nell’art. 23 c.p., sempre in ventiquattro anni».
Ebbene, per la Corte territoriale salentina, tale trattamento sanzionatorio, in quanto rigido e non modulabile secondo i criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen., non sarebbe compatibile con i princìpi costituzionali di proporzionalità e necessaria individualizzazione della pena, richiamandosi in tal senso la giurisprudenza costituzionale in tema di sindacato sulla misura della pena, che, afferma il rimettente, nel riconoscere la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle comminatorie edittali per i fatti previsti come reati, afferma ch’essa incontra il proprio limite nella manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, limite che viene superato allorché le pene comminate appaiono manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto come reato atteso che in tal caso si realizzerebbe una violazione congiunta degli artt. 3 e 27 Cost., poiché una pena non proporzionata alla gravità del fatto e non percepita come tale dal condannato si risolverebbe in un ostacolo alla sua funzione rieducativa (vengono richiamate le sentenze di questa Corte n. 197 del 2023, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012, n. 341 del 1994 e n. 313 del 1990).
Del resto, con riferimento alle pene fisse il rimettente richiama i princìpi affermati dalla sentenza n. 50 del 1980 della Consulta, a tenor dei quali: «[l]’adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti – in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento – contribuisce da un lato, a rendere quanto più possibile “personale” la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile “finalizzata”, nella prospettiva dell’art. 27, terzo comma, Cost. Il principio d’uguaglianza trova in tal modo dei concreti punti di riferimento, in materia penale, nei presupposti e nei fini (e nel collegamento fra gli uni e gli altri) espressamente assegnati alla pena nello stesso sistema costituzionale. L’uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, “proporzione” della pena rispetto alle “personali” responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statuale».
D’altronde, nel medesimo senso venivano citate, nella giurisprudenza costituzionale, la sentenza n. 222 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle pene accessorie in materia di reati fallimentari previste nella misura fissa di dieci anni dall’art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), e la sentenza n. 112 del 2019, relativa alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), nella parte in cui assoggetta alla confisca per equivalente non soltanto il profitto dell’illecito, ma anche i mezzi impiegati per commetterlo.
Ebbene, in tale quadro interpretativo il rimettente richiamava i princìpi affermati dalla giurisprudenza costituzionale giusta i quali «[i]n linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono […] in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale; ed il dubbio d’illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato» (sentenza n. 50 del 1980). Ribadisce, dunque, che «se la “regola” è rappresentata dalla “discrezionalità”, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo “indiziata” di illegittimità; e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione, attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda “proporzionata” all’intera gamma dei comportamenti tipizzati» (sentenza n. 222 del 2018).
Il rimettente aggiungeva inoltre che la norma censurata sarebbe altresì in contrasto con l’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a tenor del quale «[l]e pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato» posto che la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che prevede «norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti», ribadisce il doveroso rispetto del principio di proporzione nella determinazione del trattamento sanzionatorio, da ritenersi non compatibile con la previsione di pene che siano fisse nel loro quantum.
Nel dettaglio, nel ricordarsi la giurisprudenza costituzionale formatasi anche a proposito della proporzione delle sanzioni amministrative di carattere “punitivo” (venivano richiamate le sentenze n. 185 del 2021 e n. 40 del 2023) e delle sanzioni disciplinari (era richiamata la sentenza n. 51 del 2024), l’ordinanza di rimessione stimava che «la pena rigida di ventiquattro anni di reclusione […] non può ritenersi “ragionevolmente proporzionata” rispetto all’intera gamma dei comportamenti riconducibili al tipo di reato, che si presta a ricomprendere fenomeni associativi dalle caratteristiche estremamente eterogenee e con ben diverso grado di pericolosità per i beni giuridici tutelati».
In primo luogo, perché non sarebbe possibile operare una diversificazione della risposta punitiva nella fattispecie di associazioni dedite al traffico di droghe “leggere”; inoltre, non sarebbe possibile differenziare il trattamento sanzionatorio in base ai requisiti, più o meno strutturati, dei sodalizi criminosi finalizzati al narcotraffico.
Tanto premesso, il rimettente sosteneva che «[l]’espunzione dal testo dell’art. 74 DPR 309/90 della circostanza aggravante di cui al comma 4° con riferimento alla posizione del “capo-promotore” consentirebbe al giudice di commisurare la pena nella forbice tra un minimo di venti anni (previsto dall’art. 74 comma 1°) ed un massimo di ventiquattro di reclusione (art. 23 c.p.) in presenza di un’associazione armata e con un numero di associati superiore a dieci, tenendo conto in particolare della vasta gamma di circostanze indicate nell’art. 133 c.p., così da commisurare la pena al caso concreto ed alla personalità dell’autore, avendo la possibilità di graduare la sanzione secondo i criteri di proporzionalità e di adeguatezza; in tal guisa la pena apparirebbe una risposta – oltre che non sproporzionata – il più possibile “individualizzata”, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato, “capo-promotore” del sodalizio, “in attuazione del mandato costituzionale di “personalità” della responsabilità penale di cui all’art. 27, primo comma, Cost.” (così sentenza n. 222 del 2018)», considerato che, tra l’altro, tale conclusione non avrebbe potuto essere revocata in dubbio dall’argomento che la cornice edittale prevista dalla disposizione censurata sarebbe comunque “neutralizzabile” in caso di equivalenza o prevalenza di eventuali circostanze attenuanti, essendo stato chiarito dalla giurisprudenza costituzionale che «l’applicazione di circostanze attenuanti è soltanto eventuale, e non è in grado pertanto di sanare il vulnus costituzionale insito nella comminatoria di una pena manifestamente eccessiva nel minimo» (veniva richiamata all’uopo la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2023 [recte: n. 63 del 2022].
Potrebbero interessarti anche:
3. La decisione della Consulta: nessuna pena fissa, ma minimo edittale e cornice elastica
La Corte costituzionale – dopo avere ripercorso le argomentazioni sostenute nell’ordinanza di rimessione e stimate non meritevoli di accoglimento le eccezioni sollevate dall’Avvocatura generale dello Stato – preliminarmente rilevava che la censura proposta con riferimento all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE doveva essere dichiarata inammissibile in quanto, oltre a non essere stata introdotta invocando (nemmeno nel solo dispositivo) il parametro interponente dell’art. 117, primo comma, Cost., risultava essere stata apoditticamente prospettata senza alcuna adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni di violazione del parametro evocato dato che, fra le molte, dalla sentenza n. 135 del 2023, per giurisprudenza costante della Consulta, «deve ritenersi “inammissibile la questione di legittimità costituzionale posta senza un’adeguata ed autonoma illustrazione, da parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro evocato” (sentenza n. 252 del 2021 e, da ultimo, sentenze n. 2 del 2023, n. 263, n. 256, n. 253 e n. 128 del 2022)».
Ciò posto, era invece rilevato d’ufficio un diverso e assorbente profilo di inammissibilità delle questioni, consistente nell’erroneità del presupposto interpretativo, determinata anche da un’incompleta ricostruzione del quadro normativo.
Invero, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, cui consegua un difetto dell’itinerario motivazionale dell’ordinanza di rimessione determina l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, potendo essa incidere sia sulla rilevanza che sulla non manifesta infondatezza delle medesime, precludendone quindi lo scrutinio nel merito (ex plurimis, sentenze n. 81 del 2022, n. 201, n. 61 e n. 15 del 2021, n. 264, n. 213 del 2020 e n. 27 del 2015; ordinanze n. 229 del 2020, n. 162 del 2019 e n. 244 del 2017), essendo stato più volte ribadito al riguardo che «l’incompleta ricostruzione della cornice legislativa e giurisprudenziale di riferimento rende inammissibili le questioni sollevate solo se compromette irrimediabilmente l’iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sulla rilevanza, sia sulla non manifesta infondatezza (ex multis, sentenze n. 61 del 2021, n. 136 del 2020, n. 150 del 2019 e n. 27 del 2015; ordinanze n. 108 del 2020, n. 136 e n. 30 del 2018 e n. 88 del 2017)» (sentenza n. 194 del 2021).
L’ordinanza introduttiva del presente giudizio, dunque, per la Corte, appariva essere caratterizzata proprio da questo difetto di ricostruzione del quadro normativo, nel senso che il verso delle censure era orientato dal presupposto dell’asserita natura di «pena fissa» della reclusione «non inferiore a ventiquattro anni», che – considerati i princìpi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale – ne determinerebbe l’illegittimità.
Orbene, per il Giudice delle leggi, tale presupposto era però fallace, osservandosi preliminarmente a tal riguardo che per il reato associativo commesso da chi riveste un ruolo apicale, di cui all’art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, è prevista la pena della «reclusione non inferiore a venti anni». È qui stabilito, dunque, soltanto il minimo edittale, sicché, ai sensi della norma generale di cui all’art. 23 cod. pen., la pena della reclusione può essere in tal caso determinata tra un minimo di venti anni e un massimo di ventiquattro anni. La pena prevista per la fattispecie-base, pertanto, non è fissa, così come, analogamente, il comma 4 dello stesso art. 74, oggetto specifico delle censure del rimettente, contempla, per il soggetto che abbia un ruolo apicale nella commissione del reato associativo pluriaggravato dal numero di associati (comma 3) e dalla disponibilità di armi (comma 4), una pena che «non può essere inferiore a ventiquattro anni» di reclusione.
Questa previsione, del resto, che disciplina il trattamento sanzionatorio di una fattispecie aggravante, va a sua volta letta alla luce della norma generale dell’art. 64, primo comma, cod. pen. relativa all’ipotesi del riconoscimento di una sola circostanza aggravante, a tenor della quale, «[q]uando ricorre una circostanza aggravante, e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso», in guisa tale che, così disponendo, l’art. 64 cod. pen. fa sì che, qualora l’aumento di pena per una circostanza aggravante non sia determinato espressamente dalla legge (come invece accade nella fattispecie qui scrutinata, quanto all’aumento del minimo), possa essere disposto un aumento fino a un terzo.
Oltre a ciò, si stimava altresì necessario sottolineare che il generale criterio moderatore previsto dall’art. 66 cod. pen., nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, stabilisce che l’aumento non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato-base, e comunque la pena di anni trenta se si tratta di reclusione, apparendo tale inquadramento generale utile a evidenziare la duplice forma di incidenza delle circostanze sulla pena: per aumento o diminuzione predeterminati a livello edittale dal legislatore (in misura fissa o con l’indicazione di un limite minimo e/o di un limite massimo); per aumento o diminuzione frazionari (che il giudice deve operare sulla pena-base nel rispetto dei limiti massimi fissati dal codice).
Chiarito ciò, si osservava che il comma 4 dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, qui censurato, si limita a stabilire l’aumento minimo della pena (pari a quattro anni), senza incidere su quello massimo (pari a un terzo della pena edittale ai sensi dell’art. 64 cod. pen.), la cui misura ovviamente dipende dalla pena-base determinata in concreto dal giudice nell’ambito del compasso edittale (tra 20 e 24 anni di reclusione) risultante dal comma 1 dello stesso art. 74 e dalla norma generale di cui all’art. 23 cod. pen., in guisa tale che una forbice extra-edittale è comunque presente e, qualora la pena-base sia determinata nel massimo edittale di ventiquattro anni, l’aumento frazionario può giungere sino a trenta anni di reclusione (per effetto del criterio moderatore previsto dal codice).
Tanto premesso, se il rimettente invocava l’asserita natura di «pena fissa» della reclusione «non inferiore a ventiquattro anni» per sollecitare una declaratoria di illegittimità costituzionale che deriverebbe dai princìpi affermati in materia dalla Consulta, tuttavia, rilevava il Giudice delle leggi nella pronuncia qui in commento, anche in dottrina si è escluso che i casi di pena indicata soltanto nel minimo potessero inquadrarsi nella nozione di pena fissa dato che, se la fattispecie della “pena fissa” è integrata unicamente dai trattamenti sanzionatori del tutto anelastici, in cui la sovrapposizione fra l’astratta comminatoria edittale e la concreta irrogazione della pena è completa: in un simile caso il giudice non può procedere ad alcun adattamento, diversa, invece, è la fattispecie del trattamento sanzionatorio solo parzialmente anelastico, che si ha quando la pena non è compiutamente graduabile dal giudice sulla base degli ordinari criteri di commisurazione.
Così delimitato il campo, per la Corte, l’ipotesi della pena detentiva autenticamente fissa si rivela, almeno nel corpus codicistico, del tutto marginale, visto che i casi paradigmatici sono quello dell’ergastolo (che lo è logicamente, ma – come risulta dalla sentenza della Consulta n. 94 del 2023 – costituisce una pena illegittima solo quando è “indefettibile”) e quelli della pena della «reclusione di anni trenta» prevista per le ipotesi di delitti aggravati dall’evento del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, secondo comma, cod. pen., come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, recante «Norme penali e processuali per la prevenzione e repressione di gravi reati», convertito, con modificazioni, nella legge 18 maggio 1978, n. 191), a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis, secondo comma, cod. pen., come introdotto dall’art. 2 del d.l. n. 59 del 1978, come convertito) e a scopo di coazione (art. 289-ter, secondo comma, cod. pen., inserito dall’art. 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», ma già previsto dall’art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 718, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979»), da cui derivi la morte quale conseguenza non voluta.
Ciò posto, veniva oltre tutto precisato che, a partire dalla sentenza n. 50 del 1980, la Corte costituzionale ha affermato l’esistenza di un sospetto di illegittimità costituzionale delle pene fisse, entro un sindacato di costituzionalità calibrato non più soltanto sull’art. 27, primo e terzo comma, Cost., ma altresì sull’art. 3 Cost., così manifestandosi una propensione per la graduabilità del trattamento sanzionatorio quale strumento di adattamento della pena al concreto fatto-reato: «[i]n questi termini, sussiste di regola l’esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento individualizzato, “proporzionale”, delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono lo strumento normale. In linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale; ed il dubbio d’illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato» (sentenza n. 50 del 1980).
Ordunque, pur ribadendo la segnalata «tendenziale contrarietà delle pene fisse al “volto costituzionale” dell’illecito penale», la Consulta ha nondimeno chiarito come essa «debba intendersi riferita alle pene fisse nel loro complesso […] non ai trattamenti sanzionatori che coniughino articolazioni rigide e articolazioni elastiche, in maniera tale da lasciare comunque adeguati spazi alla discrezionalità del giudice» (ordinanza n. 91 del 2008, concernente l’aumento frazionario fisso di pena previsto dall’art. 99, primo, terzo e quarto comma, cod. pen. nel caso di recidiva reiterata), escludendo altresì dal perimetro delle pene fisse l’ipotesi delle pene pecuniarie «proporzionali», la cui eventuale illegittimità «non deriverebbe, però, dalla lamentata, ma insussistente, loro fissità strutturale; né si ricollegherebbe alla mancata previsione di un valore massimo; essa, semmai, potrebbe derivare dalla irragionevolezza o dalla sproporzione dei fattori da considerare nel computo della pena: del valore-base o dell’elemento moltiplicatore prescelti dal legislatore in relazione alla fattispecie di reato alla quale si devono applicare» (sentenza n. 142 del 2017), così come, analogamente, è stata esclusa l’illegittimità costituzionale dell’aumento di pena in misura fissa previsto dall’art. 590-ter cod. pen. («la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni») per l’ipotesi dell’aggravante della fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche dato che la relativa questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non fondata anche in quanto il trattamento sanzionatorio doveva considerarsi proporzionato, tenuto conto del disvalore delle condotte oggetto di previsione e della possibilità di applicare le circostanze attenuanti, che rendeva “non assoluta” la fissità della pena (sentenza n. 195 del 2023).
Al contrario, per i giudici di legittimità costituzionale, in coerenza con i princìpi già affermati dalla citata sentenza n. 50 del 1980, la Corte costituzionale, ravvisando l’ipotesi di una vera e propria pena fissa, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle pene accessorie fallimentari previste dall’art. 216, ultimo comma, della legge fallimentare, che stabiliva una pena indefettibile di dieci anni, evidenziandosi al riguardo che, con la sentenza n. 222 del 2018 si è innanzitutto ribadito che «se la “regola” è rappresentata dalla “discrezionalità”, ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo “indiziata” di illegittimità; e tale indizio potrà essere smentito soltanto in seguito a un controllo strutturale della fattispecie di reato che viene in considerazione, attraverso la puntuale dimostrazione che la peculiare struttura della fattispecie la renda “proporzionata” all’intera gamma dei comportamenti tipizzati».
Ciò posto, sempre la Consulta ha anche affermato che «una durata fissa di dieci anni delle pene accessorie in questione non può ritenersi “ragionevolmente ‘proporzionata’ rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato”, in base al poc’anzi menzionato test enunciato dalla sentenza n. 50 del 1980. […] Una simile rigidità applicativa non può che generare la possibilità di risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso – e dunque in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. – rispetto ai fatti di bancarotta fraudolenta meno gravi; e appare dunque distonica rispetto al menzionato principio dell’individualizzazione del trattamento sanzionatorio».
Orbene, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, la Corte costituzionale stimava opportuno precisare, a questo punto della disamina, che, mentre la “pena fissa” è oggetto di una presunzione, sia pur solo relativa, di illegittimità costituzionale, una pena come quella qui in considerazione, caratterizzata non dalla fissità, ma da un profilo di pur evidente irrigidimento, è soggetta all’ordinario sindacato di costituzionalità sulla dosimetria della pena, la norma censurata nel caso di specie non contempla una “pena fissa”, ma una pena identificata solo nel minimo, nel senso che determina un aumento fisso del solo minimo edittale nel caso di concorso di circostanze aggravanti (in tal senso si è pronunciata altresì la Corte di Cassazione, Sesta sezione penale, sentenza 18 febbraio-21 marzo 2025, n. 11494, dichiarando manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale della medesima norma oggetto di scrutinio in questa sede) poiché essa si limita a stabilire l’aumento minimo della pena (pari a quattro anni), senza incidere su quello massimo (pari a un terzo della pena edittale), in tal modo salvaguardando una forbice extra-edittale che lascia comunque aperto un non trascurabile compasso, idoneo a consentire una sufficiente elasticità nella commisurazione giudiziale della pena, nei termini sopra indicati.
Oltre a ciò, era inoltre considerato che, venendo in rilievo il trattamento sanzionatorio previsto per una fattispecie circostanziale, la pena di ventiquattro anni di reclusione è costruita dal legislatore come risultato del possibile aumento dovuto al riconoscimento di due aggravanti: effetto che, in concreto, ben potrebbe essere eliso dal concorso di una o più circostanze attenuanti.
Tal che se ne faceva discendere che i princìpi invocati dal rimettente mediante il richiamo alla giurisprudenza costituzionale sulle “pene fisse” non apparivano essere pertinenti alla disciplina censurata il che determinava, come ulteriore conseguenza, che le questioni suesposte dovessero essere dichiarate inammissibili per erroneità del presupposto interpretativo.
4. Conclusioni: inammissibilità delle questioni e conferma della disciplina sanzionatoria
Fermo restando che l’art. 74 del d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, dispone, da un lato, che, quando “tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni” (comma primo), dall’altro, che, se “l’associazione e’ armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo’ essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione” (comma quarto, primo periodo), con la pronuncia qui in commento, tali previsioni di legge sono stati ritenute conformi alla Costituzione (e segnatamente in riferimento agli artt. 3 e 27 della Cost.) nella parte in cui si prevede per il “capo-promotore” di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero di associati superiore a dieci, «la pena fissa di 24 anni di reclusione».
Di conseguenza, alla luce di quanto disposto in codesta sentenza, per colui che riveste il ruolo di capo-promotore di un’associazione criminale di questo genere, in presenza di siffatte aggravanti, rimane legittima l’applicazione della pena fissa pari a ventiquattro anni di reclusione.
Questa è dunque in sostanza la novità, o meglio la conferma, che connota il provvedimento qui in commento.
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!

















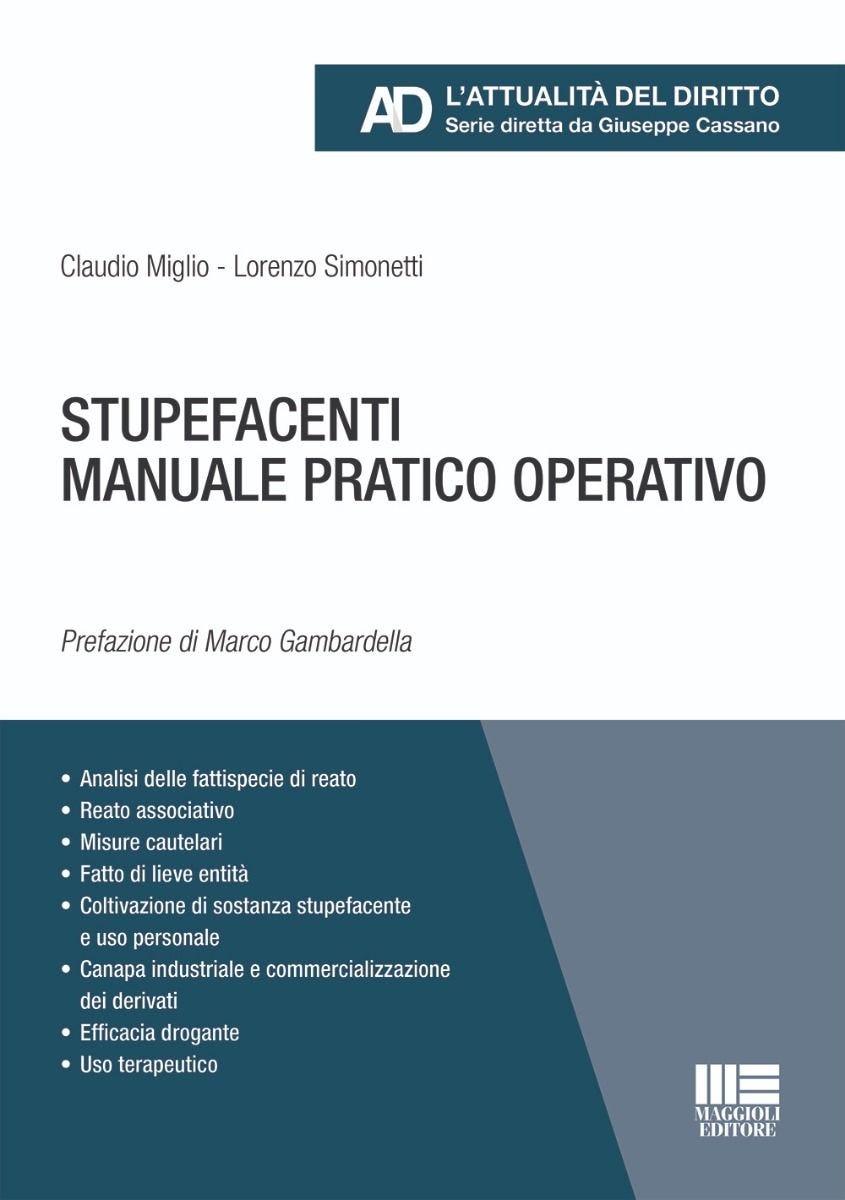






Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento